Riflessioni di un formatore / Tempo presente: dormirci su
Qualche anno fa Maria Cristina Koch, psicoterapeuta, epistemologa, adorabile maestra, nel suo saggio Dentro una locanda. La terapia come sosta, parlava della psicoterapia, appunto, in questi termini. Oggi, in piena emergenza, ben al di là della contingenza virale, come approccio positivo a prescindere, ma spesso disatteso, dovremmo poter immaginare una sosta alla locanda come parte integrante del nostro tempo operativo. Per ricaricarsi, riposare, dare tempo al nostro cervello di ossigenarsi, elaborare, produrre adeguatamente. Oggi le locande sono chiuse, aperte solo per asporto, ma potremmo portare altrove il loro spirito, perché sosta non significa stare fermi; semmai significa non percorrere sempre gli stessi sentieri, provare a infilarsi in qualche stradello laterale dove trovare diversità e conseguente stupore.
Il periodo che stiamo attraversando in realtà ci attraversa.
Come il virus, ci contagiano e ci attraversano la paura, la solitudine, l’incertezza, la preoccupazione, la fatica che si autoalimenta perché difficilmente possiamo dichiararla a cuor leggero, se non tra persone amiche, sommessamente. Un po’ forse perché “il nostro piangere fa male al re”; e poi perché comunque possano andare le cose è sempre richiesto il sorriso. Il sorriso è un obbligo, come non invecchiare, non ammalarsi, non morire. Non possiamo rischiare di angosciare gli altri con le nostre ansie o le nostre difficoltà. Esattamente come ci raccontava Primo Levi molti anni fa a proposito dei sopravvissuti ai campi di sterminio che desiderosi, e alla lettera bisognosi, di raccontare ciò che avevano vissuto subivano il fastidio dei familiari, a loro volta altrettanto bisognosi di voltare pagina e dimenticare l’orrore. Qualcuno oggi lo chiamerebbe pensare positivo, ma in realtà andrebbe definito ‘stato di negazione’. Niente a che fare con la positività di chi cerca di cambiare il mondo riconoscendone i drammi e parlandone apertamente, per quanto la parola possa essere dolorosa, cercando di trovare accoglienza e ascolto per questo, come sarebbe giusto.
I disagi provati e negati, in questo momento sono uno spartiacque. Prolungati oltre una certa soglia di tempo e intensità, cambiano le nostre vite, il nostro sentire, le nostre relazioni. È una questione fisiologica: una ferita leggera in un tempo breve può non lasciare segno o essere curata, una protratta nel tempo, invece, può lasciare tracce irreversibili. Cambiano, comunque, le relazioni. Qualcosa di incontrollabile e spesso non contrastabile in un dato momento (un virus e la sua gestione sanitaria e politica, per ora) arriva nelle nostre vite e trasforma il nostro sentire, la forma delle nostre paure, le sensazioni che abbiamo del tempo, degli altri, delle stagioni, del lavoro; cambia il senso profondo della vita che avevamo sedimentato quotidianamente, spesso con leggerezza, inconsapevolmente convinti di essere proprietari della nostra esistenza. Ora, dopo un anno e più di confusione, speranze, morti vere e uccisioni simboliche, il tasso di tristezza si diffonde.
Con un incerto tentativo di sorriso, malgrado tutto, cerchiamo di farci forza e di continuare come se in fondo tutto non fosse così grave. E rimaniamo incagliati tra la speranza di tornare alla casella di partenza con una bella iniezione vaccinale e tecnologica e quel non so che di incertezza che i nostri sensi registrano a contatto con un caldo “anomalo”, una pioggia che “non si era mai vista” e altre “amenità” naturali; o sociali, dato che in molti già oggi, forse noi stessi domani, non sappiamo se e come riusciremo a mantenerci economicamente, se potremo avere ancora una stanza tutta per noi.
Un modo sano di affrontare la realtà è affrontarla. Nominarla con parole adeguate, meditate e modificabili. Parole nette, ma flessibili, capaci di accettare l’evidenza, ma aperte al dubbio. Fare questo significa, soprattutto per noi adulti, dedicare tempo alla sosta.
Il nostro cervello è sempre acceso anche quando dormiamo. Talvolta però si impiglia, si ripete, ostinato come un moscone che cerca di uscire dalla finestra sbattendo più volte contro il vetro che non vede.
Quando ci capita di non riuscire a eseguire un compito, generalmente, ci si incaponisce fino allo sfinimento. Sarà successo a tutti di avere a che fare con un esercizio, un problema fisico o intellettuale da imparare o risolvere e che non ci riesce; un problema di matematica, un arpeggio con la chitarra, un movimento sportivo. Quando ero piccolo e a ottobre faceva freddo e le castagne sul fuoco erano in armonia con la temperatura della stagione, mi capitava di dover imparare una poesia a memoria. Ricordo la fatica che provavo con mia madre che all’altro capo del tavolo di cucina mi suggeriva le parole che entravano nelle mie orecchie, ma poi non volevano uscire dalla bocca nella fila giusta. Andavo a letto preoccupato del giudizio della maestra, mentre mia madre mi diceva una frase che con il senno di poi diventava quasi formula sciamanica: “non ti preoccupare, ora fai una bella dormita e vedrai che domani quando ti alzi fresco e riposato la poesia te la ricordi tutta”. Il mattino dopo, mentre mi vestivo, alla richiesta di mia madre, rimanevo incantato nel sentire srotolare le parole senza che io sapessi di saperle.
Di fronte a un problema che non sappiamo risolvere, può essere la cosa giusta “dormirci su”.
Come succede nel romanzo di Umberto Eco Il nome della rosa, quando il francescano Guglielmo da Baskerville, nel mezzo dell’ennesimo crimine e a rischio della propria vita per la presenza sanguinosa dell’Inquisizione nel monastero dove si svolgono i fatti, manda nel panico il suo giovane assistente Adso da Melk, dichiarando che non riesce più a ragionare e ha bisogno di dormire un po’. Per poi, una volta sveglio, comprendere e scoprire le cause, il senso e i responsabili della sequenza di morti avvenuta ricomponendo quasi magicamente le informazioni, le percezioni, le idee assimilate.
Una ‘dormita’, però, non significa per forza dormire. Sono anche due ore passate a giocare a calcetto, una passeggiata, un libro, un film, del sesso sano e bello, chiudere il computer per due giorni, uno shopping divertente. Ecco che dopo aver dedicato tempo in un qualsiasi altrove rispetto al compito che ci assedia, magicamente la cosa si risolve. L’esercizio di matematica ci torna; le mani sulle corde e la tastiera scivolano più sicure; il movimento sportivo è migliorato. Segno che la “locanda” non è stata un peccaminoso momento improduttivo. Non per nulla la parola ‘scuola’ viene dal greco scholé, che significa riposo, ma non implica essere inerti, come sappiamo bene alla fine di una vacanza, riposante proprio perché facciamo molto di diverso dall’ordinario “stancandoci” forse più del solito.
Il cervello funziona a nostra insaputa. Non siamo mai consapevoli di come pensiamo e prendiamo le decisioni. Per questo a volte lo maltrattiamo (si auto maltratta) impegnandolo in modi inutili, forzandolo in modo da renderlo inefficiente.
Un cervello che fa ripetutamente le stesse cose, sempre in emergenza e preoccupato di produrre al massimo e non sbagliare mai finisce nel comparto degli automatismi. Una specie di algoritmo che non ascolta, si impoverisce ed impoverisce gli altri. È anche una questione di sentieri che si creano tra le sue “località”. Le connessioni neuronali tra le sue parti sarebbero infinite, ma se sono sempre le stesse ad attivarsi, presto o tardi si diventa inadeguati. Come suonare sempre la stessa musica: magari è bella, eseguita con maestria, senza più nessun errore di esecuzione, ma adeguata in un matrimonio, non lo sarà per un funerale. E alla lunga non lo sarà nemmeno per i matrimoni che non sono tutti uguali e cambiano nel tempo.
Perché le solite immutate connessioni neuronali rimangano adeguate nel tempo ci sarebbe bisogno di un mondo statico. Il mondo, invece, è un caleidoscopio di diversità e, in più, cambia. Invece, affrontiamo questa crisi epocale con gli stessi sentieri neuronali che ci hanno permesso di percepire come stabile un mondo cangiante, di addomesticarlo e renderlo compatibile con i nostri legittimi bisogni di sicurezza; con la nostra immensa zona di confort, destinata però a dissolversi come una casa di cemento armato di fronte a uno tsunami se guardiamo soddisfatti alla sua struttura e non all’onda che si profila all’orizzonte.
Einstein diceva che non si possono risolvere i problemi con gli stessi criteri che li hanno prodotti. Purtroppo, invece, in molti ambiti facciamo esattamente il contrario. Inerzia e abitudini consolidate continuano a lavorare senza sosta insieme alla paura che ormai è diventata la base del nostro agire, spesso a dispetto dei dati di realtà.
Inerzia e abitudini, però, non sono una colpa. Aver paura e continuare con le abitudini che ci rassicurano non è una colpa. Nessuno di noi è colpevole di desiderare un mondo stabile, rassicurante, sicuro. Soprattutto quando non lo è affatto. Siamo responsabili, però, quando continuiamo a ripercorrere la stessa strada che non porta dove vorremmo. Una volta compreso che le solite connessioni cerebrali non sono adeguate, abbiamo l’obbligo e la responsabilità di crearne altre tornando a muoverci. Oggi intuiamo abbastanza per poter affermare, pur con la legittima speranza di sbagliarci, che non sembra possibile ritornare ai bei tempi che furono. Anche se i bei tempi non erano così belli e le crepe nell’edificio erano già evidenti a molti di noi. I tempi che saranno, probabilmente, non dipenderanno totalmente da noi, ma non sarebbe etico e responsabile rinunciare all’impegno di migliorare le nostre vite, soprattutto a partire dalle piccole cose che realmente siamo già in grado di modificare.
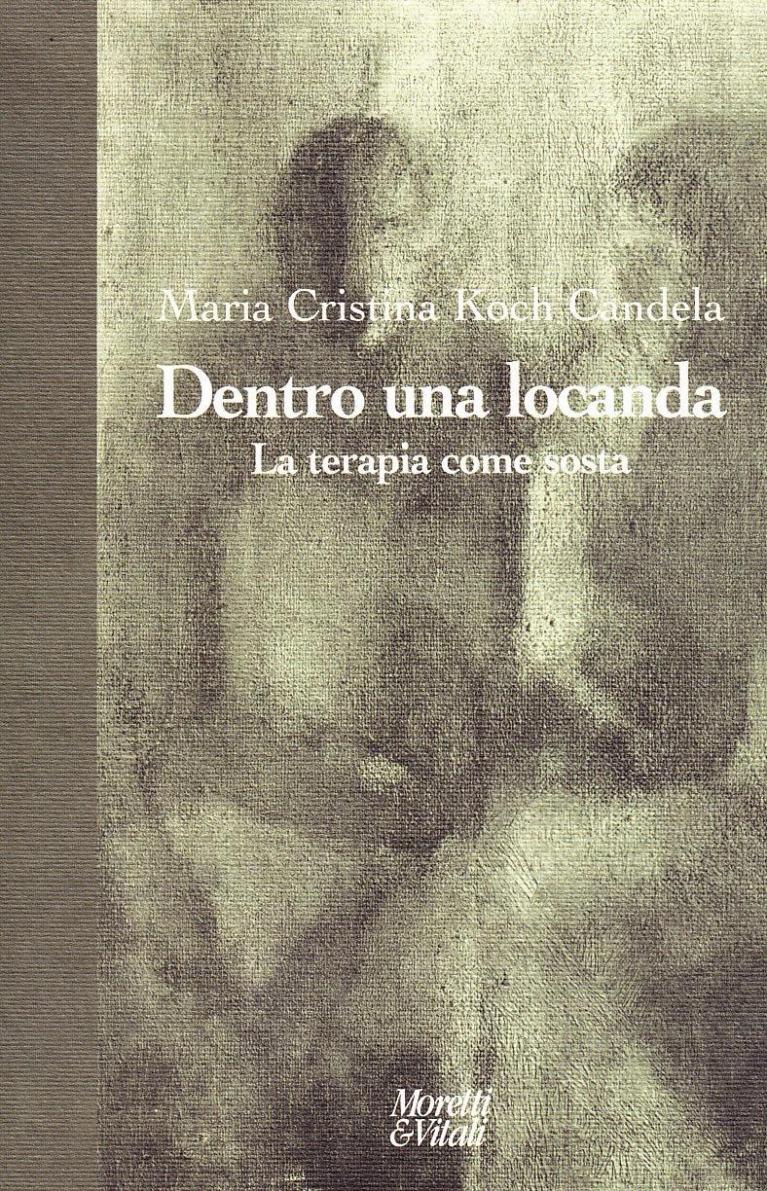
Soprattutto non sarebbe vitale.
Noi esseri umani siamo abili a impiegare anni per fare cose che si potrebbero realizzare in un mese e a pretendere rapidità per trasformazioni che richiedono anni. Questo perché spesso vorremmo un cambiamento che non ci cambi. Perché cambiare, a dispetto di tutta la retorica dell’innovazione spacciata come un bene assoluto, è una grandissima fatica. E poi, diciamolo, ci sono anche cambiamenti pessimi che non vorremmo subire a causa di rapporti di forza a noi sfavorevoli. Il cambiamento vero però, quello generativo che comporta un’inevitabile sequenza di spiazzamento, fatica e successiva gioia, non è tale se pretendiamo di rimanere intatti. Quando si parla di cambiamento dovremmo prevedere e accettare il fatto che non rimarremo intatti come individui e collettività e che questo ci destabilizzerà. E dobbiamo sapere che alcuni di noi non ne vorranno proprio sapere, costi quel che costi. E che costoro andranno rispettati, ma lasciati al loro destino perché sottrattori di energie vive.
Indipendentemente dai ruoli ricoperti, allora, anche se con gradi diversi a quelli dovuti, abbiamo tutte/i più d’una responsabilità. È una fatica enorme, ma potrebbe essere entusiasmante. Se rendessimo entusiasmante la responsabilità, questa sarebbe meno faticosa. Ma la fatica resterebbe comunque e allora tanto vale provare a scegliere quella più generativa.
Ogni volta che impediamo e ci impediamo di uscire da schemi obsoleti per paura, carrierismo, volontà di dominio, hybris; oppure per difenderci dalla paura di essere giudicati, dimentichi di quanto giudichiamo a nostra volta, ci assumiamo la responsabilità di imporre l’idea che il presente non sia modificabile e quindi non si abbia diritto di pensare un futuro. Non si può pensare al futuro se ci impediamo, se ci impediscono, se ci convinciamo che il presente non è modificabile. Un presente pensato come non modificabile è un futuro non immaginabile.
Inoltre, questo presente “immodificabile” ha bisogno quasi esclusivamente di guardiani e collaboratori di guardiani. Un’altra fatica enorme, anche per chi fa la guardia, persone che generalmente non vivono bene e non sono esempi di vitalità e felicità da imitare.
Individualmente e collettivamente, “immodificabile” significa depressione.
La depressione è l’impossibilità, vera o presunta, ma interiorizzata, di vivere e cambiare. La depressione è stasi e morte, perché la morte è l’annullamento della vita, cioè blocco del cambiamento e fine del movimento.
L’immobilità, in qualsiasi organizzazione, è l’immobilismo che paradossalmente vede la locanda come una perdita di tempo.
Spesso non abbiamo davvero tempo per fermarci alla locanda dove immaginare, non da soli, un mondo che sta cambiando a dispetto o a causa dell’inerzia degli strumenti concettuali e fisici che continuiamo a usare perché in essi ci siamo identificati.
Non avere tempo però è una scelta. Se la barca affonda, non possiamo dire che non c’è tempo per riparare il buco nello scafo, continuando nella routine di sempre. Possiamo però ignorare il problema o convincerci che la barca non stia affondando. Questo è lo stato di negazione. Per intendersi: si sta meglio a tirar fuori l’acqua dallo scafo con un secchio riconoscendo che siamo in pericolo, piuttosto che negarlo. Si sta meglio a combattere l’Isis con il fucile guardandolo in faccia come hanno fatto le donne kurde in Rojava, piuttosto che scappare o nascondersi in attesa della inevitabile violenza. Si tratta di scegliere il rischio che ci fa vivere meglio, piuttosto che la follia del rischio zero, totalmente illusoria.
Ognuno di noi, tra coloro che lavorano, è immerso in ambienti professionali che da un lato aiutano a contenere l’ansia, essendo il lavoro con i suoi schemi organizzativi un modo per fare ordine e tenerla sotto controllo; dall’altro possono acuirla perché celata e compressa sotto la coltre dell’impegno, dell’efficienza e della produttività che rendono impossibile la sosta.
Un famoso studioso delle organizzazioni diceva ironicamente che le imprese esistono per tirare via gli adulti dalla strada. Oggi abbiamo bisogno di ritornare letteralmente per strada perché lì si svolge e si svolgerà la vita. Abbiamo bisogno di non rimanere isolati, e non solo nelle nostre case. Al netto delle emergenze, della fatica, dell’impegno motivato, solidale e responsabile che caratterizza molte nostre organizzazioni, alcuni atteggiamenti efficientisti sanno di negazione della realtà e sembrano essere sintomi del disagio che viviamo noi adulti. La verità è che abbiamo tutti paura, ma non possiamo quasi mai nominarla, condividerla, dedicarle attenzione. Anche chi governa ha paura. Dobbiamo saperlo, non per giustificare errori letteralmente mortali che prima o poi si spera saranno giudicati e puniti, ma per essere consapevoli che anche quando toccasse a noi governare, in qualsiasi contesto organizzato, avremo da fare i conti con la paura e decidere se negarla o nominarla. Nel primo caso imprigionati in trappole, parole, stili che ci sembrano naturali perché si ripetono come il volo del moscone sul vetro della finestra, nel secondo con qualche grado di libertà in più. Queste trappole sono conseguenza delle nostre azioni e pensieri e ci comprimono e affondano quanto più ci agitiamo pensando di liberarcene ignorandole oppure utilizzando la forza, la guerra, in una ormai ridicola caricatura della virilità assunta come modello anche da una parte del mondo femminile.
Non so se sia esattamente così, ma anche se inventata la suggestione non perderebbe forza: mi colpì molto un esempio ascoltato da un biologo sul fatto che se in un acquario si inserisce un divisorio, i pesci sono costretti a una diversa ripartizione del loro territorio. Poi, dopo un po’ di tempo, se si toglie, ci si potrebbe aspettare che le cose ritornino come prima con tutto quello spazio di nuovo a disposizione. Invece no. I nuovi confini sono diventati cristallizzati come muri e uno sconfinamento significa battaglia. Si dirà, non siamo mica banali come i pesci, noi esseri umani…
Invece, abbiamo bisogno di trovare un modo per non fare come i pesci nell’acquario dopo che un “divisore” si sia insinuato nelle nostre vite. Dobbiamo poter immaginare di poter di nuovo “uscire per strada”, anche se da più di un anno le strade sono più o meno inagibili.
Noi viviamo e operiamo nello spazio e nel tempo. Per questo, tra l’altro, orari e spazi di lavoro sono temi così densi di energie dedicate, contrattazioni, norme. Ora, in questo momento, molti spazi sono preclusi e inaccessibili e quando fruibili comunque difficoltosi, impervi, perché sempre più marcati e vincolanti.
Lo spazio è per definizione sempre vincolante, ma può essere architettato, o possiamo architettarlo, a nostra misura. Se però una stanza, un ufficio, un’aula che conterrebbe molti viene svuotata, allora i pochi che la abitano sentono costantemente che qualcosa non va: andare in bagno diventa fonte di preoccupazione; i pochi che incontriamo sono mascherati, come noi; il disinfettante mani che incroci ovunque (spazio) e costantemente (tempo) ti ricorda tuo malgrado che qualcosa non va. Puoi non farti travolgere, adattarti, ma sei fisicamente immerso in questi segni spaziali e temporali e loro ti attraversano. Come il cibo.
Come un cibo malsano ripetutamente assunto può farci ammalare, questi segni incidono sul nostro modo di pensare, di muoverci, di sentire, di stare insieme. Incidono sulla qualità della nostra solitudine, da quella vitale, rigenerante, a quella tossica, sconnessa dagli altri, privata di legami con la natura e con il pensiero.
Negli spazi covid vincolati, covid colorati, covid profumati, covid immaginati, consapevoli o meno, siamo sempre all’erta, ma essere sempre all’erta non fa bene. Una vita sempre all’erta è una vita priva di gioia, deprivata. Poi, ancora, gli altri segni indicatori della trama su cui cresce il disagio: evitarsi per strada e sui marciapiedi; le mascherine, un disturbo costante, come un acufene che non puoi eliminare e ti spazientisce; le strade vuote e la desolazione di alcuni esercizi chiusi; gli “assembramenti” pericolosi, ma inno alla vita; le file per comprare qualcosa; gli ospedali insicuri dove non si va per paura o perché non ti curano più, o dove si va al primo sintomo, dopo che i media ti hanno terrorizzato.
Poi c’è l’enorme abuso di parole guerriere fino ad arrivare a parlare di coprifuoco. Siamo una società perennemente in guerra contro qualcosa o qualcuno. Pensiamo soprattutto in modo bellico e competitivo, mi spiace dirlo, spesso indipendentemente dal genere.
E poi i segni che fanno la differenza: i luoghi dello spettacolo e della cultura, i luoghi dell’intrattenimento serrati, allucchettati, resi inaccessibili perché visti con sospetto. Non da ora, certo, ma adesso con massima evidenza: cultura e piacere non vanno bene (con la scusa) di questi tempi. Va bene invece, tutto ciò che è considerato produttivo. Come se la cultura, il tempo libero, il piacere fossero cose eteree, prive di professionalità, di economia; come se la locanda non prevedesse osti e ostesse, cibo e servizi, ma solo avventori in panciolle. I luoghi della socialità culturale considerati un peccato né più e né meno come durante le epidemie del passato, quando gli assembramenti concessi erano solo quelli della processione e delle messe per farsi perdonare i peccati commessi.
E poi, tra i segni della sofferenza, questa apparente accondiscendenza, questa mancanza di azione, questa obbedienza che ci mostra rassegnati. Fino a che non dovesse scoccare una scintilla. Ma non le scintille che portano alla rivolta che non cambia nulla. Quelle belle che rendono la notte di giugno incantata dall’intermittenza delle lucciole.
E a ben vedere, di scintille positive, di persone che resistono creando ce ne sono molte. Per incontrarle, allearci e riprendere fiducia dobbiamo uscire per strada e frequentare i vicoli, le stradelle nascoste, quelle che abbiamo a portata di gambe, ma che ci sfuggono e ci sono sfuggite impegnati come eravamo a percorrere sempre gli stessi sentieri. Per vederle, viverle e farci di nuovo amicizia basta seguire il bellissimo suggerimento di Stephen Hawking che dalla sua sedia a rotelle diceva: ricordatevi di guardare le stelle, non i piedi.
Leggi anche









