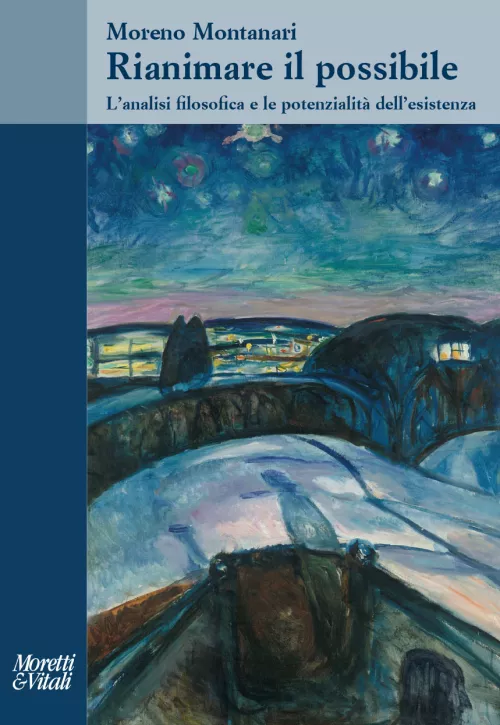Moreno Montanari All We Need Is Love
Rianimare il possibile. Titolo che, in questo nostro tempo disanimato ci invita a sperare, e domanda che ci poniamo quando ci troviamo di fronte alla sofferenza muta, e alle ferite che ci portano i pazienti nella stanza d’analisi. Moreno Montanari affronta il tema – Rianimare il possibile, Moretti&Vitali, 2024 – rivolgendosi nello stesso tempo al mondo e alla cura, e ci invita a guardare fuori dalla finestra oltre che allo specchio, come ci ha insegnato James Hillman. “La nostra epoca” – scrive l’autore – “vive uno strano paradosso: dichiara che tutto è possibile, ma nel contempo registra la parossistica esperienza di una potenza che, incapace di tradursi in atto, si converte nel suo contrario.” Questo – è sotto lo sguardo di tutti – genera una profonda stanchezza.
Come fare allora per evitare di portare “con me le ferite di tutte le battaglie che ho evitato”, come dice Bernardo Soares? Se è vero che la stanchezza è per le cose che non facciamo, qual è la strada per uscire da questo paradosso?
L’autore, attraverso quattro parole: autenticità, angoscia, riconoscimento, impotenza, scandaglia questo nostro mondo paralizzato nel quale le persone, i giovani soprattutto, sembrano bloccati, incapaci di compiere scelte. Un mondo attento al funzionamento a discapito dell’esistenza e della vita, angosciato dalla prestazione, nel quale la conoscenza non è un sapere vissuto – un conoscere che fa essere diversamente – e nel quale tutto sembra possibile.
Parole di cui abbiamo bisogno per trovare una strada, parole che si intrecciano e dialogano tra loro, e che vanno soprattutto vissute. Parole apri-pista.
Montanari, analista biografico a orientamento filosofico, ci invita a stare con le domande, ad accogliere l’angoscia che sale davanti al vuoto, a interrogarci su cosa s’intenda con vita autentica: postura della filosofia è sollevare domande, “una vita adeguatamente interrogata (…) è una vita amplificata: non aumentata, ma approfondita, illuminata, resa consapevole, dotata di senso e, conseguentemente liberata da quanto le impediva di sbocciare”. Pierre Hadot attribuiva alla filosofia un sapere che s’inscrive nell’ordine del Sé e non solo in quello della conoscenza.
Miguel Benasayag, citato più volte dall’autore, ci ricorda che il cervello aumentato genera un umano diminuito. Le macchine e la realtà aumentata vogliono risolvere velocemente i problemi, ma caratteristica dell’umano è farsi domande soprattutto per interrogarsi sul valore di qualcosa e per cercare un senso. Impresa ardua per questo nostro tempo che ha fretta di spiegazioni e non conosce l’attesa. Attesa che invece conosce bene, e abita, chi è terapeuta, perché, come ci ha insegnato Winnicott: “persino la spiegazione corretta è inutile. La persona che stiamo cercando di aiutare ha bisogno di una nuova esperienza” che passa per la relazione con l’analista, e la sua capacità di attendere. Questo può avvenire dentro un contenitore: quello di un’analisi più attenta alla relazione che ai contenuti, una postura femminile degli analisti, sia uomini che donne. Compito dell’analista è cercare di creare le condizioni favorevoli perché emergano le parti rimosse o non pensate, e la soluzione nasca dalla vita vissuta, senza risolversi in risposte frettolose. Nina Coltart, nella stessa direzione, ci ha parlato della bestia muta che arranca dentro di noi, del sintomo che scappa via e si rifugia nel corpo di fronte a interpretazioni e spiegazioni troppo precoci del terapeuta.
Il sapere che può salvare la vita, secondo Socrate, e che può curarla secondo Jung, è un sapere biografico. Questo, ricorda Montanari, è quello che avviene con l’amplificazione junghiana; ripetere le domande, declinarle, per abitare l’incanto e per attivare l’immaginazione: domande-semenza, non consapevoli. R.M. Rilke ci invita a stare con le domande e ad aspettare il momento in cui vivremo le domande, e scrive Delphine Horvilleur: “potremmo dunque dire così: dopo la morte ognuno di noi cade nella domanda e lascia gli altri senza risposta”.
In questo libro Montanari intreccia saperi differenti, in una continua spola tra filosofia e psicoanalisi, da cui emerge una tessitura ricca e profonda. Ci racconta di Sartre che afferma che siamo condannati a crearci, come esseri liberi – “solo noi possiamo essere l’essere che abbiamo da essere” –, e di Jung, che afferma che la vita è un esperimento a esito incerto – si va in scena senza copione – e mira alla realizzazione di quello che ha chiamato il processo di individuazione, realizzare la “nostra più intima, ultima, incomparabile e singolare peculiarità, diventare se stessi, attuare il proprio Sé”.
Per realizzare questo è necessario andare oltre il si fa di Heidegger: come ci si veste? Come ci si diverte? Questo è il tema che angoscia e imprigiona i nostri giovani oggi, e non solo loro.
Spaesati, faticano a vivere i loro corpi, sono altrove, hanno smarrito il proprio modo di esserci e di stare al mondo, la domanda sul senso del loro stare al mondo. L’assenza di vitalità è strettamente intrecciata alla perdita di contatto con la loro verità. L’adolescenza è oggi prigioniera di un “sii te stesso a modo mio”: la sfida per un adolescente oggi è quella tra essere fedele alle mille versioni di sé o aderire a chi si ostina a riconoscerne sempre e solo una.
Se come dice Jung, la nevrosi è il disperato tentativo di non misurarsi con la sofferenza reale dovuta al vivere, sostituendolo con una sofferenza inautentica apparentemente più gestibile, ma in realtà più ostica da affrontare, Montanari si domanda: a cosa sta portando la negazione della sofferenza nei giovani oggi? All’angoscia, che si sprigiona quando “viene a mancare la mancanza”. L’angoscia è la malattia di chi non ha imparato a fare i conti con il limite, che oggi è il vero rimosso. Maggiori sono le possibilità di scelta, più profonda è l’angoscia. La funzione preziosa dell’angoscia è quella di permetterci di misurarci con il ritorno del rimosso, di affrontare quello che non abbiamo potuto, e non avremmo saputo, affrontare nel passato. L’adulto, per accadere, deve lasciare il bambino, quel bambino che non poteva pensarsi senza madre: dare voce a quel bambino significa ricordare all’adulto che, ora, può affrontare quello che un tempo non poteva reggere. “Un ritorno più avanti”, avendo presente, come ci ricorda Nietzsche, che “quando la casa è costruita, bisogna togliere le impalcature”, perché le difese, che un tempo sono state d’aiuto, esaurita la loro funzione imprigionano. Come se tenessimo per sempre un gesso su una gamba che è stata rotta, ma non lo è più. Bisogna liberare le parti imprigionate dalle paure: il tesoro a cui fa sempre la guardia un drago.

Occorre tornare all’infanzia che non è solo ciò che siamo stati, ma anche ciò che dobbiamo continuamente riprendere. Si tratta allora di diventare bambini. L’infanzia è oggi, è una figura dell’adesso, come scrive Benjamin: riguarda noi adulti. Il passato è accaduto, l’infanzia è passata, ma custodisce un sapere che va risvegliato. Il bambino è la nostra origine che va verso il futuro e che può essere rimasta intrappolata, per questo va liberata e curata. Nei ricordi che affiorano, l’infanzia, come in un montaggio cinematografico, va costruita perché una nuova storia sia possibile. Forse proprio per questo il transfert e la relazione analitica sono un luogo della cura: permettono l’accesso a quel futuro interiore che, declinato in futuro anteriore, dà senso e direzione. L’immaginazione e lo sguardo paziente — la rêverie — accoglie, trasforma, consente il nuovo montaggio.
Montanari si domanda in che senso l’angoscia, che non vediamo, ci ri-guarda? Ciò che non si vede lo possiamo vedere – ce lo insegna la fisica – da come si comporta la materia intorno a un buco nero. Questo vale anche per la psiche e per i traumi. È fondamentale, e fondante, confrontarsi con l’angoscia che ci ri-guarda. Kierkegaard ha affermato che chi è capace di “sentire l’angoscia nel modo giusto, ha imparato la cosa più alta”. Anche Heidegger ha posto al centro della possibilità di una vita autentica la capacità di affrontare l’angoscia della morte. Le difese ci rivelano parti nascoste di noi, accedendo al cuore di materiali angoscianti che non possiamo guardare direttamente.
È necessario, dunque, partire dai limiti: quello che vivo come un ostacolo può rivelare invece qualcosa di me, la mia vera natura: un bastone, a seconda di dove lo pongo, può essere leva, bilancia o panchina.
Il limite d forma? Il limite trasforma la potenza in atto. Montanari ci ricorda la colomba di Kant: l’attrito che vorremmo far fuori è quello che rende possibile il volo. Il mondo contemporaneo vorrebbe far fuori l’attrito, e chiama questa libertà.
Ammettere di avere un limite è un buon esame di realtà, e porta alla vera autonomia e libertà. Montanari ci ricorda che volere non è potere, ma comprendere è potere, perché se la volontà vuole piegare l’ostacolo, “la conoscenza cerca invece di comprendere la relazione che li unisce, il rapporto tra noi e ciò che consideriamo un ostacolo; invita a provare a vedere le cose dal punto di vista dell’altro”.
Prezioso l’invito della psicoanalista americana Jessica Benjamin – che l’autore riprende – a sostituire la resa alla lotta: “non la resa all’altro, la sottomissione all’altrui volere e volontà – come accade al servo – bensì alla complessità della situazione”. Un concetto di resa interessante per questo nostro tempo complesso, perché si tratta di una resa figlia della comprensione che “se la realtà è intrinsecamente relazionale, la via della contrapposizione non può in alcun modo condurre al riconoscimento” (…) “un lasciarsi andare in cui la persona non si abbandona all’altro, ma semmai con l’altro. (…) lasciarsi andare a quello che si può essere con lui”. Il sé si comprende a partire dal tutto, è relazione. Benjamin parla di vulnerabilità comune – simmetrica vulnerabilità reciproca – a sottolineare che ognuno di noi è in qualche modo responsabile, in forma simmetrica, del vulnus che può provocare nell’altro. E non dimentichiamo che feriamo con le nostre ferite, perché le ferite che non riconosciamo, e non ci assumiamo, diventano armi di difesa e di offesa.
Lasciare essere, e riconoscere le proprie ferite, è possibile se qualcuno ci ha visto e riconosciuto.
Il superamento del dualismo non può comportare disconoscere le differenze, perché imparare a pensare la differenza è un aspetto fondamentale sia del riconoscimento che dell’identità. Si tratta di superare il manicheismo logico, accettare che siamo sia forti che vulnerabili, la postura femminile del tenere insieme: et et, non aut aut.
Montanari scrive che se fossimo capaci di un buon esame di realtà riconosceremmo nell’altro il migliore alleato “colui al quale dobbiamo non solo riconoscimento, ma anche la nostra riconoscenza”. Interessante che la lingua francese usi lo stessa termine per i due concetti: reconnaissance. Paul Ricoeur, non a caso, osserva che il libero e mutuo riconoscimento è la vera alternativa al riconoscimento come conflitto, per cui diventa importante riconoscere che anche la madre, che si dona al proprio figlio, è nutrita dalla conferma della sua utilità da parte del bambino. Riconoscere che anche le madri dipendono, come dice Benjamin “da questa reciprocità della responsività del bambino” è fondamentale – scrive Montanari – “per l’etica della responsabilità che parte dal riconoscimento della reciprocità della relazione”. In questa direzione vanno anche le riflessioni della filosofa Elena Pulcini che parla di “passione condivisa nella responsabilità”, e di “responsabilità come dono”.
Ma per realizzare tutto questo dobbiamo diventare gli autori della nostra vita, l’interpretazione del copione che la vita ha scelto per noi: declinare per esempio un verbo, da imperativo a condizionale, dall’Io al Noi, cambia le prospettive e la vita.
Ci troviamo, oggi, di fronte alla scomparsa del soggetto a favore di un sé che tenta inconsciamente di diventare un oggetto nel mondo degli oggetti: con chi dialogano i giovani oggi, e che umano può nascere se l’interlocutore è un avatar che mi guarda ma non mi vede?
La cura necessita, scrive Montanari, che si passi dalla domanda “cosa fare?” a “di che cosa siamo fatti?”; interrogare il nostro mito, di interpretare artisticamente il proprio copione e non ricopiare modelli considerati vincenti. Si tratta di un nuovo modo di pensare la potenza, e, in questa prospettiva, la strada verso l’impotenza è allora quella segnata dalla scelta di non amare, di non aprirsi a ciò che l’amore porta in dote, comprese le ferite e le delusioni. Scrive Spinoza: “l’amore è dunque un veicolo di felicità non tanto perché ottiene ciò che brama, ma in considerazione di ciò che attiva nel soggetto innamorato, compresa la – fondamentale – capacità di accettare i limiti che questo potere ha sugli altri”. Forse allora è proprio vero che All We Need Is Love.