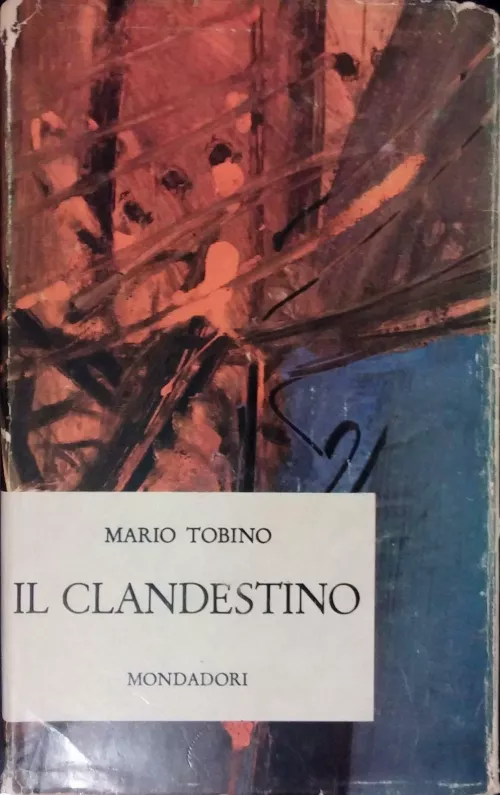Einaudi e Mondadori / Mario Tobino. Il clandestino conteso
Esistono centouno quaderni manoscritti, compilati a partire dal 4 marzo 1945, che compongono il diario dello psichiatra e scrittore Mario Tobino. Sono stati conservati dagli eredi, e non c’è opera tobiniana che non sia lì testimoniata nella sua genesi e nel suo sviluppo.
Narratore di cui si possono riconoscere agilmente almeno due grandi partiture: quella della follia (esemplificata in opere come Le libere donne di Magliano o Per le antiche scale) e quella del fascismo e della guerra (i cui titoli di maggior circolazione sono forse Bandiera nera, Il deserto della Libia, Il clandestino), accomunava tutti i suoi lavori dalla costante ricerca di un’immedesimazione sincera con i silenzi dei personaggi, con le loro attese più oscure, con la realtà che essi abitano. E se ciò è certamente presente nelle opere sulla follia – per Tobino era necessario stabilire una relazione interpersonale con i pazienti, non essendovi altrimenti nessuna cura psichiatrica – è altrettanto evidente nei, per così dire, romanzi di guerra.
Persino in un’opera corale come Il clandestino. Nelle pagine di questo romanzo, la Resistenza è infatti tutt’altro che idealizzata; viene semmai rappresentata nella sua drammaticità a partire dalla fatidica data del 25 luglio 1943, giorno della caduta di Mussolini; del suo arresto e del successivo proclama di Badoglio che raggela le speranze di pace degli italiani: la guerra sarebbe dovuta continuare al fianco dei tedeschi: «L’Italia – recita il messaggio – duramente colpita nelle sue provincie invase, nelle sue città distrutte, mantiene fede alla parola data, gelosa custode delle sue millenarie tradizioni».
Romanzo monumentale, che supera le 550 pagine, Il clandestino è un’opera dalla lunga gestazione. Già nel 1952, dieci anni prima del visto si stampi, il progetto è in essere, e l’autore annota sul suo diario che i fogli manoscritti di Il periodo clandestino sono quasi mille: «Non sono forse nemmeno a mezzo, anzi non sono certamente neppure a metà». Se ne rammarica e, subito dopo l’uscita con Vallecchi di Le libere donne di Magliano, si rende conto di essere in ritardo sugli eventi narrati: «Sono passati dieci anni dal 1943. E ancora non ho scritto Il periodo clandestino. Dio mio, che vergogna! […] Ci vogliono ancora due anni di lavoro umile, di abbandono, genio e pazienza».
È una previsione è errata. Il lavoro di riscrittura, ribattitura a macchina e revisione porterà via molto più tempo; la chiosa definitiva giungerà solo il 16 novembre 1961, quando può annotare sul diario: «Mi sento placato. Ho finito Il clandestino. Ho detto ciò che avevo di più virulento e vero nel mio animo. Non ho mancato nulla, non manca una parola. Sono circa cinquecento pagine. Sono anni e anni che ci pensavo e lavoravo, ci lavoravo e ci pensavo. Tiro un sospiro di sollievo come un tuffatore che ritorna in su». Due settimane dopo, negli uffici della Mondadori, aprivano una busta contenente il dattiloscritto.
Come si sia arrivati a questa apertura di busta, e perché essa non fosse destinata alla Einaudi o a Vallecchi, editori con cui Tobino pubblicava sin dal 1951, è una storia che ha per protagonista Mariagloria Sears, consulente della casa editrice milanese, che nel giugno del ’58 ha l’occasione di conoscere Tobino tramite l’amica Paola Levi Olivetti (donna che fu, dello scrittore viareggino, cardine sentimentale). È lui a confessare alla Sears di voler entrare in contatto con Mondadori: «Non so esattamente come sia il suo contratto – scrive la consulente a Milano – ma si è offerto di mandamene una copia. Va tenuto conto che Tobino mi ha parlato in via più che amichevole». E ne traccia poi un profilo caratteriale: «Egli è [...] un uomo difficile, diffidente, che tanto Vallecchi quanto Einaudi hanno sempre trattato male, sia pure per motivi diversi. È dunque un uomo amareggiato, che fa di professione il direttore di un manicomio, ha poco denaro, ed ha bisogno di essere curato».

Ciò è quanto basta per attivare le macchine. Elio Vittorini viene incaricato di stendere la scheda su Tobino; lo definisce uno scrittore con dei numeri alla Gadda, anche se di più facile lettura e meno profondo; «discontinuo: può fare ottimi libri, […] e può farne di mediocri. […] Ma comunque è rispettabile e sempre degno di entrare nel nostro catalogo all’ombra di una collana di prestigio come la Narratori italiani».
Ma occorrerà attendere l’anno successivo, quando Vittorio Sereni sostituisce Elio Vittorini, per vedere il cerchio cominciare a stringersi attorno allo scrittore. Del resto, proprio Vittorini è tra quelli accusati da Tobino di averlo scarsamente considerato alla Einaudi. E il suo è un giudizio umano tanto feroce che nemmeno la morte dell’editor porta clemenza: nel diario possiamo leggere un ricordo di Vittorini definito come «un infantile, entusiasta di una sua immagine di gloria letteraria, del tutto avulsa dalla sua realtà».
Ancora nel febbraio del 1959, un contratto per Il clandestino non è stato siglato e allora, prova a interferire nella trattativa Italo Calvino, prefigurando il nuovo romanzo di Tobino come il possibile libro dell’anno di casa Einaudi. La replica a quella lettera è però elusiva: «Amerei lavorare ma il benedetto ospedale e altre malinconie mi fanno lungo. Sicché non ti posso proprio rispondere nulla». Tobino si lamenta poi soprattutto per la scarsa presenza in libreria di quelle sue opere uscite sotto l’insegna dello struzzo. Eppure, complice il fatto che l’accordo con Mondadori non veniva siglato, da via Biancamano tentano un ultimo affondo, ed inviano una bozza di contratto accompagnata da una lettera di Luciano Foà: «Speriamo non ti schermirai e ce la rimanderai firmata. Di questo tuo nuovo libro contiamo di fare un grosso successo. Gli altri tuoi libri che abbiamo pubblicato non potevano uscire dalla cerchia dei soliti 2000-3000 lettori». Ma, di nuovo, Tobino incalza, ed è in particolare la frase in cui si fa riferimento al grosso successo, che lo urta: «Non ho potuto, leggendola, trattenere un sorriso. Anche per Passione per l’Italia mi fu assicurato così».
Parallelamente, Niccolò Gallo e Vittorio Sereni portano a compimento quel lungo lavoro di corteggiamento suscitato dalle missive di Mariagloria Sears e, il 28 novembre 1961, Alberto Mondadori può scrivere all’autore dandogli il benvenuto nella casa editrice.
Era infatti accaduto che sin dalla fine del 1959, per avere Il clandestino, l’atteggiamento di Sereni si era fatto sempre più esplicito: «Senza molti preamboli, ti dico che c’interessa particolarmente il romanzo che stavi, o stai, scrivendo, e di cui abbiamo notizia», e gli preannuncia l’idea, poi realizzatasi, di stampare il romanzo nella collana Narratori italiani, e di farlo essere il primo di una serie interna intitolata Opere di Mario Tobino.
L’autore non prende però posizione, perciò nel marzo del ’60 Niccolò Gallo viene spedito a Lucca per incontrarlo. Ne torna ottimamente persuaso: «Ci darà il romanzo, [...] tempo: otto-dieci mesi. Oltre tutto non chiede nessun trattamento particolare, né anticipi né premi d’ingaggio. […] L’unica sua riserva è che non vorrebbe legarsi definitivamente, per conservare – dice – la sua libertà: non ci darebbe, cioè, l’opzione sui libri da venire».
La prima copia di Il clandestino, Tobino la riceve il 2 maggio 1962, ed è un momento vissuto «con malinconia, per il ricordo delle infinite mie solitarie sere, giro stanotte lo sguardo alla libreria, magra, della stanza che mi ospita nel manicomio di Lucca, e rivedo Il clandestino, le copie che ho disposto tra gli altri libri pubblicati».
Guarda le sue copie rivestite di una copertina che non era quella che si prefigurava nei primi anni di lavoro al romanzo; ipotizzava infatti l’immagine di un tappetino rosso «contornato di frange e nel suo mezzo la fotografia, per lungo, di una bruna pistola, la canna diretta verso l’oriente».

La prima tiratura si esaurisce in quindici giorni e il romanzo di aggiudica il Premio Strega, ma bruciano, all’autore, alcune recensioni, in un’accoglienza della critica che si rivela generalmente tiepida.
Secco è il giudizio di un giovane Pietro Citati, che su “Il Giorno” proclama: «Forse non c’è nulla di più triste di uno scrittore che si avvia alla decadenza. […] Nessuno scrittore italiano possedeva forse una prosa così arditamente espressiva, piena di metafore bellissime, di torsioni, di ellissi, di scorci immaginosi. [...] Ed ora questa espressività non esprime: le arditezze si sono trasformate in errori: la stringatezza machiavellica si è sciolta in un chiacchiericcio abbondante e senza nerbo». Tobino accusa il colpo, e nel suo diario lancia tutta la sua rabbia contro Emilio Cecchi, reo – secondo lui – di essere il mandante della recensione di Citati: «Il Cecchi ama molto il Guicciardini e io amo molto il Machiavelli. Guicciardini era un signore, ma rimase nella provincia, Machiavelli era universale».
Quel che Cecchi rimprovera in particolare è la quantità di episodi che si affastellano nel libro, molti dei quali si risolvono in nulla: «In complesso, è nel romanzo un forte eccesso, quasi si direbbe un ingombro di materia rimasta grezza, non fusa». Il critico salva però le parti in cui compare Anselmo, medico alter ego dello scrittore: dove è lui, infatti, «l’atmosfera del racconto prende un insolito calore interno, si ravviva d’una più sicura qualità di partecipazione umana».
Eppure, tra i primi apprezzamenti privati a Il clandestino, era giunto quello di Arrigo Benedetti, direttore di “L’Espresso”: «Lo stile è sciolto, certe durezze sintattiche che erano proprie di alcuni tuoi romanzi più brevi non esistono più, e forse deriva dal carattere più disteso della narrazione. La sintassi delle Libere donne di Magliano, dei Biassoli e di certi tuoi diari era quella di un poeta che scrive in prosa mentre la sintassi del Clandestino è veramente narrativa».
Ma molti altri non sono di quel parere. Luigi Baldacci su “Epoca” conferma le impressioni di Cecchi: «È […] l’apertura di compasso che nel Clandestino si è allargata per abbracciare un quadro epico, ma con una certa sproporzione tra lo strumento e l’oggetto che si voleva cogliere».
E se mentre dieci anni dopo l’uscita, in una introduzione al volume riversato negli Oscar Mondadori, Geno Pampaloni esalta l’autore per aver «cantato la storia contemporanea come una saga eroica», sembrano suonare come definitive le parole di Enzo Siciliano, che nel 1972 commenta: era «il libro più pensato, e forse per questo più incerto nel risultato complessivo».