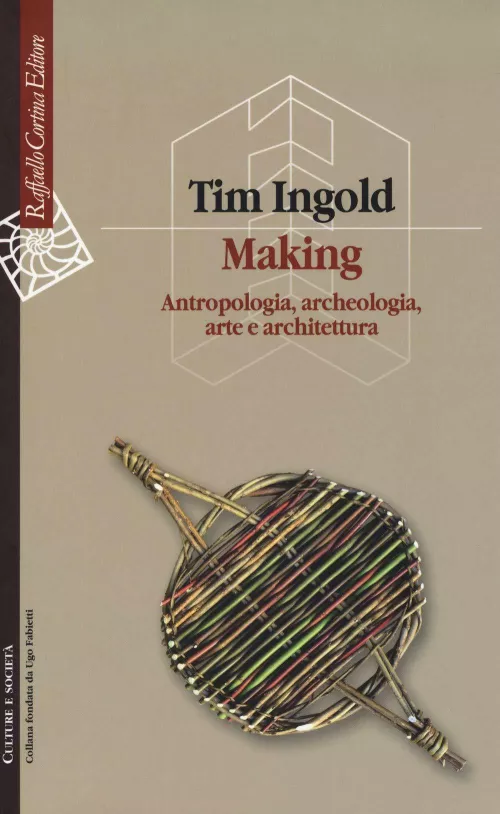Making, Arte, Archeologia, Architettura / Artisti e antropologia: far parlare la realtà
Negli ultimi vent’anni c’è stato un avvicinamento impressionante tra due discipline che non hanno mai avuto uno statuto comune: l’arte e l’antropologia. Da qualche settimana uno degli antropologi più brillanti e antiaccademici come Michael Taussig (di lui è in uscita la riedizione di Il mio museo della cocaina per Fieldwork-Milieu) tiene un corso a Cà Foscari a Venezia il cui titolo è “Fieldwork as art”. La tesi di Taussig è che il lavoro di ricerca sul campo che consiste in un’osservazione partecipata, cioè nella condivisione della vita quotidiana della gente che “si studia”, ha tutte le caratteristiche della ricerca artistica. In un testo rivelatore e pieno dei suoi “schizzi”, disegni, mappe, aforismi e osservazioni immediate, “I swear I saw this”, Giuro di aver visto questo, Taussig pone le basi per una nuova teoria del fieldwork. Catturare, annotare, disegnare, scrivere note è un processo artistico, una presa sul mondo che consenta di farlo passare come un’impronta nei propri carnets di viaggio. Ciò richiede un’arte, si tratta cioè di una lunga formazione che educhi la sensibilità a intuire cosa accade là fuori. Un altro antropologo contemporaneo, Tim Ingold, nel suo bellissimo Making, Arte, Archeologia, Architettura (Raffaello Cortina ed.) definisce il fieldwork come l’apprendimento per contiguità delle pratiche altrui. Un apprendimento fisico prima ancora che intellettuale, fatto di gesti, tecniche del corpo, maniere di fare, di trasformare la materia intorno. All’antropologo, secondo Ingold, è richiesto di avere quel particolare tipo di “apprensione” della realtà che sta più nel campo dell’intuizione (altri parlano di abduzione) e che compete alla creazione artistica. La cosa impressionante è che nel campo degli artisti avviene un fenomeno analogo. L’idea che la pratica artistica sia un “fieldwork” è talmente diffusa che si sprecano i convegni, le monografie e i reader sull’argomento e gli artisti che si definiscono antropologi sono oggi numerosissimi.
Si pensi al lavoro di Jimmy E. Durham, l’artista Cherokee amico di Taussig, che è stato insignito del premio alla carriera dalla Biennale di Venezia quest’anno, ma anche alle opere del sudafricano William Kentridge, che sconfinano tra denuncia, documentazione storica, sensibilità antropologica, ricerca dettagliata sul campo. Anche all’ultima biennale i lavori di documentazione sul campo erano numerosissimi, tra tutti quelli sulla danza nelle favelas di Rio per il padiglione Brasile, ma lo stesso padiglione Lituano con la performance sulla spiaggia aveva i caratteri di una messa in scena molto etnografica. Gli artisti hanno con piacere attraversato i confini disciplinari e si può dire che gli scambi sono molto fruttuosi e arricchiscono le pratiche di entrambe le discipline e soprattutto le mettono in una crisi produttiva. Ci sono casi di “imbrogli” poco piacevoli, dove artisti un po’ superficiali si appropriano degli strumenti dell’antropologia senza avere la pazienza e la competenza per adoperarli e se ne servono come giustificazione al proprio lavoro, ma sono eccezioni.
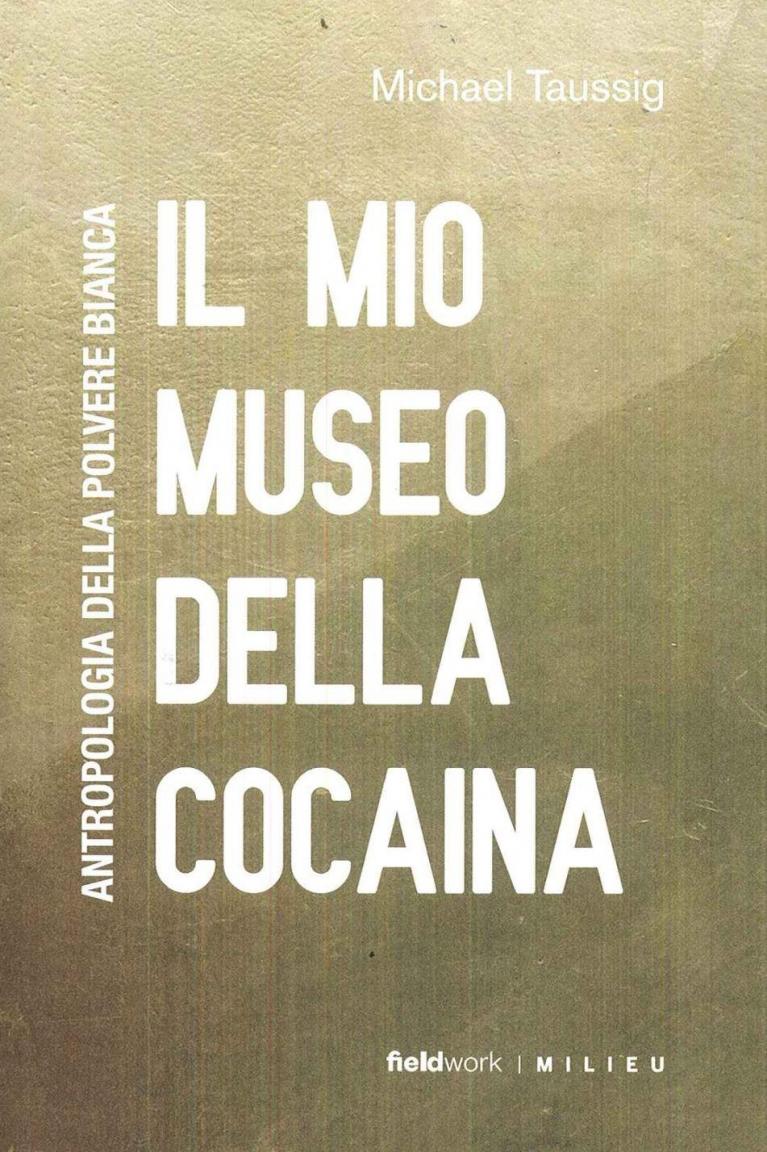
Occorre anche notare che questa vicinanza dei campi era stata posta in altri periodi. All’origine dell’antropologia francese, intorno ai surrealisti e al “Collegio di Sociologia” si riunivano personaggi come Bataille, Caillois, Leiris, consci del valore fondamentale dell’altrove nella mossa del cavallo che era necessaria a un’arte contemporanea. Lévi-Strauss stesso, per quanto abbia soffocato in un sorgente strutturalismo questa attenzione, non ne era del tutto al riparo. E per andare oltre-oceano, c’è un esempio che nella New York degli anni ’40 stupisce per la sua intuizione anticipatrice. È il caso di Maya Deren, artista e cineasta d'avanguardia, vicina a Man Ray e allo stesso tempo assidua frequentarice di Joseph Campbell, l’autore del libro di mitologia più venduto al mondo L’eroe dai mille volti e alla coppia Gregory Bateson e Margaret Mead. È proprio trattando con questi ultimi che la Deren decide di andare a passare un lungo periodo ad Haiti per studiare il Vudù. Una volta giunta sull’isola l’artista newyorkese si immerge nei rituali di possessione, entra nel mondo delle divinità africane e fa parte delle séances di possessione. Ad Haiti però accade qualcosa di inaspettato: la Deren rinuncia a fare l’artista, decide che la realtà dentro cui si trova è troppo complessa per essere trasformata in “arte” e si trasforma in antropologa. Non produrrà alcun film, ma un testo che è ancor oggi di riferimento per chi voglia occuparsi di vudù haitiano. Lo ha ripubblicato in Italia il Saggiatore, I cavalieri divini del Vudù, l’originale è del 1953, la traduzione italiana di Cristina Brambilla.
Per chi conosce il percorso della Deren e la sua maniera di lavorare, il passaggio all’antropologia sembra uno sviluppo naturale della sua maniera sperimentale di procedere. La stessa artista che filma Duchamp a New York durante la partita a scacchi concepisce se stessa come una ricercatrice, un’artista che cerca di evocare la presenza ineffabile della realtà. Da poco sono stati pubblicati degli estratti del suo diario di campo ad Haiti. E per comprenderne la portata, anche scientifica, occorre confrontarli con la conclusione dei Cavalieri, laddove la Deren racconta la sua possessione, inaspettata, come un calarsi nell’abisso, una possessione che lei non ha cercato, anzi che ha evitato accuratamente durante tutto il lungo periodo, tre anni di ritorni e permanenze sul campo (anche questa una caratteristica che l’accomuna all’antropologia, il non accontentarsi di un mordi e fuggi, ma un calarsi completamente nella realtà da studiare). Viene alla mente il coinvolgimento di cui Michael Taussig parla in Il mio museo della cocaina, quel non potere mai restare indifferente alle circostanze, l’essere implicato nella vita delle comunità povere e minacciate dei neri della Colombia. Se l’antropologia si richiama al “metodo”, all’importanza della sospensione tra oggettività e soggettività, della capacità dello sguardo da lontano, ma coinvolto, per gli artisti il capitombolo avviene al contrario. Il salto mortale è quello dalla soggettività estrema alla capacità di far parlare la realtà senza caricarla solo del proprio sguardo.