Ho paura dei dieci
“Mi fanno paura i voti”, la tredicenne fissa i suoi leggins neri. “Hai preso dei brutti voti?” “No, quelli non li prendo mai – io ho paura dei voti, tutti i voti. Prendo nove o dieci, quasi mai otto, ma ho paura anche dei nove e dieci. La sera prima della restituzione di una verifica, non dormo. Ho il terrore delle cifre che saranno scritte sul mio foglio.”
“Quando il sangue inizia a gocciolare” dice la sedicenne con un filo di voce, “io sto meglio. Sono calma. Sono loro che creano tutto quel caos attorno.” – Loro chi? – “Gli insegnanti, l’ambulanza, il preside, i genitori. Mi accusano di influenzare le altre.” – Quante siete in classe che vi tagliate? “Sei!” la risposta è accompagnata da un sorriso.
“Sento le mie cosce grossissime”. L’undicenne trattiene il fiato, come se avesse svelato un segreto. “E mi ripeto: non devi mangiare i crackers, non devi mangiare i crackers.” Il suo sguardo mi attraversa senza trasmettermi alcuna emozione: “Tu cosa mi consigli?”
Da quando gli smartphone permettono di essere costantemente online (dal 2010 in poi) – è stato riscontrato un aumento inarrestabile di ansia e depressione negli adolescenti, in particolare nelle ragazze. Lo scrive Jonathan Haidt nel suo bestseller mondiale La generazione ansiosa. Haidt descrive correlazioni rilevanti tra l'uso dei social e la salute mentale e riporta che gli adolescenti negli Stati Uniti passano mediamente sette ore al giorno davanti agli schermi.
Ho chiesto a un ragazzo ventenne, in terapia con me, quante ore al giorno trascorre sugli schermi. “Cinque o sei, più o meno” risponde, “ma se vuoi, ho la app, possiamo controllare.” Abbiamo guardato insieme la sua app: un giorno prima erano nove ore e 40, l’altro otto ore e 30, due giorni prima dieci ore e 20. È rimasto più stupito di me.
Non si tratta solo delle ore trascorse nel mondo virtuale. Oggi notiamo cambiamenti più drastici e difficilmente reversibili inerenti alle dinamiche intrapsichiche. Riguardano soprattutto un bisogno che sta alle radici dei processi di maturazione e di socializzazione: il bisogno di essere visti e riconosciuti dagli altri.
“Tutte abbiamo tre account sui social”, mi spiega una quattordicenne, “uno privato solo per gli amici, uno pubblico e uno...insomma, abbiano un terzo account, con un profilo totalmente fake. Con quell’account posso seguire chi voglio, perché nessuno sa che sono io.” – “Capisco, quell’account non sei tu, ma sei tu ad usarlo”. – “Esatto, io posso seguire gli altri. E posso entrare nei siti più strani.” Fino a ieri si andava dallo psicanalista per confrontarsi sulle cose strane. Oggi c’è il terzo account. Chissà dove sarà situato. Mi rendo conto che la parola dove è superata oggi. D’altro canto in questi luoghi che non hanno fisicità, si produce un tipo di intimità particolarmente intensa. Si crea una sensazione di vicinanza creata dalla iperstimolazione sensoriale, limitata alle percezioni visuali e acustiche. Un’intimità senza il tatto, il gusto e l'olfatto.
La ragazza desiderava guardare gli altri senza essere vista. Una forma di voyerismo? Potrebbe trattarsi anche del suo opposto. Quel bisogno vitale di essere visti e riconosciuti dagli altri. È per quel bisogno che i ragazzi rimangono incollati a guardare video altrui? Non sembra logico. Lo fanno perché sperano di trovare il trucco, perché un giorno diventi “virale” un loro video?
Cercando di capire, ho provato a guardare i videoclip come arrivano sul cellulare di una sedicenne: da un sito cinese famoso. I contenuti erano lontani dai miei interessi e i protagonisti lontani dalla mia età. Nonostante ciò, devo ammettere che durante l'esposizione mi sono sentita in compagnia, come se fossero venuti a trovarmi dei vicini di casa che non avrei mai invitato. Quando ho spento lo schermo, i colori della mia stanza sembravano più opachi di prima, il cielo fuori meno azzurro e le cose che avevo da fare sembravano lontane. La iper-stimolazione audiovisiva aveva già lasciato traccia nel mio cervello.
Osserviamo le dinamiche relazionali fra influencer e follower: i primi, che hanno un’infinità di follower, confessano che temono un incontro casuale con essi. Se si incontrano per strada, il follower si commuove e corre ad abbracciare l’influencer come se avesse ritrovato un amico di vecchia data. L’influencer rimane paralizzato, trovandosi di fronte a una persona sconosciuta, ma emozionata. Non sa cosa dire. Dalla pelle di tutti e due trasuda l’imbroglio. L’unilateralità della relazione, che era stata percepita solo da uno dei due come estremamente intima, viene alla luce. Ma che tipo di esperienza stava cercando il follower mentre seguiva il suo influencer con fedeltà quasi ecclesiastica? Difficilmente saranno i contenuti. È possibile invece che il follower si sentisse in compagnia del suo influencer e che – in maniera quasi allucinata – si sentisse anche visto da lui. Le dinamiche relazionali sembrano rovesciate: chi guarda ha la percezione di essere visto e così continua a guardare.
Il bisogno di essere visti e riconosciuti dagli altri trova un’affascinante espressione nella primissima infanzia: il gioco del nascondersi, la gioia assoluta di un bambino di meno di un anno, esiste in tutte le culture. L’adulto nasconde il proprio viso con le mani o con un telo per farlo poi riapparire d’improvviso. C’è – non c'è. L’intensità dell’emozione lascia intuire l’importanza evolutiva di questa interazione. È la gioiosa scoperta della propria esistenza in relazione agli altri.
La ragazza che mi aveva parlato dei suoi account, era genuina e pericolosamente ingenua. Sembrava una bambina entusiasta che voleva giocare peek-a-boo e non sapeva come fare. Fissava il suo cellulare per ore e non si accorgeva che nessuno stava giocando con lei, che le persone dentro la realtà virtuale si comportavano solo come se la vedessero: la fissavano con occhi truccati e apparentemente empatici, si avvicinavano con visi impeccabili parlandole in toni accattivanti. Nessun essere umano la stava guardando. Ma la stimolazione sensoriale ipersaturata di colori, suoni, movimenti e delle risate le davano la sensazione di essere vista e riconosciuta mille e mille volte.
La tecnologia sembra riuscire a trasformare relazioni reciproche in relazioni unidirezionali, dalle quali dipendiamo. I figli della generazione Z (studiata da Haidt) non sono in grado di accorgersi di questo. Vorrebbero imparare ad avere relazioni umane. Vorrebbero costruire un’identità coerente per se stessi. Vorrebbero stare in compagnia e vogliono avere un ruolo utile nella società. Catapultati fin da piccoli nel mondo virtuale, si confondono. Si illudono di essere visti e in compagnia e non smettono di fissare gli schermi. Ansia e depressione da una parte, ed esperienze di delusione dall’altra, sono inevitabili. Non notano che il sentiero lungo il quale camminano nell’intento di crescere, è un vicolo cieco. Come succede alle tartarughe marine che, una volta uscite dalle uova, si dirigono verso l’interno della costa, anziché verso il mare. Le piccole tartarughe sono attratte dalle luci della città, che sono più forti del luccichio del mare, verso il quale sarebbero geneticamente programmate ad orientarsi. Prendono la direzione sbagliata e, investite dalle auto, muoiono.
Il mondo virtuale per molti non inizia a undici anni, ma nel primo anno di vita. Il cucciolo mammifero è geneticamente predisposto a rilassarsi venendo in contatto con l’animale adulto. I piccoli umani vengono invece deposti in appositi lettini (con doghe trattate mediante sostanze naturali) dove li aspetta, già caricato per durare tutta la notte, il tablet con la musichetta e brevi animazioni che aiutano a prendere sonno. È noto che i produttori dei software li hanno ideati con l’obiettivo di creare dipendenze.
Molti genitori di oggi conoscono una serie per bambini: brevi video, la durata di una canzoncina con il nome di un frutto. Avrete probabilmente assistito a questa scena: un bimbo di un anno attraversa una crisi da abbandono, perché la mamma si è indirizzata verso la porta. La bocca spalancata, la faccina rossa, il respiro bloccato – e poi: l’urlo. No, niente urlo: la tata ben istruita ha premuto il play ed è iniziata la musichetta. In mezzo secondo il bambino è diventato un altro. Con le guance ancora bagnate di lacrime, fissa lo schermo: è partito il video visto da milioni di piccolissimi a casa, in macchina, sul vasino, nei ristoranti, nel passeggino. Lui ha perso la percezione del tempo e dello spazio – potrebbe scoppiare una bomba o la mamma potrebbe uscire e entrare quanto vuole – il comportamento di attaccamento (J. Bowlby) è stato disinnescato e il bimbo è tutto lì all’interno di quel mondo ipercolorato con bambini e adulti ipersorridenti, dalle bocche larghe, dagli occhi giganti e dalle mani grosse. Nulla di violento, nulla di veloce, tutto sembra a misura di bambino.
Guardando questi video il bimbo imparerà un sacco di cose, ma non impara a gestire i momenti di distacco, né a regolare le emozioni. La crisi di panico è passata, ma l’attivazione adrenalinica persiste nel corpo. Senza la regolazione emotiva da parte di un adulto che tenga il bimbo in braccio e gli parli, il suo sistema nervoso autonomo rimane in allerta e i muscoli contratti. L’iperstimolazione del video sostituisce il bisogno di contatto fisico: il desiderio di un abbraccio è in effetti sparito. Il bimbo fissa lo schermo quasi fino al termine della canzoncina. Poiché la conosce e sa che fra poco finirà, un’agitazione gli sale prima delle ultime note. A questo punto le opzioni sono due: o il bimbo sa già come far ripartire il video o scoppierà a piangere – questa volta non per crisi di abbandono, ma per rabbia. Piange, ma ha perso il senso di quello che gli è successo prima, il vero motivo del pianto. Ha tutte le ragioni per arrabbiarsi. Non ha potuto elaborare e superare una crisi di separazione in maniera graduale e fisiologica. Ha piuttosto sperimentato il conforto-distrazione che fornisce lo schermo e dopo tre minuti e mezzo l'ha di nuovo perso. Il suo sistema psicofisico ha iniziato a dare precedenza alla stimolazione audiovisiva rispetto al contatto fisico, per il rilascio di dopamina che nel caso di esposizione ai video è immediato e più intenso del contatto fisico.
La mamma nel frattempo è uscita per andare dal pediatra. Lamenta che il bambino è poco coccoloso e che dorme male. La visita pediatrica prevede una domanda sul tempo di esposizione agli schermi nelle culle?
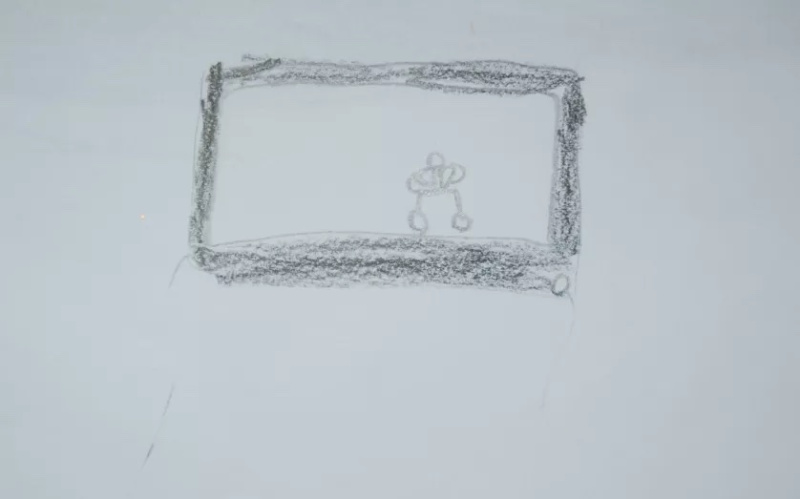
La generazione Y, che nel 2010 era adolescente è oggi composta da genitori. In una piccola area giochi nel centro di Milano con qualche panchina attorno, ho osservato sei genitori (o adulti affidatari) con i relativi bambini, che gironzolavano attorno a scivoli e altalene senza impegnarsi in un gioco. Quattro di sei adulti erano concentrati sui loro schermi, qualche volta con espressione divertita, sognante o preoccupata: la loro vita era lì dentro.
“Splendore...”, mentre camminavo sul marciapiede ho sentito la voce di un papà. Spingeva il passeggino manovrandolo abilmente attraverso la folla, lo sguardo fisso sulla linea dell’orizzonte. Parlava al cellulare. La bimba stava seduta nel passeggino, imbronciata, tesa e sola. Iniziava a piagnucolare. Nel tono paterno si avvertiva un filo di severità: “Splendore!” Ma la telefonata non finiva. Dopo un po’ lo splendore è scoppiata a piangere attirando l’attenzione di tutti: benintenzionati, ma a lei sconosciuti e che quindi la facevano piangere ancora di più. Ne seguì una crisi totale con il papà: “Ma che cos’hai? Ma si può sapere CHE COSA HAI?”
Proviamo ad occuparci di bambini un po’ più grandi quelli di scuola elementare e parliamo con Elisa Queni, insegnante di scuola primaria di Moneglia un piccolo paese ligure.
“Quest’anno ho l’ansia anch’io”, dice e i motivi sono vari: “Nel 2023 ho concluso con una quinta di ventiquattro bambini. Nel 2024 alla prima si sono iscritti quattro bambini. Qualche anno fa - per non dover arrivare alla multi-classe, abbiamo potuto iscrivere qualche anziano che non aveva ancora la licenza elementare, ma ora non ce ne sono più.”
Il calo demografico Italiano è palpabile. Ma, oltre al calo del numero di bambini, cosa devono aspettarsi gli insegnanti all’inizio dell’anno?
“Ah,” risponde con sollievo perché ne può parlare: “Quando i genitori iscrivono i bambini, durante il primo colloquio conoscitivo, esce sempre questa frase: Sa, maestra, lui, (lei) è già molto avanti... Ed io penso ogni volta: Avanti rispetto a chi? E sto zitta.”
Oggi i genitori vengono ascoltati. Per legge devono essere ascoltati anche i loro desideri rispetto al piano didattico, “...come se tutti avessero delle lauree in pedagogia. Ma io non mi metto a dire al panettiere come deve fare il pane. Il problema più grande per noi insegnanti è che oggi ogni bimbo deve eccellere, deve per forza essere più intelligente, più creativo e più efficiente degli altri.”
Mi immagino i quattro bambini di quest’anno, tutti molto avanti nei loro piccoli universi, che il 9 settembre 2024 arrivarono in un'aula semivuota, ma munita di computer.
“E noi, la scuola, dovremmo insegnare a loro competenze sociali...”
“I bambini amano le regole”, continua l’insegnante.
Perché? Forse le amano di più oggi che in epoche passate. Avere la chiara conoscenza di un contesto dà un senso di controllo e permette di muoversi con autonomia: Posso stare nella regola o posso non rispettarla. Non rischio di provocare un’emotività eccessiva da parte dell’adulto, ma posso aspettarmi un riscontro oggettivo. L’emotività oggi poco regolata dei genitori crea un senso di insicurezza, perché i bambini non riescono a prevedere cosa sia in arrivo: irritazione, amore, coccole, abbandono, indifferenza o rabbia. Le semplici regole – mettere a posto, finire le attività, lavarsi, andare a letto, aprire i quaderni e chiuderli tutti insieme – rendono più accessibile un mondo complesso, lo dividono in piccoli pezzi integrabili. Questo inizia già nella primissima infanzia. Vuoi uscire dalla vasca? Vuoi una ciliegia? Vuoi che andiamo al parco? Vuoi che mamma ti cambi il pannolino? Sono domande che, poste quotidianamente, rendono un bambino insicuro. Impediscono lo sviluppo dell’autonomia, invece di stimolarla. Il bambino viene invaso dall'insicurezza dei genitori, i quali – cercando sempre il meglio per il figlio – non riescono a decidere quando farlo uscire dalla vasca, quando e cosa dargli da mangiare, quando metterlo a dormire. Se invece sceglie lui – questo è il loro assunto implicito – sarà giusto per lui. Lui, che non conosce le regole, rimane invece in un limbo e dentro una casualità caotica. Decide a caso, una volta la ciliegia, una volta la carne, una volta gioca a lungo e un'altra volta poco e tutta la vita familiare segue le sue decisioni, che non sono vere scelte. Non gli viene permesso di amare le regole, che sarebbero per lui strumenti per decifrare la realtà. Se tutto dipende da lui, se lui ha mangiato, dormito, giocato solo quando voleva lui, il bambino è stato sovraccaricato di responsabilità. Se questo atteggiamento dei genitori continua, potrebbe sentirsi accompagnato da un’invisibile corte di servitori che gli creano l’illusione che il mondo esista per lui. Questo lo isolerà e può predisporlo a rifugiarsi, appena può, nelle realtà virtuali.
I due disegni sono dal libro: Eva Pattis Zoja, Liliana Liturri, Il mio nottario. L'ora dei sogni in classe, Moretti Vitali 2016.







