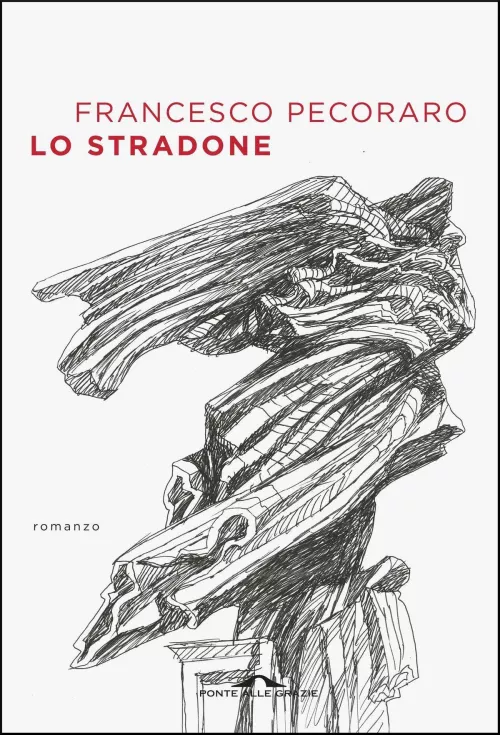Lo Stradone / Francesco Pecoraro, un’apocalisse lentissima
La città che costruiamo è un prodotto collettivo; la città demmerda è un’incerta, auto-celebrante, messa in figura della gente demmerda che ci abita e che la costruisce. Niente di più, ma neanche niente di meno.
Già nel 1960 Giorgio Manganelli, del Pasticciaccio di Gadda, poteva indicare la novità di scala e grana dell’osservazione, nella «visione in grande […] esercitata su oggetti fatiscenti e sfatti». Sicché non si sbaglia a pensare, forse, che natura di Roma sia stata, sempre, quella d’essere la rovina di se stessa. Anche nella sua stagione più canonica, rinascimentale e barocca, la gloria di quelle forme architettoniche luminose quanto arroganti si fondava sul magma di una classicità perenta e deprivata di senso, senza scrupoli depredata e riplasmata. Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini. «Il barocco», ha scritto Ungaretti, «è qualche cosa che è saltato in aria, che s’è sbriciolato in mille briciole: è una cosa nuova, rifatta con quelle briciole, che ritrova integrità, il vero».
In questo meccanismo crudelmente vitale, però, qualcosa – forse giusto al tempo del Pasticciaccio – s’è inceppato. Da quel momento in poi, lo sfarinarsi interminabile del passato ha smesso di produrre quel futuro che è stato, di volta in volta, il nostro presente. Come spesso ripete Guido Mazzoni (che vi si è trasferito con intenti, c’è da credere, schiettamente etnografici), la Roma in macerie di oggi è prefigurazione di un futuro dove a essere morto, e putrefatto, è appunto il futuro; un mondo dominato dall’entropia che, alla fine del ciclo, tutto ricondurrà al caos particellare dei primordi. Il più banale degli esempi: che in sette mesi le scale mobili della metropolitana, della mia sventurata città, non solo non siano state riparate, ma se ne sia decretata la sostanziale irreparabilità, è segno plastico di come il Politico abbia definitivamente abdicato al Termodinamico. Del resto proprio dall’inizio dei Sessanta un maestro come Thomas Pynchon registra con «cupa allegria» l’impercepito quanto irresistibile trionfo dell’Entropia.
È appunto questa la condizione che nel suo nuovo, atteso libro (dopo La vita in tempo di pace, che nel 2013 lo ha fatto finalmente conoscere a un pubblico più vasto), Francesco Pecoraro chiama «Ristagno». Alla sensibilità dello scrittore Pecoraro aggiunge uno sguardo diciamo “interno”, tecnico: se è vero che prima del tardivo esordio letterario ha a lungo lavorato come architetto al Comune di quella che non chiama mai Roma, ma – come già aveva fatto Pasolini – «la Città di Dio» (con maiuscole del pari emblematiche il Tevere è «il Fiume di Fango», e l’Italia «la Penisola»); e può così misurare con occhio clinico le coordinate di un Degrado di cui ogni civis, quorum ego, non si stanca di riempirsi la bocca (beninteso senza neppure ipotizzare che qualcosa vi si possa mai opporre). Le invettive di Pecoraro contro gli «architetti senza un’idea precisa di cosa sia l’architettura», i quali hanno dato vita a una «struttura linguisticamente incerta, affastellata, che oscilla tra l’azteco e la fantascienza russa anni Trenta», echeggiano quelle di Gadda, nella Cognizione del dolore, contro «gli architetti pastrufaziani» che s’erano sbizzarriti a progettare «ville» e «villule» che «tenevano della pagoda e della filanda, ed erano anche una via di mezzo fra l’Alhambra e il Kremlino».

La formazione tecnico-scientifica che con Gadda condivide Pecoraro (per cui, della triade canonica del materialismo storico, Freud-Marx-Darwin, è quest’ultimo da sempre la sua stella polare) gli fa adottare una postura sperimentale, quasi laboratoriale: che attenua la furia sintattica della Vita in tempo di pace («non odio più. Sarebbe troppo semplice. Al posto dell’odio c’è una specie di disprezzo amoroso, come quando non riesci a staccarti da qualcuno che non stimi, ma a cui sei misteriosamente legato»), come dispiegandola da grumi d’intensità parossistica a una sorta di planimetria millimetrica del Disagio. Sul Tramonto dell’Occidente, a scanso di genericità sociologistiche e invettive millenaristiche, getta uno sguardo minuziosamente localizzato: dal margine della Città, per la precisione dal bar lungo lo Stradone che ha fatto assurgere a luogo letterario, «il Porcacci». Equipaggiato di Binocolo cinese e Atrabile d’ordinanza, alterna campi lunghi (e anzi lunghissimi: su proporzioni gaddianamente geologiche, più che genealogiche) a micro-dettagli proto-cellulari; e vista raso-terra (e anzi raso-Stradone) a prospezione dall’alto della settemplice «Palazza» nella quale lo ha esiliato una vicenda di sconfitte reiterate, e sempre più stoicamente accettate.
Ma soprattutto alterna di continuo le prospettive temporali. Già nella Vita in tempo di pace, in effetti, la ricostruzione storica del percorso che aveva condotto «la Penisola» alla sua condizione attuale era, oltre che retrograda (sino al precipizio nella «buca di Bomba» ’45, da cui tutto aveva preso le mosse), lievemente sfalsata. Nello Stradone queste micro-oscillazioni, questo inavvertibile bradisisma cronologico, assurge ormai a dichiarato metodo conoscitivo (il capitolo iniziale è intitolato, con rovesciato omaggio a Calvino, al telescopio Hubble: ciò che vediamo nel presente è solo un effetto prospettico che giustappone «presenze luminose di entità esistite in tempi lontani e molto diversi dal presente»). È l’effetto che un pensatore che immagino Pecoraro disprezzi – imbevuto com’è di filosofia continentale e psicoanalisi «insopportabilmente metaforizzante» –, Slavoj Žižek, ha chiamato Visione di parallasse (il melangolo 2013): in cui lo scarto dovuto alla prospettiva dislocata dell’osservatore non è un difetto dell’osservazione, bensì la sua stessa condizione materiale. È infatti l’Osservatore stesso il primo a essere attraversato da questa «differenza minima che segna la non-coincidenza dell’Uno con se stesso». Una differenza minima che – come ha insegnato un altro maestro, James G. Ballard – sposta appena nel futuro un’ambientazione che, per il resto, non si discosta affatto dal presente: la «realtà esterna […] mi appare come una distopia precoce del presente, come un presente spostato più in là verso un futuro facilmente immaginabile come peggiore dell’adesso, ma che sullo Stradone è già qui».
Ed è per questo che in termini letterari – ridottasi ulteriormente la membrana sottile che divideva dall’autore effettivo, empirico, il personaggio della Vita in tempo di pace, l’ingegner Brandani: il quale, non a caso, ha perso ora anche il suo senhal – tuttavia Lo Stradone non è ancora un saggio (sebbene ormai da tempo quello che scrive Pecoraro non possa essere più considerato – a dispetto della solita scritta in copertina – un romanzo). Un po’ come accadeva nel libro estremo di Thomas Bernhard, Cemento, Lo Stradone si presenta anzi come quod superest del tentativo di scrivere un saggio, appunto, sulla pittura astratta (echi di questo progetto erano già in un paio di racconti del libro d’esordio di Pecoraro, Dove credi di andare, Mondadori 2007). Tentativo consegnato naturalmente allo scacco: «scrivere un saggio oggi? Cioè proprio negli anni in cui la forma-saggio è estinta e dell’astrattismo non frega più un cazzo a nessuno?».
La forma-saggio è infatti stata dispositivo per eccellenza di quel pensiero critico moderno che, in quanto antitesi perfetta al «post-tutto» dell’Età del Ristagno («quando tutto quello che era, tutto quello che pensavi dovesse essere non è più, o non è mai stato, o non sarà mai e la materia di cui sei fatto è obsoleta, è ruggine che si sbriciola rapida, è moneta fuori corso»), è oggi il più screditato e dileggiato. Eppure è proprio grazie a un’azione «parallattica», per dirla con Žižek, che nello Stradone Pecoraro, lui ostinato «costrutto della metà del Ventesimo Secolo», against all odds dimostra che «l’interpretazione, nella sua odierna rarità post-ideologica, resta pur sempre un atto prezioso e singolare»: quello che almeno dal punto di vista soggettivo, etico (l’«ultimo dignitoso sforzo di consapevolezza cui siamo tenuti di fronte a noi stessi»), ci può consentire di essere sì «travolti, ma ad occhi bene aperti». Alle visioni raso-Porcacci – «ambienza bugiarda», direbbe Gadda, dove però, proprio come nel Pasticciaccio e post-, residuano molecole di icastica autenticità in forma di “perle” linguistiche: «la gente dello Stradone, abituata all’andarsene delle cose e ormai aggrappata alla verità dell’unica cosa condivisa, il linguaggio»; e, sia pure per macchie improvvise e abbacinanti, addirittura edonistica è, da parte di Pecoraro, la percezione di tale verità – si alternano infatti insistiti micro-carotaggi in una micro-storia quanto mai eloquente, che ha il pregio d’insistere sullo stesso Quadrante geografico del “presente”. E che residua, fossile enigmatico nell’irresistita centrocommercializzazione del paesaggio, come archeologia del presente in un futuro anteriore à la Ballard.
Davvero nella zona di Valle Aurelia si erge tuttora, infatti, una ciminiera che più o meno sino agli anni Venti del Novecento ha servito una delle tante fornaci sorte in mezzo ai depositi d’argilla nei pressi del Vaticano, e che le mura orgogliose della Città di Dio hanno per secoli rifornito di migliaia, di milioni di mattoni. Ancora alla fine degli anni Cinquanta, nel celebre epigramma contro Pio XII della Religione del mio tempo, Pasolini aveva buon gioco dialettico a scandalosamente contrapporre lo sfarzo della «bella cupola di San Pietro» all’immediatamente contiguo «monte tagliato a metà da una cava, e sotto / tra una marana e una fila di nuovi palazzi, / un mucchio di misere costruzioni, non case ma porcili», «posti infami, dove madri e bambini / vivono in una polvere antica, in un fango d’altre epoche»: ossia proprio la borgata di Valle dell’Inferno dove per secoli l’umanità diseredata dei Fornaciari ha materialmente edificato la Grande Bellezza che per tutti quei secoli l’ha disprezzata, o semplicemente ignorata.
Della contro-realtà di questa «valle dei dimenticati» celata nelle pieghe del tempo e dello spazio, con erudita pietà oggettiva si raccontano miserie e fierezze, eroismi grandi (nel 1922 la comunità dei fornaciari resiste ai fascisti per una quindicina di giorni, e «per tutto il periodo fascistico la Sacca restò “la piccola Russia”: lavoro + antifascismo + partito + opposizione + galera + resistenza») e piccoli (la quotidiana struggle for life della memorabile «Pierina» che, come un personaggio di Pagliarani, «difende la vita nella sua interezza») dei quali è chiamato a testimone persino Lenin: una leggenda metropolitana lo vede far visita alla Valle dell’Inferno, nel 1908, in transito da Capri a Ginevra, e così confrontarsi con la «dignità» di «questi che» – diceva sempre Manganelli del Pasticciaccio – «vien fatto di chiamare gli indigeni».
A rimpiangere la struttura più robusta e sagomata della Vita in tempo di pace (che si guadagnò un Viareggio e, per quel che vale, la finale allo Strega) ci saranno, c’è da scommettere, i feticisti della forma-romanzo: i quali non sanno apprezzare neppure il giro di vite rappresentato da Eros e Priapo rispetto al Pasticciaccio, o da Nord di Céline rispetto al Viaggio al termine della notte. Quando invece è nello Stradone che si entra a contatto senza sconti (e a prezzo di qualche insistenza di troppo: che non mancava neppure, peraltro, dall’exploit precedente) con quel paradosso vivente che è Pecoraro. Gli umori irriconciliati che urticavano l’epidermide a nudo, ai tempi del precipitato da blog di Questa e altre preistorie (fuoriformato Le Lettere 2008), da tempo si sono sedimentati in costrutti formidabilmente riconoscibili: che, proprio per la loro difformità dal piattume della letteratura circostante – come l’ha definita Gianluigi Simonetti – nonostante tutto se ne ergono, col misterioso residuo fossile di un metabolismo che dovrebbe essere stato da tempo messo a tacere, e ne rappresentano un contro-esempio tacitamente annichilente: proprio come le Torri dell’Edilizia Popolare, così universalmente calunniate, che malgrado tutto con fierezza ancora si sopraelevano, «così cementizie orgogliose severe sovieto-cooperative, e soprattutto altissime e svettanti come un’isola socialista in mezzo al palazzinume borghesuccio circostante».
Se in un suo libro Walter Siti (al quale, nella virtuosistica ekphrasis di un video porno, Pecoraro paga qui il suo tributo) ha potuto scrivere «Io sono l’Occidente», più concretamente l’autore della Vita in tempo di pace avrebbe potuto dire «Io sono l’Italia». E con questo nuovo libro, con ancora maggiore spietatezza di dettaglio, Pecoraro può dire «Io sono Roma» (o, magari, «Io sono Valle Aurelia»). Perché se ogni territorio, in letteratura, è uno spazio affettivo e mentale, nell’opera di uno scrittore il mondo coincide – se è uno scrittore vero – con se stesso. Roma poi, se da sempre è caput Mundi, è perché concentra in sé, nella sua gloria e nella sua miseria, le glorie e le miserie di tutti («Roma capoccia», dice la canzone, «der monno infame»). Alla fine del percorso lo scrittore – se è uno scrittore vero – non avrà bisogno di dire «Io sono io» (col sottinteso seguito albertosordesco). Sarà la sua opera a dirlo; a esserlo, anzi.
Francesco Pecoraro, Lo Stradone, Ponte alle Grazie «Scrittori», pp. 443, € 18
Questo articolo è già uscito in versione ridotta su "Tuttolibri" di "La Stampa", che ringraziamo.