Louise Glück, Una vita di paese
Monologhi, verso libero e andamento narrativo, paesaggi rustici, figure (personaggi) anomale rispetto al patrimonio lirico classico (o canonico): chi ha una maggiore dimestichezza con la poesia italiana del Novecento, sentirà, nella traduzione italiana di Massimo Bacigalupo di A Village Life (2009) di Louise Glück, qualcosa che ha molto a che fare con le immagini periferiche, la sonorità distorta e la cadenza omerica di Lavorare stanca (1936, 1943) di Cesare Pavese; altri, invece, magari proprio grazie ai versi di Pavese (o al quinto album di Fabrizio De André, Non al denaro non all’amore né al cielo, 1971), riconosceranno nei 41 ritratti consecutivi, privi di cesure, pause, sezioni, e accompagnati dal solo titolo della poesia della raccolta, il sottotesto più iconico e culturale del primo Novecento americano, ossia l’Antologia di Spoon River (1915) di Edgar Lee Masters. Ma qui l’immaginario italiano, attraverso esercizi di intertestualità eseguiti per associazioni memoriali (o inconsce) e prestiti pavesiani, si potrebbe estendere fino alla poesia di Walt Whitman, o agli spazi trascendentalisti di Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau – ma se invece volessimo rimanere nella sfera dell’esercizio critico di Bacigalupo, il verso di Glück sembrerebbe giocare maggiormente con quello di Ezra Pound e di T.S. Eliot, e rievocare, a suo modo, la galleria dei trapassati di Masters.
Ma Una vita di paese è già, oggi, un libro diverso da A Village Life: in mezzo, c’è stato il Nobel nel 2020, con la sua lectio virtuale da casa e l’evocazione dei fantasmi della poesia (William Blake, Emily Dickinson, T.S Eliot), numerosi premi e riconoscimenti (tra i molti, la National Humanities Medal), le cattedre di scrittura creativa (prima a Yale e poi a Stanford), le raccolte Faithful and Virtuous Night (2014) e Winter Recipes from the Collective (2021), e, nel giro di un anno, la morte del suo amico poeta (e dedicatario di A Village Life), James Longenbach, e della stessa Glück (tra il 29 luglio 2022 e il 13 ottobre 2023).
Rileggendo oggi (a distanza, diciamo, di circa dieci anni dalla prima volta) Una vita di paese, quell’idea di cambiamento che almeno fino alla Vita Nova (1999) sembrava tenere in piedi le fila del discorso lirico di Glück, sembra avere una presa meno forte sul lettore, soprattutto dopo la morte di Longenbach. In questo caso, però, più che il Longenbach critico di Glück – che in un celebre saggio sulla Vita Nova parlava proprio del rapporto tra lirica e velocità –, mi interessa rievocare il Longenbach lettore di Glück, per entrare lateralmente nella Vita di paese.
Verso la fine della sua vita, quando ormai un tumore al rene aveva già raggiunto i punti nevralgici e vitali del corpo (“Didn’t everyone, my parents, my grandparents, grow old before they died?”, “ma tutti: i miei genitori, i miei nonni, non erano invecchiati prima di morire?”), Longenbach pubblicò sull’“American Poetry Review” (2020) una poesia in sei parti, intitolata In the Village (ora in Forever, 2021). Si tratta di un tipico ‘long poem’ americano (à la Stevens) che non solo dialoga, formalmente e tematicamente (“Shortly before I died, /Or possibly after, / I moved to a small village by the sea”), con il testo eponimo che chiude la raccolta di Glück, ma che, retrospettivamente (?), sembra suggerirci una sorta di breviario o avvio alla lettura di Una vita di paese, a partire dalla fine: “The death and uncertainty that await me / as they await all men, the shadows evaluating me / because it can take time to destroy a human being, / the element of suspense / needs to be preserved –” (“La morte e l’incertezza che aspettano me / come aspettano tutti, le ombre che mi soppesano / perché può volerci del tempo per distruggere un essere umano, / l’elemento di suspense / deve essere preservato –”, p. 180).
Sulla fine dei libri e della vita, tra romanzo e poesia, si è scritto molto (da Frank Kermode a Giorgio Agamben, da Il senso della fine a Il tempo che resta), e nonostante il soggetto lirico (molto pronunciato, nell’ultimo testo, rispetto allo statuto di spettatore e narratore che ricopre nell’intera raccolta) abbia trovato ulteriore spazio (ma sempre mediato da altre voci, spazi, tempi, personaggi) nelle opere successive, l’io e il sé di Glück sembrano congedarsi o rimanere incastrati in una temporalità ferma, immobile, esperita attraverso la ripetizione dei rituali della vita: “On Sundays” (ogni/di domenica), “Summer and winter” (‘d’estate e d’inverno’), “the same road” (‘la stessa strada’) “I keep in mind images from each walk” (‘mi restano in mente le immagini di ogni passeggiata’), “in early spring” (‘all’inizio della primavera’), “Midday” (‘mezzogiorno’), “When” (‘quando’), “Later” (‘più tardi’), fino all’ultimo verso della silloge, “On market day, I go to the market with my lettuces” (‘nel giorno di mercato, vado al mercato con le mie lattughe’, pp. 180-187). Ma se spostiamo il tempo, verbale e avverbiale, della fine all’inizio della raccolta ci ritroviamo nuovamente di fronte alla morte: questo luogo (“this place”) uccide le persone senza alcun motivo (“the way it kills people for no reason”, p. 16).
Ma di che posto parla, Glück, in un testo che, ironicamente, porta il titolo (mutilo) di Pastorale (americana)? I lettori meno giovani avranno in mente lo Spoon River quando vengono catapultati in uno spazio naturale dove vita e morte convivono in una temporalità sospesa, mentre i lettori più giovani avranno come orizzonte d’attesa la pastorale americana di Philip Roth – un altro luogo di distruzione, o decostruzione, del sogno americano attraverso la dialettica tra storia privata e storia pubblica, ma all’interno di uno storytelling (appunto: storico) in divenire.
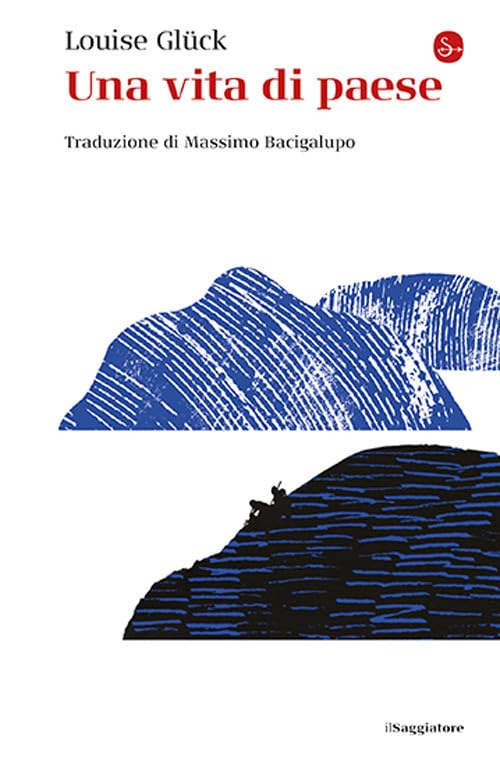
Il tempo di Roth (e, per estensione, del romanzo) scorre, si muove in avanti, ha una fine, nonostante le ripetute resistenze dello svedese (Seymour Levov) e delle sue idiosincrasie (l’armonia, la famiglia, la superfice). Il tempo di Glück, invece, consiste in un’attesa, immobile, della fine del tempo, all’interno di un tempo presente che non assomiglia per niente a ciò che di solito viene associato – più per convenzione culturale che per prassi letteraria – al ‘lyric present’: un non-tempo in cui l’evento lirico avviene attraverso la sua testualità e performance (la lettura, e il conseguente effetto di voicing della voce dell’autore nella mente di chi legge e si appropria dell’identità del soggetto lirico).
Anche senza usare il filtro interpretativo di Longenbach, Una vita di paese è una poesia tutta al presente – con qualche segno verbale al passato (che però non è mai remoto) – in cui le vite dei suoi personaggi (umani e non umani – accanto all’io, agli amici, ai famigliari e agli sconosciuti con cui il soggetto condivide ciò che rimane di lei, ci sono le piante e gli animali, gli edifici e i fiumi, a cui l’autrice affida, se non un valore ontologico, almeno una presenza testuale che va al di là dello statuto di oggetto o referente linguistico) sembrano vivere all’imperfetto: i bambini piangono e le madri sono stanche (p. 24); tutto è deciso (p. 23); la morte è reale (p. 38); le donne entrano quando amano (p. 50); sua moglie canta nella camera da letto (p. 70); la dottoressa mi guarda (p. 96); l’arista vuole esprimere un sentimento di celebrazione (p. 128); so che qui la situazione è difficile (p. 148).
Tutto accade in Glück, come se ogni azione fosse concepita come la ripetizione di un atto che un altro soggetto lirico aveva recuperato da un altro io: se Pavese, in La luna e i falò, scriveva che “un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”, il paese, per Glück (e per Longenbach), è un luogo in cui l’io può sfuggire alla ripetizione del tempo meccanico della vita urbana per abbracciare il tempo della natura (prima della fine) negli spazi privilegiati della vita di campagna, lontani dai rumori della città e dai fastidi che la vita urbana reca a chi desidera tornare al mondo della natura (“The summer night glowed; in the field, fireflies were glinting. / And for those who understood such things, the stars were sending messages”, p. 174). Non sarà di certo un caso, allora, che tutti i testi della raccolta abbiano a che fare con il tempo naturale (crepuscolo, mezzogiorno, tramonto, alba, notte, marzo, primavera, sorgere del sole, mezza estate, una giornata calda), con i suoi elementi più ‘pastorali’ (affluenti, fiumi, neve, foglie, fichi, ulivi), con alcuni dei suoi animali (lombrico, pipistrelli), con attività rurali tipiche della vita di campagna (raccolto, caccia, bruciare le foglie, trebbiatura, matrimonio, confessione, ballo), e con alcuni dei suoi (pochi) luoghi (bar, piazza, chiesa, camere, corridoi).
In questo senso, ogni momento ripetitivo della raccolta è scandito dalla ciclicità della natura, senza che ci possa essere – anche in sottofondo – una scansione diacronica del tempo (anche lirico: non ci sono sezioni nella raccolta né sembra che Glück abbia costruito un canzoniere in morte – si veda Il desiderio della lirica, di Francesco Giusti): chi parla, nel testo, può vedere e vedersi (quindi: riconoscere e riconoscersi) solo alla luce del sole (“It’s very dark today; through the rain, / the mountain isn’t visible”), o al massimo può affidarsi ai suoni della natura (“The only sound / is rain, driving life underground”), sicché l’io e gli altri tornano a essere “animals living in darkness / without language or vision”, p. 140). Un po’ come Pastorale (pp. 16-21), Solitude (p. 140) sottolinea il carattere privato, lirico e s-paesato della raccolta: prossimo alla fine, anche quando decidiamo solo di riavvicinarci al tempo naturale, l’io riesce, finalmente, a comprendere la propria condizione empirica: “niente dimostra che io sia in vita. / C’è solo la pioggia, la pioggia non ha fine”, come leggiamo nella efficace traduzione di Bacigalupo (“Nothing proves I’m alive. / There is only the rain, the rain is endless”).
Tutto, dal crepuscolo all’alba, conduce a questa presa di coscienza: l’io è corpo (vita animale, di istinti e desideri: “My body, now tat we will not be travelling together much longer / I begin to feel a new tenderness towards you, you raw and unfamiliar, / like what I remember of love when I was young”, p. 162), e il tempo è naturale, quasi sconnesso, o disinteressato, dal mondo umano.
In questi 41 ritratti, Glück prova a ristabilire un principio di identità (o di corrispondenza) tra io e mondo; ogni istante tenta, a suo modo, di riportare l’io alla pura esperienza (“experience / being always preferable to theory”), alla “essence of life”, cioè quando l’illusione (la conoscenza: sapere come funziona il mondo naturale, come quello dei pipistrelli) ci permette di vedere direttamente la morte, senza filtri, o addirittura di simularla (“what you see now appears to be a simulation of death”, p. 164), prima del suo decisivo e ultimo compimento. Questo perché, come si legge molto nitidamente in Walking at Night, ogni corpo (‘body’) è espressione di una corporalità radicale e soggettiva che dura solo fino alla morte: dopo di essa, nulla rimane, e quella storia privata scompare con la scomparsa del corpo (“When you look at a body you see a history. / Once that body isn’t seen anymore, / the story it tried to tell gets lost –”, p. 84).
Ed è proprio in questo cortocircuito tra story e history, tra vita e racconto, che l’io lirico di Glück si dissolve, seguendo quel patto narrativo che la vita sancisce con la morte al momento della nascita: “To get born, your body makes a pact with death, / and from that moment, all it tries to do is cheat” (“per nascere, il tuo corpo stringe un patto con la morte, / e da quel momento non fa altro che imbrogliare). Una vita di paese, in fin dei conti, è questo: un tentativo di sospensione, in un eterno presente di ricorrenze (di gesti, di affetti, di parole), del tempo e della nostra mortalità, fino a quando “your word”, “Infinitiy […] cannot be measured” (“la tua parola, Infinito, non potrà essere misurat[a]”, p. 142).
Leggi anche:
Louise Glück | Louise Glück, tre poesie
Massimo Bacigalupo | Louise Glück al Golfo dei Poeti
Alessandro Carrera | Louise Glück, la durezza della poesia
Gianni Montieri | Averno di Louise Glück / È bastato un fiammifero. Ma al momento giusto







