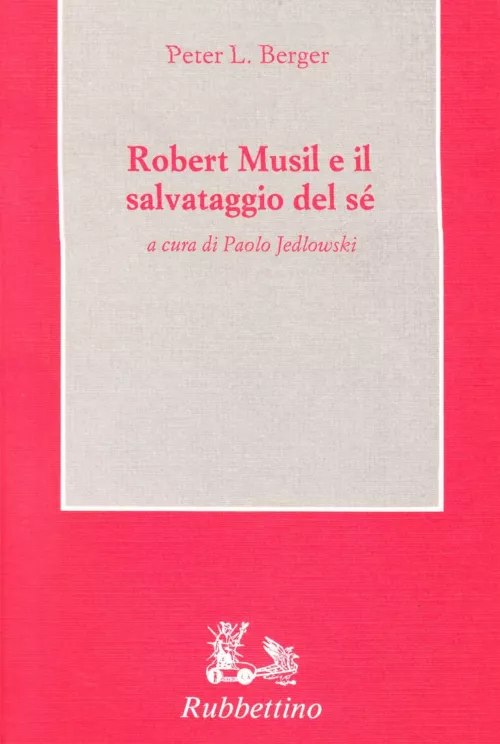Modi del sentire / L'intimità come mistero
Sembra a volte che la parola intimità porti con sé un alone di senso che la avvicina a una promessa di autenticità, di spazio protetto nel quale è possibile – con una sorta di sospiro di sollievo dopo tanto affaticarsi alla superficie delle mascherate di ruolo e degli stereotipi della civiltà di massa e della tecnica – finalmente “toccare” la verità nascosta delle persone, la loro psiche o anima, il loro corpo al di là delle vestizioni nelle “uni-formi” dell’apparire, obbligatorie anche nel loro dovere essere eccentriche.
Confesso un certo fastidio per questa voga che volta in positivo ogni pretesa intimità. Mi sembra una sorta di antagonista prefabbricato, un rifugio illusorio, troppo semplicistico, al divorante imperativo delle maschere sociali. Insomma mi pongo questa domanda: ma è poi davvero possibile, e come, l’intimità come disvelamento di sé al di là delle maschere di ruolo?
In realtà un vecchio quesito: mi pare che la ricerca e la valorizzazione dell’intimità abbia preso il posto – drammaticamente scomodo e irrisolto – del cangiante e plurivoco soggetto moderno alle prese con gli effetti della sua decostruzione.
La difficoltà di ogni intimità presunta, e forse anche la sua dolorosa ricerca, si trova intanto a disagio con ogni classificazione: forse l’intimità potrebbe essere raffigurata da una linea curva asintotica che si avvicina all’infinito a un punto di congiunzione, senza mai raggiungerlo. Così sfugge a ogni definizione, sia pure a quelle apparentemente innocue.
Theodor Zeldin nel suo An Intimate History of Humanity (1994, tradotto da Donzelli nel 1999), scrive di Michèle Blondel, una scultrice abbastanza nota, che per lei niente era più crudele di uno sguardo perché ogni sguardo ci mette in scatola: “Io sono una donna: questa è una scatola”, “Io sono una madre: questa è una scatola”. No: “io sono invisibile”. Gli altri non possono vederla davvero. I suoi primi dipinti erano tutti bianchi, diverse sfumature di bianco, perché il bianco contiene tutti i colori, ma colori che non possono essere visti. Con questo metodo pensava di essere riuscita a nascondersi dallo sguardo degli altri, fino a che non decise che proprio questo la mostrava più nuda che mai e che quindi poteva anche non dire più niente di sé: quando la gente crede a quanto diciamo di noi stessi, allora siamo stati proprio noi a confezionarci una scatola-prigione nella quale ci siamo rinchiusi senza neppure accorgercene. Persino nell’amore, quando sentiva liquefarsi ogni identità, al di là di ogni vergogna, le sembrava di non essere però percepita nella sua irripetibile individualità, nella sua diversità da chiunque altro, ma come un oggetto di desiderio: “Essere messi in una categoria è essere messi in una bara”.
Zeldin sa di aver gioco relativamente facile con una artista con la storia di Michèle Blondel e quindi passa all’esempio di Henri Laborit, un grande scienziato (a lui si deve, tra le tante, la scoperta nel 1952 dell’uso della clorpromazina come neurolettico antipsicotico), un biologo la cui antropologia filosofica è un elogio della fuga come evitamento della competizione per la superiorità. Lo scopo della vita è sopravvivere, il che richiede mantenersi calmi ed evitare lo stress. Se proprio non si può sfuggire fisicamente, lo si può fare con l’immaginazione e col pensiero. Immaginazione e pensiero sono fuori dalla portata di ogni altro e di qualsiasi gruppo: un’intimità che non si può toccare e neppure sapere.
A Laborit non riusciva facile farsi degli amici, diceva che, salvo quelli della sua infanzia, non aveva trovato altro che gente che voleva competere, essere più potente di lui. Probabilmente non era vero: Alain Resnais fece un magnifico film dopo aver letto e aver conosciuto Laborit, Mon Oncle d’Amérique, e i due diventarono amici. Si è poi persino innamorato in vecchiaia di una donna molto più giovane senza peraltro lasciare la moglie. Evidentemente la fuga non è tutto.
Rimane però l’idea che l’intimità non solo sia tutt’altro che facile da incontrare, ma sia anche difficile da immaginare e, quindi, da pensare.
Certo è vero che nessuno potrà mai sapere cosa sto davvero immaginando e pensando. Ma il problema è che neppure io so chi sono: le mie immaginazioni e i miei pensieri si contraddicono. Philip Roth, al centro di una controversia che ruota proprio attorno alla sua biografia, diceva che “vivere è fraintendere”, e però il suo libro di impudica intimità con la vecchiaia del padre, Patrimonio, dice subito, nel titolo stesso, Una storia vera. Probabilmente voleva farsi fraintendere e fraintendere sé stesso, di proposito: come può un romanziere – ma si potrebbe alzare il tiro: come può un umano – scrivere o raccontare una “storia vera” se non intendendo per “vero” una storia che, poiché è una storia, non può essere copia del riferimento reale? Roth d’altra parte sapeva bene che non si è mai al riparo da ciò che altri suppongono che noi si sia: “È il mio destino comico di essere chi i miei detrattori hanno deciso che io non sia”.
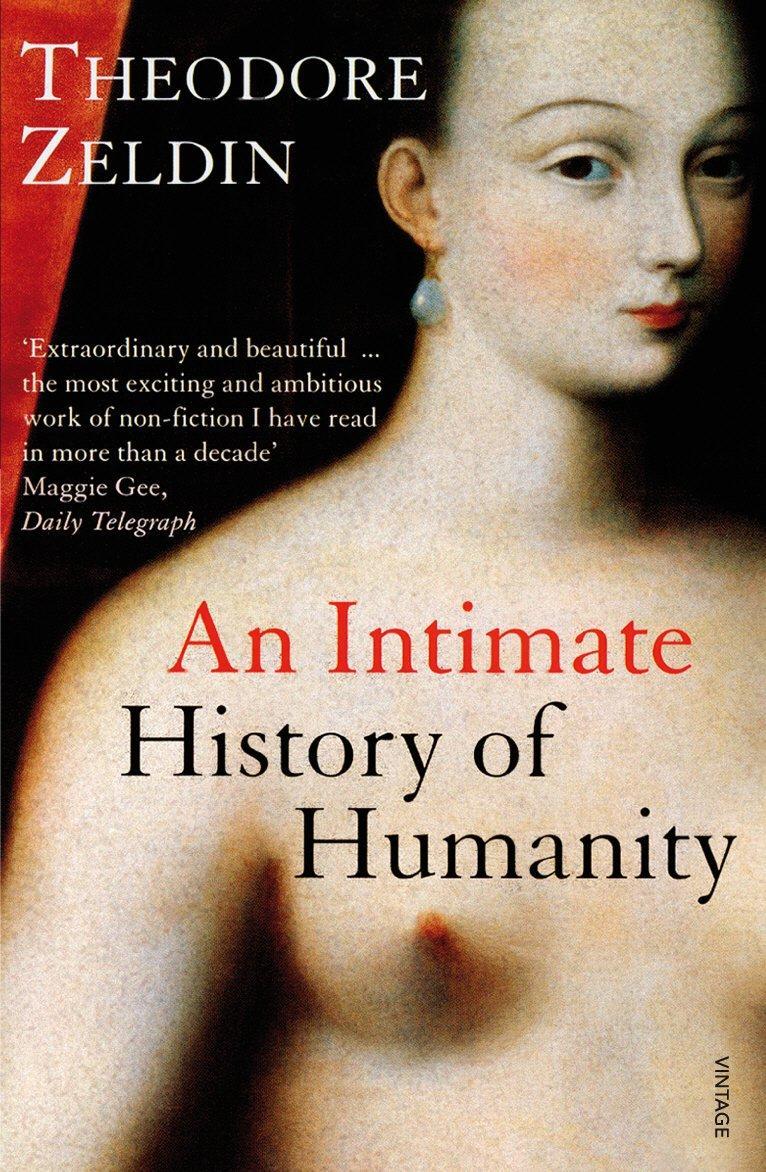
Il tema dell’intimità non può che inquietarci, sembra che sia l’estremo rifugio di un’epoca che ha baldanzosamente, quanto problematicamente, dichiarato l’identità fuori gioco per tutti i sedicenti progressisti. Ma mentre l’identità ha almeno una dimensione logica che è molto complesso – per non dire impossibile – aggirare, l’intimità sfugge, vorrebbe rintanarsi nello psichico, ma proprio lo psichico la sospinge sempre di un grado più in là rispetto alla parola, al gesto, al sentire, all’emozione che la vorrebbe almeno indicare: c’è sempre dell’altro. E dell’altro che ha una radice sociale e culturale tanto robusta da mettere in dubbio ogni tentativo di rifugiarsi in una dimensione psichica presuntuosamente autonoma.
Al contesto storico-culturale ci può guidare una gemma, minuscola per la brevità del saggio, di P. L. Berger, Robert Musil e il salvataggio del sé, scritto nel 1984 e tradotto in Italia nel 1992 per Rubbettino, con un sottotitolo che lo colloca in un panorama epocale in quanto “Saggio sull’identità moderna”, anche con l’aiuto del commento illuminante di Paolo Jedlowski: “Berger, Musil e il ‘soggetto moderno’”.
Il progetto collettivo-patriottico che pone a tema la domanda: “Che cos’è la vera Austria?” affonda perché è l’ordine dello Stato che si sta disintegrando ed esploderà insieme alle bombe della Grande Guerra alle porte. Una pazzia collettiva, salutata con entusiasmo, all’inizio, da gran parte dell’élite e dalla popolazione. Ma insieme al mondo, nel seguito del romanzo, è l’ordine del sé che si disfa in Moosbruger e in Clarissa.
Scrive Berger, commentando Musil: “L’idea che il sé sia una qualche sorta di entità centrale, e che pertanto ogni individuo sia dotato di un ‘vero’ sé, è un’illusione. Forse un individuo, con grande sforzo, può acquisire un centro del genere: ma questo non esiste come un dato della natura umana. Piuttosto il sé è un buco, che, in qualche modo, in ogni modo, deve essere riempito, da noi e dagli altri.” Berger ovviamente dice che però questo sentirsi “buco” è proprio della modernità, nelle epoche precedenti – ma questo non significa affatto fosse meglio – si avevano più certezze circa chi si era.
Rileggiamo questo passaggio densissimo di implicazioni di Berger: “Il moderno, disgregato, ‘sé’ è un ‘sé’ plurale: veramente un Variationskreisel. [uno strumento inventato da Musil, una “ruota di variazioni” che aveva a che fare con la percezione dei colori]. Le qualità di una persona si staccano da lei e diventano meri pendagli di ruoli sociali liberamente variabili. Nelle prime parti del romanzo si stabilisce che ogni individuo, non solo Ulrich, ha almeno nove caratteri – legati alla sua vocazione professionale, alla nazione, allo Stato, alla classe, al contesto geografico, alla sessualità, al conscio, all’inconscio e, forse, alla vita privata (qualunque cosa significhi quest’ultima come categoria addizionale) – e, in qualche modo, deve giostrare tutte queste identità un giorno dopo l’altro. Così un individuo può essere un Ceco, un suddito dell’Austria Ungheria, una persona di famiglia piccolo-borghese, un depravato, un moralista con una libido immorale e, in cima a tutto questo, magari, una persona con una profonda sensibilità musicale” (pp. 26-27).
Un tema che ha avuto mille variazioni, prima e dopo Musil. Due per tutte: Joyce e Pirandello.
Ma una delle idee più trascurate e una delle più teoricamente strutturate e strutturanti, la più ricca di conseguenze se solo la si sapesse articolare, è la definizione degli umani – in quanto personificazioni della reificazione feticistica operata dalla sussunzione nella dinamica delle cose-valori (merci, denari e capitali) – come Charaktermaske, maschere di carattere, nel linguaggio di Karl Marx nel primo volume di Il Capitale.
Che poi, nella vita quotidiana, le maschere moderne (ben altra cosa sono state le maschere prima della modernità), i ruoli degli attori e dei personaggi, diano luogo a un affresco sociologico di grande respiro, è stato efficacemente argomentato da Erving Goffman in La vita quotidiana come rappresentazione, un libro del 1959 il cui titolo in originale suona The presentation of Self in Everyday Life.
Dunque si può e si deve far questione proprio del “sé”. Ed è il “sé” che è in qualche modo in questione nell’intimità: se il “vero” sé è problematico di che intimità si tratta? Quale velo, quale vestito ci si è tolti, quale nudità è svelata o toccata? Non è anche la più intima delle intimità un teatro?
La metafora teatrale è usatissima e abusatissima, e certo non si può – non si deve – superficialmente concludere che se anche l’intimità è teatro allora non esiste o non è importante. Si tratta però di scartare molti involucri senza la pretesa di trovare finalmente il nocciolo, l’essenza nascosta e, per questo, più vera della messa in scena dell’esteriorità, del gioco dei ruoli, della dissimulazione … E senza fingere che la disillusione non possa essere drammatica.
All’alba della modernità Shakespeare aveva atrocemente portato al grado di fusione ogni velleità idealizzante e ogni contraltare superomistico: il nucleo atomico del nichilismo, il monologo della fine di Macbeth.
“[…] Spegniti, spegniti, breve candela!
La vita non è che un’ombra che cammina; un povero attore
che si pavoneggia e si agita per la sua ora sulla scena
e poi non si ode più: è una favola
narrata da un idiota, piena di rumore e di furore,
che non significa nulla” (atto V, scena quinta).
Verrebbe da dire, riconoscendo la sfida e la verità di Macbeth, che non abbiamo niente da contestargli, ma che possiamo non arrenderci: si tratta allora di raccontare una diversa favola, una favola che abbia un senso, un orientamento, che esplori un possibile oltre l’autosoppressione della vita nel rumore e nel furore.
Se l’intimità fosse allora quella tensione – ma allora seriamente, faticosamente, drammaticamente, anche nella non impossibile gioia – a creare uno spazio-tempo fuori scena (in questo senso sì, anche “osceno”), consapevole di essere parte di un metateatro nel teatro, allora forse potremmo darle un nuovo ruolo, fuori e contro quello di contropiano compensatoriamente romanticheggiante della nostra invivibile vita pubblica e delle nostre, spesso stantie, maschere sociali. Il gioco deve chiamare in campo i nostri doppi impresentabili, anche essi certamente parte del retroscena, ma come personaggi ogni volta capaci di suggerire alle maschere sociali imperanti, collettive e personali, una trasformazione più inclusiva, più articolata e sensibile al destino comune e alla irripetibilità della individualità.
Insomma con altre parole aveva ragione Agostino a invocare “Dio” come più intimo a noi stessi di noi stessi: questa invocazione possiamo tradurla nel mistero infinito che il nome “Dio” evocava. Più conosciamo noi stessi, comandamento ineludibile della dignità dell’essere umani, più conosceremo un mistero che si dilata a ogni passo in avanti. Proprio come succede per qualsiasi genere di conoscenza, basta farci caso. Il cosmo della fisica moderna è più misterioso di ogni cosmo immaginato dal mondo premoderno: sapendone di più sappiamo che il nostro non sapere cresce ancor più del nostro nuovo sapere, e proprio per questo. La conoscenza atematica di Dio in quanto mistero, la chiamava il teologo Karl Rahner nel primo capitolo del suo Trattato sulla fede. Ecco, mi pare che lo stesso sia il destino dell’intimità: qualsiasi intimità si raggiunga, con lo stesso movimento si dilata e si approfondisce il mistero dell’altro, dell’altra e del nostro essere-divenire altro e altra.