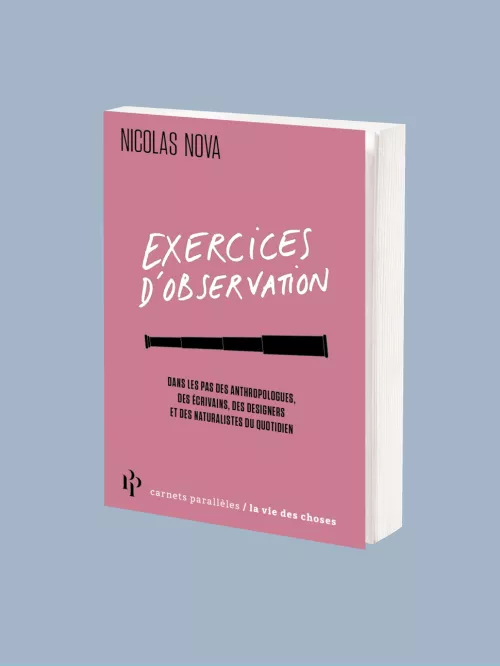L’osservazione: istruzioni per l’uso
L’idea di Exercices d’observation (Premier Parallèle) di Nicolas Nova è folgorante: scrivere un piccolo manuale di esercizi d’osservazione. La natura felicemente indisciplinata di questo designer-antropologo emerge dalle sue molteplici ispirazioni: scienze sociali (antropologia, etnografia, sociologia), scienze naturali (botanica, zoologia, geologia, ecologia e quella “scienza dei paesaggi” che è la geomorfologia), letteratura e arti visive, design incluso. I suoi esercizi vogliono risvegliare una modalità di vedere il mondo oggi poco coltivata. L’osservazione è una capacità cognitiva, un savoir faire che si apprende e si può esercitare senza grandi sforzi e qualità se non una disposizione d’animo e, naturalmente, un pizzico di pazienza. Moltiplicando i punti di vista, di scala e di posture, l’osservazione, screditata in quanto pratica passiva o noiosa, diventa così una forma di creazione di cui si giovano artisti e scrittori, storici e critici d’arte, studiosi di scienze sociali e naturali. La finalità? Interpellare la vita delle cose e degli esseri. Prima di soffermarmi sulle motivazioni dell’autore, seleziono e riformulo di seguito sette esercizi con varianti.
Esercizi
Esercizio 1. Passate dieci minuti a stilare un inventario sistematico di quanto accade attorno a voi, ovunque vi troviate. Annotate ogni cosa che attira la vostra attenzione, un movimento o una qualsiasi entità (animali, umani, piante, oggetti, veicoli, infrastrutture, pannelli e scritte varie). Insistete sul visivo come sul sonoro, sullo statico come sul mobile. A partire da questo inventario realizzate una lista con almeno trenta elementi, ripartiti in colonne e nell’ordine che preferite. Variante: per trenta minuti attraversate uno spazio abitato, che sia il centro città o una zona commerciale, registrando parole, slogan e avvertenze riportate su pannelli pubblicitari, insegne, macchine, schermi, oggetti, giornali, adesivi, vestiti. Organizzateli in un paragrafo che restituisca la vostra deambulazione pedestre o con altri mezzi, dallo skateboard alla bicicletta.
Esercizio 2. Osservate qualsiasi elemento del mondo circostante per una decina di minuti e formulate in seguito 25 domande che lo riguardano, senza cercare necessariamente una risposta.
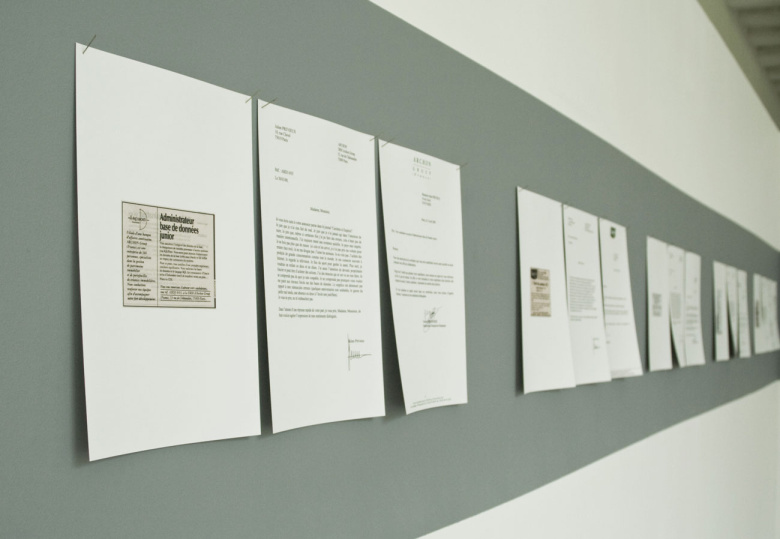
Esercizio 3. Circolate in un luogo prescelto – supermercato, quartiere, parco pubblico, appartamento di amici, foresta – cogliendo il maggior numero di elementi e annotando le vostre impressioni sull’atmosfera e su dettagli specifici. Disegnatene o fotografatene alcuni. Soffermatevi sull’organizzazione generale del luogo, identificando approssimativamente le dimensioni dei suoi elementi. Realizzate una pianta con didascalie accurate. Variante: realizzate una carta sonora di un luogo con una densità di frequentazione umana o animale (bar, foresta, piazza pubblica, spiaggia) dopo averla osservata per un paio d’ore. Restituite le fonti d’emissione dei suoni e le loro caratteristiche (volume, variazioni d’intensità), utilizzando ove necessario delle onomatopee. Altra variante: disegnate un fregio cronologico degli odori percepiti durante un itinerario in un territorio dato. Oppure: descrivete un percorso immaginario in un luogo remoto in cui non siete mai stati, utilizzando una carta digitale, Google Street View, fotografie scovate sui social, ogni tipo di documento disponibile su internet o in biblioteca.
Esercizio 4. In un luogo pubblico, disegnate schematicamente gesti e posture delle persone mentre interagiscono con diversi oggetti (smartphone, computer, giornale, libro). Non soffermatevi sui dettagli ma sulla postura, identificando movimenti e motivi ricorrenti cui darete un nome. Variante: trovate un’attività ripetuta, codificata e osservabile come la realizzazione di una ricetta di cucina o di un manufatto e documentate ogni singola operazione, gesti e interazioni, parole e terminologie, utensili e materie. Realizzate un diagramma cronologico dello svolgimento dell’azione suddiviso in tappe nel modo più dettagliato possibile.
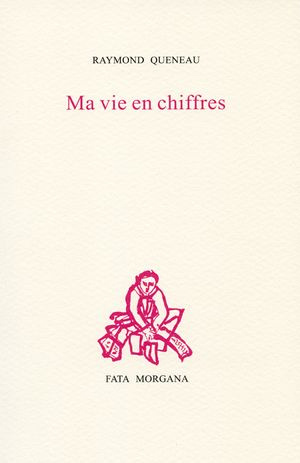
Esercizio 5. Osservate gli angoli meno accessibili e più nascosti, gli interstizi e le anfrattuosità di un territorio circoscritto (un quartiere urbano, il perimetro di una stazione, una foresta). Scattate una foto o disegnate quello che incontrate, redigendo un abbecedario, una lista, un testo strutturato in ordine alfabetico. Variante: svuotate al suolo il contenuto di un bidone della spazzatura, organizzate gli scarti per affinità, contateli, realizzate diagrammi e grafici a torta secondo criteri stabiliti quali, ad esempio, la percentuale di rifiuti organici o di un certo colore…
Esercizio 6. Prendete un oggetto qualsiasi, uno di quelli che in genere trascurate; toccatelo, palpatelo, manipolatelo, ruotatelo, odoratelo, trascrivendo le sua qualità in una lista. Variante: smontate un oggetto del quotidiano analizzando ogni sua componente, attribuendogli un nome, che sia quello tecnico o inventato di sana pianta. Tale dissezione meccanica o reverse engineering come nei centri di riparazione smartphone, cari all’autore, vi aiuterà ad affrontare il carattere opaco degli oggetti.
Esercizio 7. Selezionate un oggetto che non suscita la vostra attenzione (sacco a pelo, foglie d’alberi, joystick, segnali di divieto, graffiti) e per diverse settimane documentate i vostri incontri con questo oggetto attraverso la fotografia, il disegno o la scrittura. Identificate delle categorie e organizzatele, realizzandone infine una classificazione.
Altri esercizi, tra i diciannove proposti, prevedono infine la descrizione di attività collettive (giardinaggio urbano, visita turistica, assistenza notturna ai senzatetto, raccolta di funghi); il pedinamento pedissequo di un passante o shadowing mentre svolge le sue attività quotidiane, che ha una nobile genealogia, da Truman Capote a Sophie Calle; la rappresentazione di un oggetto percepito a distanze diverse e così via.
Come avete intuito, nessuna tiritera contro la tecnologia. Alcuni esercizi prevedono l’uso di taccuini, come quello di William Burroughs in viaggio da Tangeri a Gibilterra diviso in tre colonne: resoconto di viaggio, ricordi e citazioni tratte dai libri portati con sé. Ma molti altri necessitano dello smartphone, come la documentazione delle reti wi-fi di un luogo prescelto e la realizzazione di una loro mappa; lo stesso vale per un contatore Geiger, un misuratore della qualità dell’aria o un Pokemon Go.
Protocolli
Cosa c’è dietro Exercices d’observation? Ad accomunarli è anzitutto il protocollo di partenza, le istruzioni da seguire, in un gioco letterario che cerca la complicità del lettore. “Sforzatevi di scrivere ciò che non ha alcun interesse, ciò che è il più ovvio, il più comune, il più noioso” (Georges Perec) ma anche: “Attribuisci a tutto ciò che ti tocca il potere di farti pensare” (secondo la storica delle scienze Isabelle Stengers citata da Jean-Marc Galan), un mantra seguito da Nova.
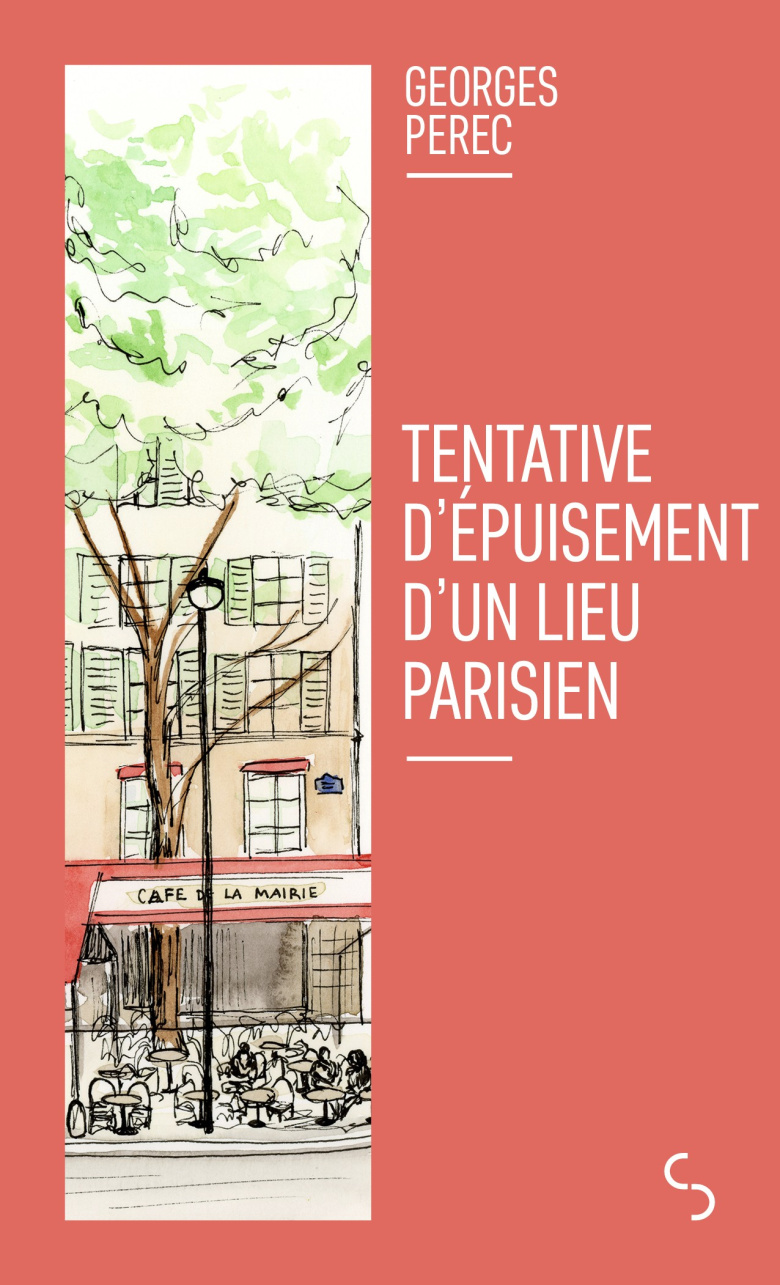
In linea generale, la trovata ingegnosa dell’osservazione sistematica del quotidiano che si fa letteratura risale a due scrittori francesi, Raymond Queneau e Georges Perec. Queneau per i suoi Esercizi di stile, da cui Nova ricava il titolo del suo libretto, dove la stessa scena ordinaria è ripresa e descritta 99 volte e ciascun texticule adotta un punto di vista diverso. Senza dimenticare il meno conosciuto Ma vie en chiffres. Quella di Queneau è “una lezione magistrale d’osservazione. Il mondo non può essere letto immediatamente [...] Noi costruiamo le nostre rappresentazioni dirigendo la nostra attenzione, cioè usando in modo meticoloso i nostri sensi – principalmente la vista e l’udito, a volte gli altri – per selezionare i dettagli che ci sembrano rilevanti su esseri, cose e luoghi” (p. 10).
Per Perec, i riferimenti vanno, in ordine cronologico, a: Tentative d’épuisement d’un lieu parisien (1983), quando Perec trascorre tre giorni a place Saint-Sulpice nel 1974 mettendo per iscritto “ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages”, carezzando classificazioni assurde quanto inutili come le forme degli ombrelli; Penser/classer (1985); L’infra-ordinaire (1989), elogio del banale, del quotidiano, dell’ordinario, del rumore di fondo dell’esistenza, al cuore di un’antropologia attenta non all’esotico ma all’endotico: fare l’inventario di quanto abbiamo nelle tasche o in borsa, contare i gesti necessari per comporre un numero telefonico (o per farsi un selfie, come diremmo oggi); i Cahiers des charges de La Vie mode d’emploi (1993), raccolta di appunti presi dallo scrittore mentre lavora a La vita. Istruzioni per l’uso. Insomma, un Perec ben conosciuto, tradotto e amato in Italia.
Cosa trae Nova da questo doppio riferimento alla letteratura potenziale? Il gusto per le contraintes, accompagnato dalla consapevolezza che anche l’archiviazione più meticolosa non sarà mai esaustiva, che “solo una frazione dei fenomeni può essere compresa” (p. 28). Tuttavia, malgrado l’ombra del fallimento, la sua utilità resta valida: “non solo ci incoraggia a produrre una sorta di poesia del quotidiano attraverso la giustapposizione di frammenti disparati, ma allena la nostra capacità di prestare un’attenzione sostenuta a tutta una profusione di dettagli anodini e di notare tra loro singolarità, insiemi e collegamenti” (p. 28).
Perché di grazia esercitare l’osservazione? Per curare la nostra alienazione: “La discrepanza tra le molteplici sollecitazioni causate dalla quantità di informazioni che ci raggiungono attraverso i media digitali e le limitate capacità cognitive a nostra disposizione per recepirle lascia un’impressione di accelerazione” (p. 12). Gli esercizi rispondono al nostro “deficit patologico dell’attenzione” analizzato da Yves Citton (Pour une écologie de l’attention, Seuil 2014), alla “nostra difficoltà a prestare attenzioni alla diversità degli esseri che popolano il mondo” (p. 11).
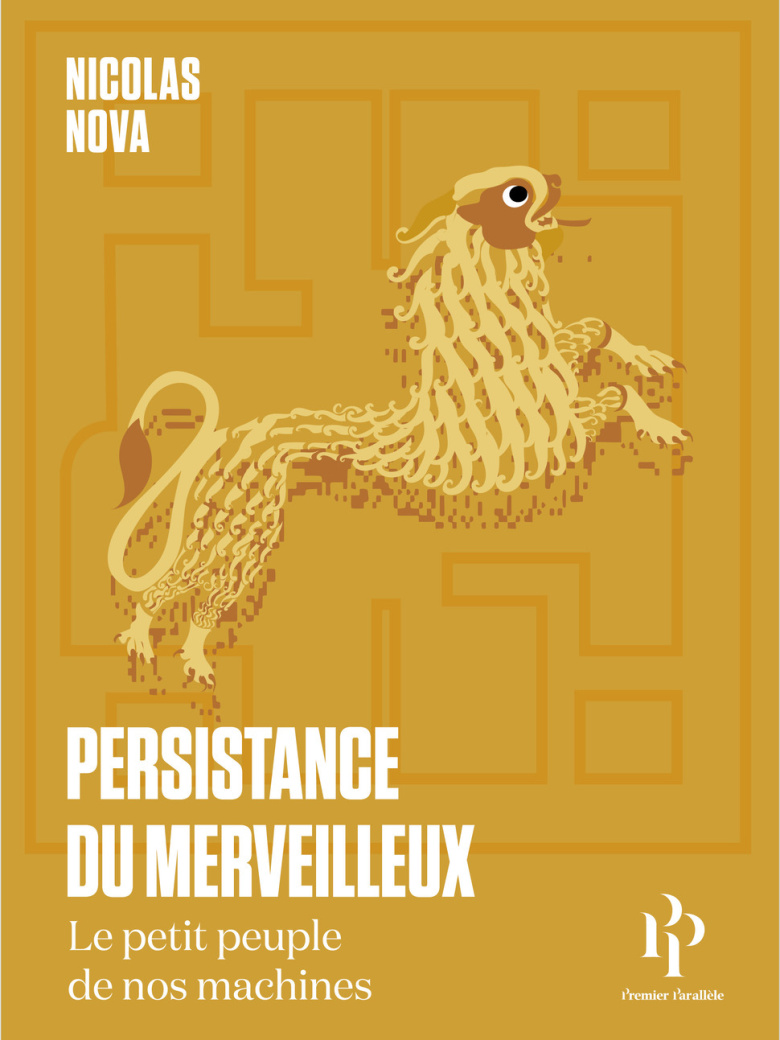
Il rapporto con l’arte contemporanea non manca, dalle istruzioni per comporre una poesia dada di Tristan Tzara all’arte concettuale, dalle pratiche situazioniste a Sophie Calle, dalla urbex (esplorazione urbana) alle pratiche performative che mettono in gioco il corpo dell’artista fino alle lettere di non-motivazione di Julien Prévieux. Tuttavia il ruolo centrale spetta alla letteratura, nel suo rapporto, a volte inconfessato, con le pratiche più sperimentali delle scienze sociali e naturali.
Azioni
Nelle ultime pagine Nova ammette che i suoi esercizi non sono altro che suggerimenti per esplorare ulteriormente le “arts de remarquer”, al punto che i lettori sono invitati a condividere le loro proposte con l’autore. E mai come in questa occasione siamo invogliati a contribuire a una seconda edizione del libro. Exercices d’observation si chiude con l’indirizzo email dell’autore – col suo indirizzo non professionale ma privato, nome-punto-cognome per esteso. Un’apertura al dialogo e una generosità che mi colpiscono ma che, rimettendo il libro in tasca sicuro che mi accompagnerà ancora a lungo, mi rattristano profondamente.
Perché Nicolas Nova, nato nel 1977, è scomparso improvvisamente il 31 gennaio 2024 a soli 47 anni, nel corso di un trekking in Oman, e Exercices d’observation resta il suo penultimo (diciottesimo!) libro uscito nel 2022 (a novembre 2024 è uscito Persistance du merveilleux. Le petit peuple de nos machines, Premier Parallèle).
Abbiamo bisogno di fuoriclasse come Nova. Ci mostrano che un intellettuale è colui che sente e non che sa, che non si distingue cioè per quanto ha letto e visto ma per la capacità di mantenere accesa una curiosità quasi infantile verso il mondo, la capacità di entusiasmarsi e vedere in ogni riflesso del quotidiano un’avventura del pensiero, un’occasione per mettersi in cammino, una sfida imprevista. “Il pensiero di Nicolas era soprattutto un coup d’œil, un’ipersensibilità per l’insignificante, un rispetto per il bizzarro e un’ermeneutica dell’inatteso” (Jean-Marc Galan).
Sta a noi adesso ingegnarci per trovare altri esercizi d’osservazione, che sia intensa, canalizzante, profonda o, al contrario, intermittente, fluttuante, sfocata, perché a interessarci non è un’economia ma un’ecologia dell’attenzione. Certo, quelli proposti da Nicolas Nova ci terranno occupati un bel po’, sufficienti per reinventare il quotidiano, per impregnarci di mondo, per cogliere il potenziale e la pluralità di quei possibili che aspettano solo di essere adeguatamente osservati. Davanti a Exercices d’observation non ci sono alternative: dobbiamo passare all’azione, armati di carnet, penna e smartphone.