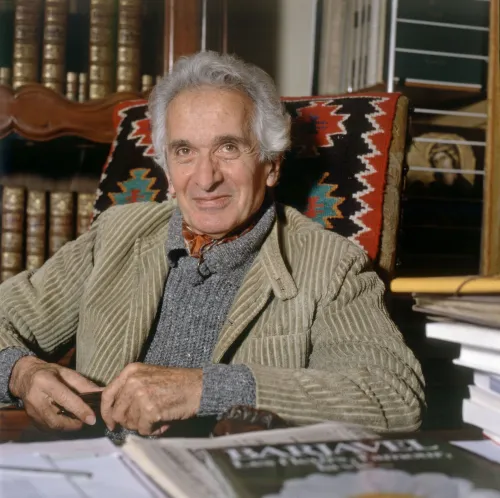Le distopie di René Barjavel
Da qualche tempo vengono riproposti, anche al di fuori dei circuiti specialistici, alcuni classici della fantascienza come ad esempio: L’Uomo che cadde sulla Terra di Walter Tevis con Minimum fax, Picnic sul ciglio della strada dei fratelli Strugatzki con Marcos e Marcos e vari titoli dispersi di Stanislaw Lem con Mondadori. Si affianca ora l’editrice L’Orma con il francese René Barjavel, autore poliedrico e discusso nato nel 1911. Impegnato in un giornale quotidiano incontra da giovane una persona decisiva per il suo futuro, l'editore Robert Denoël di Parigi del quale accetta la proposta di lavoro. Mantiene pur sempre in modo forte e quasi dominante l’interesse per il cinema come sceneggiatore e critico. Infatti nel 1944 esce il visionario Cinema totale. Saggio sulle forme future del cinema (Editori Riuniti 2001) in cui anticipa strade contemporanee (ad esempio il cinema 3D, i film senza pellicola e l'archiviazione su disco) e prevede l'impatto sociale degli allora embrionali mezzi di comunicazione (radio, cinema e tv). Adattatore, sceneggiatore e dialoghista si impegna in numerosi film, alcuni con Totò (Totò a Parigi del 1958 per la regia di Camillo Mastrocinque), altri con la serie di “Don Camillo” del 1952-53 per la regia di Julien Duvivier per il quale lavorerà come sceneggiatore di La gran vita,1960 e Le tentazioni quotidiane,1962. Offre al regista Cayatte il soggetto di Katmandu, sceneggia il film I miserabili con Jean Gabin, traduce i dialoghi del viscontiano Gattopardo per la versione francese. Sarà poi influenzato dall’incontro con Gurdjieff, il soggiogante pensatore armeno che, tra esoterismo e filosofia, incrociava la scuola mistica dell’islam con le tradizioni religiose quali ebraismo, cristianesimo, sikhismo, buddhismo, induismo. Barjavel ricorda: “Lo incontrai una volta soltanto a una delle cene in cui era contornato di discepoli. Lui sogghignò, gli piaceva mettere in imbarazzo chi gli si avvicinava per la prima volta. Aveva un temperamento vulcanico: era una montagna ruggente ma preferii arrestarmi al ruscello che scorreva intorno a essa. So di aver bevuto alla fonte della verità da cui sgorga tutta la saggezza del mondo, da dove si sono formate tutte le religioni”. Esce il primo romanzo nel 1943 dal titolo Ravage (in Italia appare come Diluvio di fuoco per Urania nel 1957 e ora come Sfacelo per L’Orma nel 2019). Inappagato e vulcanico si inoltra in svariati mondi narrativi, dai romanzi ‘straordinari’ precursori della fantascienza, ai romanzi d’amore come Turendol nel 1946 (ora L’Orma 2023), di cui Julien Duvivier acquisisce i diritti per una miniserie televisiva nel 1980. Sensibile a problemi contingenti Barjavel fa uscire nel 1946 Béni soit l'atom (Benedetto sia l'atomo, Visto, 1958, anno VII, n. 51) e nel 1948 Le diable l’emporte (non tradotto) sulla questione della terza guerra mondiale che si inserisce nella letteratura del dopoguerra resa nota da Cronache del dopobomba di Philip K. Dick e da Io sono leggenda di Richard Matheson. Sempre nel 1948 pubblica Il viaggiatore imprudente (Garzanti, 1999), scrive canzoni, si dedica alla fotografia a colori e i suoi scatti vengono raccolti nel volume Les fleurs, l'amour, la vie. Gli anni ’60 lo vedono attratto dai temi del Maggio francese evocati in La notte dei tempi del 1968 (L’Orma, 2020) dedicato al regista Cayatte, e vincitore del ‘Prix des libraires’. Nel 1978 si impegna in un acceso pamphlet contro le armi nucleari ( Lettre ouverte aux vivants qui veulent le rester, non tradotto) e nel 1984 stupisce con Il mago M., riscrittura moderna della saga dei cavalieri della Tavola Rotonda con un mago Merlino inconsueto, innamorato di Viviana ma nel contempo concentrato nella ricerca del Graal. Nel 1985, anno della morte, viene pubblicato un suo giallo, La peau de César, (non tradotto), ambientato durante una rappresentazione teatrale del Giulio Cesare di Shakespeare a Nîmes. Il successo però non riesce a offuscare alcuni problemi non indifferenti, tra tutti l’accusa di aver partecipato alla rivista collaborazionista “Je suis partout” che aveva sostenuto la destra filofascista, le pubblicazioni neonaziste e l’ l'antisemitismo, appoggiando ad esempio la colpevolezza di Dreyfus con la penna di Lucien Rebatet (di cui ora I due stendardi, Edizioni Settecolori, 2021), Barjadel viene così inserito, sconfitto il fascismo, nella lista nera dal “Comité national des écrivains” e sarà scagionato solo da una lettera di Georges Duhamel, scrittore oggi noto in Italia, seppur tardivamente, per alcuni romanzi (Confessione di mezzanotte, Ago 2023, Due uomini, Ago 2025, vedi recensione in doppiozero). La sinistra comunista alla sua morte sull’Humanité gli nega il perdono: “benché indossasse gli occhiali restò cieco al senso della storia, alle sorti dei suoi concittadini”.
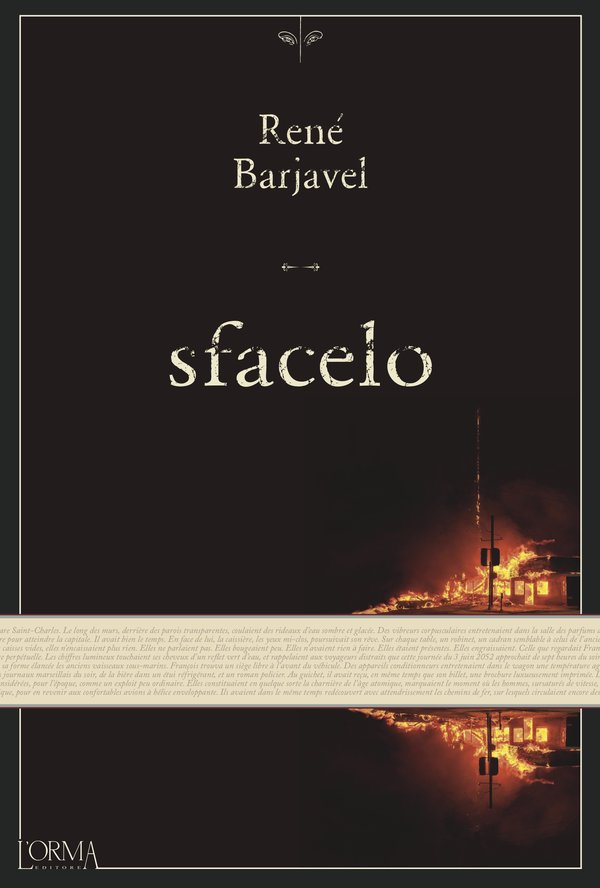
Tre suoi romanzi (Ravage, Viaggiatore imprudente, La notte dei tempi) si collocano tra le profezie negative e due di essi (Ravage nel 1943, Viaggiatore imprudente nel 1944) escono in anni in cui la fantascienza americana non ha ancora “colonizzato l’immaginario europeo” come osservato da taluno. I romanzi di Barjavel sono quasi dei prototipi, quando ancora in Francia si parla di «romanzo scientifico» alla Jules Verne anche se autori di quel mondo sono ormai scomparsi come Régis Messac (Quinzinzinzili, Tlon, 2023 ) e Jacques Spitz (Incubi perfetti, Urania n. 1510, 2006), mentre furoreggiano i romanzi di anticipazione di J.-H. Rosny Aîné (Guerra del fuoco, Nord 2000), Albert Robida (Re delle scimmie, Homo scrivens 2023) e Maurice Renard. (Le mani d’Orlac, Delitti d’oltralpe, Giallo Mondadori 87 del 2018).
In Ravage, del 1943, ambientato nel 2052, il protagonista François Deschamps, figlio di agricoltori, si reca a Parigi per studiare e ritrova un’amica di infanzia, Blanche. Costei, attrice, cantante, modella, affascinata dalla città, è oggetto delle attenzioni dell’uomo di affari Jérôme Seita, che si impegna nel fare di lei una star ottenendo nel contempo la promessa di matrimonio. Proprio la sera del debutto della ragazza in televisione si verifica però un’apocalisse energetica che distrugge le infrastrutture. La corrente elettrica è interrotta, i metalli ferrosi diventano incandescenti, le auto si fermano, gli aerei cadono, i treni rimangono senza freni e motore. Non si riesce a comprendere l’accaduto anche se prende corpo la convinzione che quanto si verifica sia la conseguenza dell’eccessiva dipendenza dalle “macchine”. Il racconto è disseminato di invenzioni a dire il vero strabilianti. I treni sono ultra rapidi a supporto magnetico, la propulsione nucleare è sostituita da carburante ad acqua di mare, i taxi sono a decollo verticale, i libri audio si diffondono a macchia d’olio, il visiophone mostra il volto dell’interlocutore, i vestiti sono sintetici, aderenti, chiusi con bottoni magnetici, le macchine e i mobili sono di “plastec”, materiale chimico resistente e morbido, l’alimentazione è assicurata da lavorazioni che fanno germogliare il frumento sotto radiazioni e le biotecnologie sono dominanti come lo è la carne sintetica con palesi ripercussioni sul lavoro degli agricoltori. La popolazione cresce a dismisura, e attorno a Parigi, che conta ormai 25 milioni di abitanti, crescono citta satelliti. Il romanzo risente del clima in cui è stato scritto, degli anni in cui si vagheggiava l’uscita dalla città, il ritorno alla campagna, il richiamo a valori semplici ed essenziali, al lavoro manuale non soggetto alla tecnica, alla gerarchia naturale, all’autosufficienza della comunità.
Il viaggiatore imprudente del 1944 ha un taglio completamente diverso, sollecita la fantasia con tagliente umorismo e vi compare per la prima volta il cosiddetto “paradosso del nonno”. Utilizzato nelle discussioni sul rapporto spazio-tempo, esso espone come esempio classico il viaggiare nel passato per tornare a far visita al nonno. Il viaggio riesce, ma il nonno è giovane e non si è ancora sposato con quella che diventerà la nonna. Se si uccide il nonno oppure lo si distrae dalla vita normale, potrebbe non presentarsi all'appuntamento con la ragazza che diventerà la nonna. Di conseguenza i genitori e il viaggiatore non nascerebbero, ma in questo caso come si sarebbe potuto impedire ai nonni di incontrarsi? È questo un tema tipico della fantascienza di cui Barjavel fu l’iniziatore, e lo si trova anche in film come The Time Machine da La macchina del tempo di H. G. Wells e di recente in Interstellar di Nolan in cui il protagonista, entrando in un buco nero, riesce a viaggiare in un multiverso cercando di cambiare eventi del passato. Ma soprattutto è dominante nel film-trilogia Ritorno al futuro di Zemeckis in cui il protagonista, viaggiando nel tempo, avrebbe impedito ai genitori d'incontrarsi e sarebbe dovuto scomparire dalla realtà in quanto mai nato.
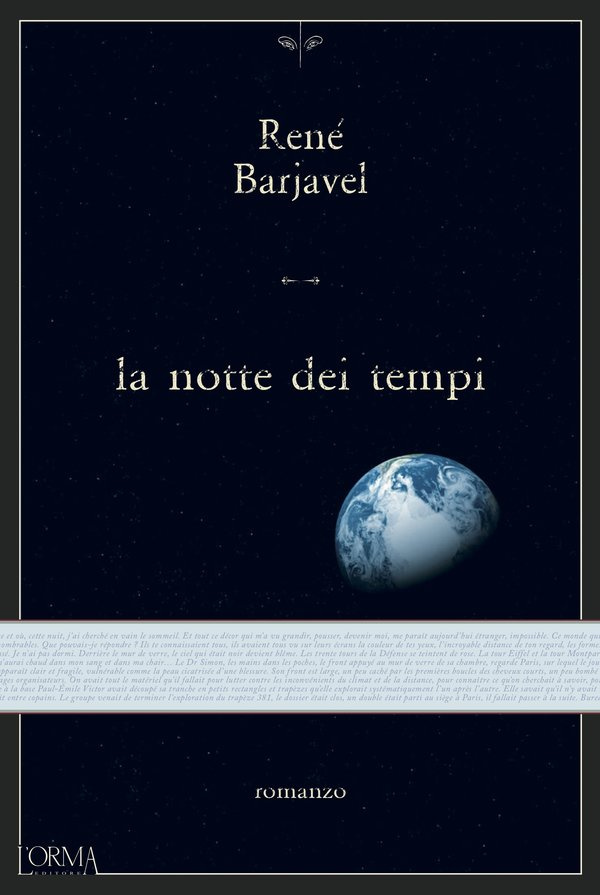
Nel 1968 Barjavel pubblica La notte dei tempi in cui sviluppa idee della fantascienza degli anni ’50, come l’ apocalisse e la fine del mondo. Prende le mosse da una spedizione scientifica in Antartide che effettua rilevamenti sotto il ghiaccio quando le sonde registrano un segnale proveniente da 900 metri di profondità. Nella roccia vengono trovati resti di una civiltà antichissima e riemergono due corpi ibernati da quasi un milione di anni. Cosa è capitato a quella civiltà scomparsa? Per rispondere il lettore viene immesso in una ambientazione fantastica, nella magia dell’inatteso, nell’evocazione proveniente da antiche rovine di per sé già affascinanti come ricorda Marc Augé in Rovine e macerie (Bollati Boringhieri, 2004). La notte dei tempi rievoca due civiltà in lotta tra di loro, Gondawa e Enisorai. Gondawa è una società quasi perfetta, organizzata in modo da garantire la sopravvivenza della flora e della fauna, in cui i cittadini dispongono di una chiave personale e trasmissibile multifunzionale. Esistono però svantaggi in quanto non si possono esercitare diritti civili, politici o qualunque altre libertà, si vive sorvegliati dallo Stato, non c'è libertà di pensiero tanto che anche nella scelta del partner funziona il rito della “Designazione” attraverso una sorta di computer che "non sbaglia”, con ripercussioni inevitabili sulla formazione delle strutture familiari. L’obiettivo è creare una società saggia e perfetta, ma il prezzo da pagare è l’eliminazione della democrazia e dell’autodeterminazione. I cittadini di Enisorai invece rassomigliano a popolazioni autoctone, spontanee, soggette però a persecuzione. Essi vivono con una struttura basata, al contrario di Gondawa, sulla libertà di fatto dell'individuo che possiede, tra l’altro, l'energia universale di Zoran sfruttabile non per portare la guerra ad altri, ma solo per produrre armi da difesa. La trama narrativa è imperniata su questo confine, tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, anche e soprattutto nell'uso di questa “energia”. Il recupero di questi mondi del passato fa riemergere immagini bibliche, come la coppia perfetta ed ibernata di Eléa e Paikan, che vivono in un amore perfetto di dimensione mistica. Eléa, riportata in vita, è il punto di contatto col passato e grazie a lei gli scienziati conoscono la vita di 900.000 anni addietro, la società di quel tempo, il rito della Designazione, gli Enisorai, la guerra e quant’altro. La decisione della donna di darsi la morte viene presa avendo avuto costei la consapevolezza di non poter più vivere senza Paikan e dopo aver rievocato gli eventi dolorosi della guerra tra Enisorai e Gondawa. Simon, lo scienziato della spedizione, ha nei confronti di Eléa una reazione particolare, se ne innamora e vuole comunicare con lei per diventare lui protagonista del dialogo con la società gondawiana. Ben presto però, il suo desiderio soccombe alla passionale relazione di Eléa con Paikan. Nelle immense distese polari, nel freddo e in condizioni climatiche estreme, in una "cornice di cristallo e ghiaccio", sembra delinearsi da quelle rievocazioni la possibilità di un mondo migliore che svela anche il mistero dell'origine e della riconquista del paradiso perduto. L'uomo della base polare rievoca la civiltà perfetta, o quella che crede tale, di Gondawa, mentre oggi dominano antichi rancori, antagonismi militari, ci si ributta verso il male promuovendo i più svariati tentativi di distruzione operati anche dalle scoperte scientifiche.
Quel castello di sabbia eretto dalla spedizione polare, diffuso di pace e armonia, viene improvvisamente distrutto da una tempesta di neve, e così, condannata a subire il furore della natura che quasi sembra ribellarsi, la stazione polare è evacuata.
Gli scritti di Barjavel, come già sottolineato, hanno una cifra specifica e si inseriscono nella tradizione letteraria dell’apocalisse, rievocata come monito per l'uomo il quale, sentendosi onnipotente, interviene sulla natura direttamente con i suoi comportamenti oppure in modo mediato attraverso l’uso della tecnica. Il posto dell'uomo nella natura è per Barjavel una riflessione costante, essendo egli attento a un’umanità proiettata verso un futuro dominato da un irrefrenabile bisogno di comfort grazie anche alla tecnologia (tema attuale confermato ancora di recente, cfr. Apocalisse, ora. Fine della storia e coscienza escatologica a cura di G. Gaeta L. Lenzini, Quodlibet 2025).
Il futuro in realtà non è, come un tempo si vagheggiava, radioso, spinto verso “magnifiche sorti e progressive”. È dominato invece dalla capacità autolesionistica dell’uomo pervaso da una cecità che impedisce di vedere quanto gli sta accadendo attorno. L’umanità ha paura di questo futuro fosco, cerca di tenerlo lontano, incatenata da insicurezze diffuse. Questo pessimismo appare invincibile, forse anche perché l’umanità sembra spingere se stessa verso la propria distruzione e si blocca nel presente perché teme un futuro nero. Vive così una sorta di “iperpresente”. E la distopia intuisce quelle inquietudini, si confronta con un immaginario pessimista e con quote di realismo fornisce un deterrente per evitare una società prossima e indesiderabile.
Questa ispirazione ha incontrato consensi e successi anche attuali, pur essendosi autorevolmente osservato che non c’è “mai stata un’epoca che non abbia creduto di essere davanti ad un abisso, pervasa dalla coscienza disperata di stare in una crisi decisiva, qualcosa di cronico dell’umanità,” (W. Benjamin, Passages di Parigi, Einaudi, 2010).