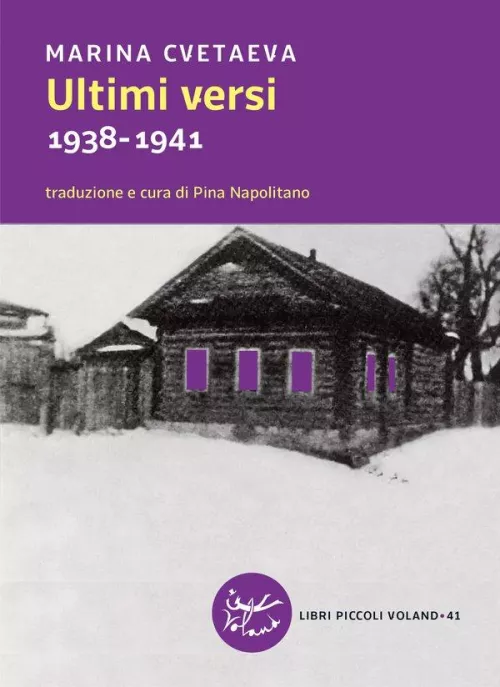Gli Ultimi versi della grande poetessa / Marina Cvetaeva, Diario dell’ammutolire
Un atteggiamento di resa, di composta rassegnazione, l’amara consapevolezza dell’approssimarsi della fine percorrono gli Ultimi versi di Marina Cvetaeva (1892-1941), i pochi, ultimi versi compiuti che scrive tra il 1938 e il 1941, nei quattro anni precedenti il suo suicidio. La posterità ha di certo potuto facilmente etichettarli come ultimi, mentre non è facile stabilire da quale momento anche Cvetaeva li percepisse come tali. Forse quelli dell’ultimo anno di vita, dove ricorre l’immagine della morte: «È tempo di spegnere la lanterna / sul portone» scrive il 7 marzo 1941, nell’ultima breve poesia che chiude la raccolta. Cinque mesi dopo, la poetessa che Iosif Brodskij ha definito la più grande del XX secolo, si toglierà la vita. In verità Brodskij usa il genere maschile – poeta, e non poetessa – per rimarcare l’assoluta grandezza, l’universalità senza attenuanti, il suo gareggiare nella stessa categoria degli uomini, e non in una categoria a parte, solo femminile. Oggi che il dibattito sul genere delle professioni, sull’uso dello schwa e simili è diventato un terreno di accesa e discutibile rivendicazione, il riferimento a una poetessa al maschile non passa inosservato, ma dopotutto anche Cvetaeva chiamava se stessa ‘poeta’.
«Diario del progressivo ammutolire» ha definito gli Ultimi versi Pina Napolitano, traduttrice e curatrice del volume, edito da Voland in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla morte della poetessa. L’ammutolire trova riscontro nell’esiguo numero di versi che Cvetaeva scrive nella fase finale della sua vita, soprattutto se si paragonano questi pochi componimenti alla prolificità della giovinezza. Aveva cominciato a scrivere versi in tenerissima età, non solo in russo, ma anche in francese e in tedesco, la seconda lingua della sua infanzia, imparata dalla madre, figlia di un tedesco del Baltico. La scrittura è ciò che dà senso alla sua esistenza: «Se mi portassero oltre l’oceano, in un paradiso in cui mi proibissero di scrivere, rifiuterei oceano e paradiso» scrive all’amica cecoslovacca Anna Teskovà, con cui ebbe una corrispondenza durata diciassette anni. L’ammutolire è dunque segno di patimento, sofferenza, separazione, esasperati probabilmente dal loro protrarsi nel tempo.
Se infatti negli anni ‘20 il dolore per la scomparsa della figlia Irina, morta a soli tre anni per malnutrizione, fu la molla della sua esplosione creativa (La principessa guerriera, Il campo dei cigni, Separazione, Mestiere, Psiche, Dopo la Russia solo per citare alcune raccolte), diversa è la sua reazione alle avversità in età matura. Nel 1938, l’ultimo anno della sua emigrazione, Cvetaeva si trova a Vanves, sobborgo di Parigi e confida all’amica Teskovà che non trova pace nell’animo e che per tutto l’inverno non ha scritto nulla. Cvetaeva aveva lasciato l’URSS sedici anni prima, nel 1922, per ricongiungersi al marito, Sergej Efron, ufficiale dell’Armata bianca con cui si era stabilita in Cecoslovacchia. Qui avevano vissuto per tre anni prima di partire per la Francia.
È proprio la Cecoslovacchia uno dei temi centrali degli Ultimi versi. Il pretesto per cantare la Boemia, il «ceco paradiso» amato e rimpianto, arriva in seguito all’annessione dei Sudeti alla Germania di Hitler, avvenuta in quello stesso 1938 poeticamente infruttuoso per Cvetaeva. «Paese di ampiezza / e di abbondanza. Un solo / dolore: manca ai cechi – il mare». Si apre così il componimento Settembre del breve ciclo Versi per la Boemia, dove il paese che la ospita nei suoi primi anni di emigrazione viene esaltato nei suoi elementi naturali, nelle ricchezze minerarie, nella mitezza.
Piangendo la perduta libertà di questo «Eden» in cenere, Cvetaeva maledice la Germania predatrice e augura prosperità al popolo boemo. La Cecoslovacchia fu uno dei centri più accoglienti dell’emigrazione russa in Europa, dove ripararono soprattutto studiosi e studenti che a causa della guerra e della Rivoluzione non erano riusciti a concludere i loro studi. Grazie alle elargizioni del governo cecoslovacco furono finanziate varie istituzioni culturali tra cui un’università russa, fondata negli anni ’20.

Qui nel 1925 era nato il terzo figlio della poetessa, Georgij, detto Mur, che avrebbe dovuto chiamarsi Boris in onore di Pasternak. Agli anni del soggiorno ceco risale tra l’altro l’inizio della corrispondenza platonicamente amorosa tra Pasternak e Cvetaeva, due anime affini che condivisero la stessa solitudine, e che riuscirono ad incontrarsi di persona solo dodici anni dopo, nel 1935, in quello che la Cvetaeva, forse delusa, avrebbe definito un ‘non-incontro’ (nevstreča).
Il non-incontro era avvenuto a Parigi, al congresso internazionale degli scrittori. Cvetaeva era arrivata in Francia esattamente dieci anni prima, nel 1925. È qui che si accorse di amare profondamente la Cecoslovacchia, di quell’amore che la poetessa tipicamente rappresenta come rottura e preclusione, mai come condivisione, compiutezza o appagamento. L’amore per ciò che è precluso si manifesta poi anche nei confronti della Francia. «Non c’è della Francia / per me più dolce paese» scrive nel componimento Douce France, in cui il luogo in cui ha vissuto a lungo da emigrata viene guardato, nonostante l’emarginazione e l’estrema povertà patite, con l’idealizzazione nostalgica dell’imminente distacco. La poesia risale infatti al 5 giugno 1939: otto giorni dopo partirà con Mur per raggiungere il marito e la figlia Ariadna, stavolta in URSS: «Salpare mi spetta / come Marie Stuart». Tornata in URSS, Cvetaeva dovette vivere in incognito, senza documenti, senza i propri bagagli che contenevano anche i suoi libri e manoscritti e che arrivarono un anno dopo. Alla fine dell’estate fu arrestata la figlia e in autunno il marito. Cvetaeva e Mur furono ospitati a Mosca, nell’appartamento in comune in cui alloggiava la cognata e dove dormirono in un’anticamera, su dei bauli: apoteosi della provvisorietà. Qualche tempo dopo trovarono una sistemazione vicino Mosca, nella Casa di riposo degli scrittori.
A questo periodo fa riferimento il secondo nucleo tematico degli Ultimi versi, quello della vecchiaia. Di ritorno dalla Francia, Cvetaeva aveva accolto la vecchiaia congedandosi definitivamente dalla giovinezza, racconterà la figlia Ariadna alla zia, nel 1944. «Una volta a un coetaneo (oh rame / dei miei capelli! Viva vena!) / giurai di non invecchiare» scrive alla fine del 1940, all’età di quarantotto anni, quando la vecchiaia è avvertita con maggior intensità in rapporto all’amore, o all’infatuazione, come si preferisce definire le molteplici passioni di Cvetaeva. Alla Casa di riposo degli scrittori si invaghisce del giovane filologo Evgenij Tager. «Basta! Per questo fuoco / sei vecchia!» e ancora «Sciocca! Per amare sei vecchia» scrive in due componimenti del gennaio 1940. Tager, sposato, tiene a bada le attenzioni della poetessa e, quando parte per Mosca per raggiungere la moglie, lei accusa il colpo: «Se n’è andato – digiuno: / insipido il pane […] era pane per me, / era neve. Nera la neve, / inviso il pane».
Siamo al 1941. La morte ormai prossima è presenza tangibile in due delle tre poesie di quest’ultimo anno di vita. «Piuttosto che spauracchio tra i vivi / uno spettro voglio essere – con i tuoi» recita uno dei versi della poesia che scrive in risposta a La tavola preparata per sei, componimento che il poeta Arsenij Tarkovskij aveva dedicato ai suoi familiari scomparsi. Invaghitasi del giovane collega, Cvetaeva è risentita per essere stata esclusa dalla tavolata e immagina allora di sedere, la più mesta di tutti, al settimo posto, non apparecchiato. Anima viva tra i morti, Cvetaeva si appresta però a compiere gli ultimi gesti rituali prima che cali la tenebra. «È tempo di togliersi l’ambra», scrive nella poesia che chiude la raccolta, e infine la chiosa: «è tempo di spegnere la lanterna». Poi il buio.
Alla sua morte rimanda la foto in copertina della dača di Elabuga, circondata dalla neve e scattata senz’altro in una stagione diversa rispetto all’agosto 1941, quando Cvetaeva vi si impiccò. Morì qui, separandosi infine da Mur, che fu ucciso al fronte tre anni dopo e che probabilmente l’aveva tenuta in vita fino ad allora. Quando era ancora a Parigi, nel 1938, la poetessa aveva confidato allo scrittore e critico Mark Slonim di voler morire, ma di dover vivere per Mur, visto che ad Ariadna e Sergej non serviva più. Il suicidio fu dopotutto l’estrema via di fuga – e forse neanche la più difficile – per quella generazione che, come scrisse Jakobson, aveva dissipato i suoi poeti. «Non crediate che si sia uccisa» disse Anna Achmatova ad Ariadna Efron, «quel tempo l’ha uccisa, come ha ucciso tanti, come ha ucciso me».