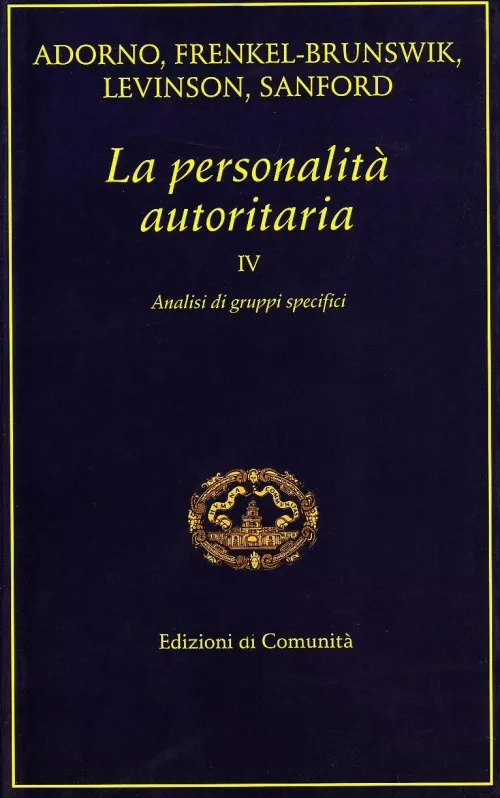Speciale
La scuola di Francoforte 2 / Jervis: introduzione a "La personalità autoritaria"
Nella Germania degli anni Venti, all’indomani della pesante sconfitta subita nella prima Guerra Mondiale, negli anni della crisi politica ed economica, si è prodotta un’inedita ridefinizione delle prospettive critiche e degli approcci metodologici e cognitivi ai diversi campi del sapere.
Si è iniziato ad esempio a osservare la letteratura dalla prospettiva sociologica, la filosofia da quella economica, la sociologia dalla specola della psicoanalisi e la storia dell’arte da quella della fisiologia umana.
Il progetto della scuola di Francoforte si definisce in questo clima culturale di profonde trasformazioni, soprattutto a partire dalla direzione di Max Horkheimer, ossia dal 1931.
Con la pubblicazione dal 1932 della Zeitschrift für Sozialforschung la Rivista per la ricerca sociale l’istituto divenne un luogo di ricerche interdisciplinari a cui parteciparono a vario titolo figure come Theodor W. Adorno (1903-1969), Walter Benjamin (1892-1940), Erich Fromm (1900-1980), Siegfried Kracauer (1889-1966), Leo Löwenthal(1900-1993) e Herbert Marcuse (1898-1979).
Doppiozero presenterà alcune sequenze di questa ricerca, a partire dalla questione di quale sia il ruolo della filosofia e del pensiero critico in un mondo in cui le persone diventano cose e i rapporti umani sono segnati dalla mera strumentalità. Presenteremo una selezione di passaggi intorno al problema della progressiva disumanizzazione del mondo a cominciare dalla messa a fuoco della personalità autoritaria e della cura pedagogica per prevenire la distruzione delle minoranze e degli avversari politici.
Lo scopo è di riportare all’attenzione un pensiero che riteniamo ci interpelli anche oggi e ci offra strumenti di analisi utili per capire la nostra contemporaneità.
(Roberto Gilodi)
Nel 1950 con il titolo The Authoritarian Personlity furono dati alle stampe gli esiti di uno studio interdisciplinare avviato nel 1944 e concluso nel 1949 sulle componenti psicologiche dell’antisemitismo. Di questo studio, promosso dall’American Jewish Committee, erano autori T.W. Adorno, E. Frenkel-Brunswik, D.J. Lewinson, R. Nevitt Sanford.
Il lavoro si basava su una ricerca empirica condotta su campioni rappresentativi della società bianca americana tradizionale, quindi escludendo gli appartenenti a minoranze etniche e religiose. Si trattava prevalentemente di membri di organizzazioni come sindacati, università, scuole, associazioni. Le persone prescelte – in tutto 2099 – venivano sottoposte a test che indagavano sia la loro condizione sociale sia soprattutto aspetti legati alla loro sfera psichica come la mentalità, le convinzioni etiche, l’immaginario, le fantasie.
Questo studio apparve in traduzione italiana nel 1973 suddiviso in due corposi tomi presso le Edizioni di Comunità con un’introduzione dello psichiatra Giovanni Jervis.
Diamo qui di seguito la parte centrale di questo saggio introduttivo preceduta da una serie di interessanti osservazioni che Jervis ha fatto intorno alla genealogia teorica che ha ispirato questa ricerca. Il riferimento principale sono, secondo lui, gli studi comparati di psicoanalisi e sociologia avviati negli anni Trenta da alcuni membri della Scuola di Francoforte. Soprattutto da Erich Fromm, che diede un contributo fondamentale agli Studien über Authorität und Familie pubblicati a cura di Max Horkheimer a Parigi nel 1936. Proprio questo volume può essere considerato l’antefatto fondamentale dello studio su La personalità autoritaria tra i cui precedenti Jervis ricorda anche Escape from Freedom del 1941, anch’esso di Fromm, e il saggio di A.H. Maslow, The Authoritarian Character Structure, pubblicato nel “Journal of Social Psychology” nel 1943, e infine il celebre capitolo “Elementi di antisemitismo” in Dialettica dell’illuminismo di Horkheimer e Adorno del 1947.
Lo sterminio degli ebrei d’Europa, di cui si iniziava a intravvedere in quegli anni le proporzioni reali, è stato certamente il motivo drammaticamente attuale della ricerca americana del 1950. A guidarla era però la consapevolezza, maturata in seno alla Scuola di Francoforte a partire dalla conquista del potere da parte di Hitler, della stretta relazione che ha legato quel regime, le sue basi ideologiche e la costruzione sistematica dell’immagine del nemico alla disponibilità di sottomettersi ad una logica del dominio autoritario che comportava l’esautorazione della responsabilità e della volontà individuale.
Il saggio di Giovanni Jervis mette a fuoco il quesito centrale della ricerca americana, vale a dire: chi è l’individuo anonimo che dà il suo convinto sostegno al fascismo, all’eliminazione di chi è diverso per provenienza etnica o per appartenenza nazionale e religiosa. Al di là delle cause storiche che hanno determinato le svolte politiche autoritarie, quali erano le basi psicologiche del loro consenso di massa?
Lungo questa direttrice di ricerca si scoprono indizi che permettono un provvisorio identikit di un soggetto in cui è visibile l’“associarsi di fattori istintuali con mediazioni culturali ancora largamente oscure, con tradizioni familiari e variabili personali”.
Un effetto ravvisabile di questo concorso di fattori è la tendenza che questi individui manifestano all’“etnocentrismo”. E qui Jervis nota acutamente come ad esso si accompagni spesso una disposizione paranoica in cui alla rappresentazione de-realistica dell’altro fa da pendant la sua criminalizzazione.
L’esclusione violenta del diverso e la fissazione identitaria sul proprio etnos sono stati e sono tuttora il brodo di coltura delle diverse forme di fascismo.
Commentando gli esiti della ricerca americana Jervis sottolinea come il modello di spiegazione scelto dal team di studiosi abbia privilegiato la spiegazione “psicologico-sociale” del fascismo rispetto alla spiegazione “storico-politica”. Per quanto negli anni Settanta apparisse riduttiva questa ipotesi, Jervis già allora ne sottolineava la perspicuità affermando che “il diritto di cittadinanza della psicologia sociale tra le scienze dell’uomo continua a scaturire anche oggi dalla necessità di sapere attraverso quali meccanismi gli individui elaborano i dati a loro forniti dal mondo storico”.
Il saggio di Jervis ha il merito di illuminare una questione tuttora controversa, ossia se il fascismo possa risorgere dalle sue ceneri storiche e se possano o meno essere considerate forme di fascismo le politiche di ispirazione etnocentrica proposte e praticate oggi da alcune forze politiche di destra e di estrema destra. Jervis ci spiega che comportamenti di questo tipo non sono spiegabili sul piano della comparazione storica ma sul terreno delle degenerazioni psichiche e alla luce dei meccanismi proiettivi della colpa e dell’aggressività.
Segue ora brano di Giovanni Jervis tratto dalla sua “Introduzione” a Theodor Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel Levinson e Nevitt Sanford, La personalità autoritaria, 2 voll., Edizioni di Comunità, 1973.

Erich Fromm.
***
Il tema centrale dell’opera consiste nel supporre – e nel cercare di dimostrare – che l’anti-semitismo fa parte ed è espressione di un’ideologia più complessa caratterizzata dal conservatorismo politico, da un rapporto di sottomissione verso l’autorità, dall’autoritarismo verso chi ha minor potere, e soprattutto da una ideologia etnocentrica, la quale a sua volta è legata a una struttura autoritaria del carattere, dotata di una propria coerenza e chiaramente identificabile.
Il concetto di etnocentrismo e di ideologia etnocentrica, che risale al Folkways di Sumner (1906), è fondamentale come referente psicologico-sociale in tutta la struttura dell’opera: il suo significato viene man mano precisato nel corso dell’analisi. Possiamo indicarlo come quella tendenza (largamente inconscia, ma inscindibilmente legata alla sua razionalizzazione ideologica) a valutare positivamente e esaltare come ovvie, normali e in un certo senso assolute, le caratteristiche di valore del gruppo sociale di appartenenza (in-group), negando sia l’esistenza dei suoi aspetti criticabili, sia la legittimità stessa della critica di tali aspetti. Di conseguenza, l’etnocentrismo consiste nello svalutare e respingere in modo totalizzante e punitivo le caratteristiche dei «gruppi esterni», in particolare quando essi si configurino come espressione di una minoranza, e di una parte giudicata più debole rispetto al gruppo di appartenenza.
Da un punto di vista più strettamente psicologico, il concetto di etnocentrismo è legato, secondo gli autori stessi, a ciò che si designa come proiezione, soprattutto nel senso freudiano; e poiché è a Freud e alla psicanalisi che gli autori si richiamano come al principale corpus teorico che sottende alla loro indagine, vale la pena di esaminare alcune implicazioni della dinamica psicoanalitica della proiezione.
La proiezione è un meccanismo di difesa consistente nell’attribuire ad altre persone caratteristiche, atteggiamenti e intenzioni che in realtà sono propri di noi stessi, ma la cui presenza in noi viene ignorata o negata. Parlare di proiezione non ha però molto senso, se non si tiene a mente che esistono motivi precisi per cui questa parte di noi viene a essere in tal modo alienata e negata: l’immagine di sé che la società ci concede, e i cattivi adattamenti che, attraverso la famiglia, sempre ne conseguono, fanno sì che la sgradevole verità su noi stessi non debba mai apparire. Ma se il meccanismo proiettivo consiste nell’attribuire all’altro quella caratteristica negativa che neghiamo in noi, esso tende ad attribuire all’altro tutto ciò che di negativo ci appartiene e viene respinto, e quindi a caricarlo di negatività e di sospetto. All’altro viene attribuita quella stessa aggressività verso di noi che neghiamo in noi nel nostro rapporto con lui: così la negatività e la paura si riflettono in una reciproca proiezione di attese e di attribuzioni di ruoli.
In questo senso il meccanismo proiettivo non è mai un semplice rispecchiamento, dove ciò di cui viene negata la presenza nella nostra psicologia viene trasportato, per così dire intatto, nella psicologia dell’altro, e a lui falsamente attribuito. L’immagine di noi viene modificata nell’altro, acquista significato e caratteristiche ben diverse. Nella dinamica intrinseca della proiezione emerge una componente che fa apparire l’immagine prestata all’altro come assai più negativa di ogni nostra intenzione immediata ed evidente; entra in gioco una componente di più profonda aggressione, la quale fa sì che nell’altro non si ritrovi solo il nostro volto, ma anche il fantasma di una negatività più minacciosa, che può essere concepita sia come incarnazione della alterità stessa, sia come l’incubo di una nostra possibile distruttività, o l’indicazione ancora più arcaica di una negatività che è quella della perdita di sé. Freud stesso, fin dall’inizio della trattazione del concetto – nelle Nuove osservazioni sulle neuro-psicosi da difesa del 1896 – lo lega al meccanismo profondo della colpa e della aggressività nella paranoia.
Il meccanismo è molto comune. In molte situazioni di gruppo, soprattutto quando esistano forti componenti di lotta, di pericolo e di mobilitazione ideale, o anche nei casi di singole persone, certamente non da considerarsi squilibrate ma soltanto estraniate da una situazione di verifica, si riscontrano meccanismi proiettivi di tipo decisamente delirante, o paranoico, caratterizzati da una negazione di taluni aspetti della realtà in funzione di una sua reinterpretazione aggressivo-persecutoria o maniacale. La rappresentazione de-realistica dell’altro, e quindi della realtà stessa, viene utilizzata nella dinamica etnocentrica per esaltare e giustificare la propria collocazione, attraverso i circuiti di auto-conferma e le sostanziali assenze di confronto proprie dei gruppi sociali ideologicamente chiusi; il gruppo di appartenenza diventa valore e unità di misura del valore, ma il processo non è mai senza residui, non si appaga della propria circolarità, riproduce una attiva aggressione e una profondissima intolleranza verso il gruppo e la cultura estranei. L’esistenza stessa di quest’ultima, infatti, è la minaccia stessa che è in noi, e insieme è la negazione delle categorie su cui è fondato il nostro esistere.
Ma a questo punto l’analisi psicologica trova il suo limite. In primo luogo infatti risulta impossibile scindere lo studio scientifico del pregiudizio da un nostro giudizio di valore sul caso concreto in cui è avvenuto il meccanismo proiettivo. Nella proiezione ci si trova di fronte al sospetto della malafede, cioè al problema dell’eventuale spostamento strumentale della barriera del preconscio in funzione di un progetto implicito: in altre parole si è sempre al cospetto di una intenzione operativa che può avere le motivazioni più varie, che spesso ha finalità criticabili, e rispetto alla quale risulta facile accusare l’operazione proiettiva di bieca strumentalità. Così, in termini più banali, l’accusa che sorge ovvia verso chi proietta è quella di aver compiuto comunque una scelta, di essersi messo volontariamente in una posizione tale da poter anche utilizzare meccanismi nevrotici o psicotici di rimozione, di avere in una parola utilizzato «il trucco dell’inconscio» per potersela cavare senza pagar di dazio, cioè per giustificarsi di fronte a se stesso e agli altri.
Il dubbio non è poi così futile; ma il problema diviene ancora più serio quando si esamini l’aspetto collettivo della «aggressione proiettiva», e quindi la responsabilità non più solo etica ma politica dei gruppi e delle collettività che cedono alla dinamica del pregiudizio e al razzismo. Qui diviene impossibile allo studioso non impegnarsi personalmente (e sarebbe grave se pretendesse di non farlo) nell’esprimere una opzione e un impegno di carattere politico nei confronti delle dinamiche sociali in esame. In questo senso uno studio puramente «scientifico» delle motivazioni inconsce che presiedono a determinati comportamenti sociali rischia di fornire modelli di spiegazione perpetuamente di tipo giustificatorio. Una volta stabilita, quindi, la necessità di introdurre nell’analisi una dimensione di giudizio (e quindi di opzione politica), diviene anche necessario ripercorrere in modo critico quella ricostruzione puramente psico-dinamica dell’etnocentrismo e del meccanismo proiettivo di cui si è cercato più sopra di mettere in evidenza alcuni aspetti. Questo porta a chiedersi se ciò che è stato indicato come «il tema dell’aggressività» presente nel meccanismo della proiezione possa dipendere in modo esclusivo da fantasmi arcaici, dalla negazione della colpa, dall’impulso di morte, e dalla minaccia categoriale di una «presenza che ci nega»: o se non abbia invece fin dall’inizio una collocazione storica, come aggressività concreta in un mondo di violenza, e non dipenda quindi, forse in misura preponderante, da influenze assai più dirette, decisamente esterne, piuttosto che da una arcana distruttività dell’animo.
Questa ipotesi serve tra l’altro a spiegare come mai, se il meccanismo della proiezione è universale, e non rari davvero i settarismi, solo in certi casi l’etnocentrismo acquista (e ciò viene confermato anche dagli autori del volume e da altri che si sono mossi sulla stessa linea) un carattere di intolleranza propriamente fascista. In pratica ci si rende conto che esistono interessi storici, e non psicologici, tali da spingere gli uomini – o determinati strati sociali – verso quegli aspetti di «cattiva solidarietà» e di etero-aggressione che definiscono, come abbiamo visto, l’etnocentrismo nel suo aspetto peggiore. Per chiarire meglio, possiamo riferirci alla analogia di una tematica più nota, quella della guerra, e ricordare che se è in parte vero – come afferma Freud – che la guerra permette agli uomini di scatenare la loro aggressività, non possiamo oggi accettare né l’ipotesi secondo cui questa aggressività è biologica e quindi non è storicamente determinata, né tanto meno l’altra ipotesi secondo cui le guerre avvengono sostanzialmente per questi motivi, cioè per l’emergere di dinamiche psicologiche collettive, anziché per l’egemonia, gli interessi e i contrasti di interesse tra i gruppi dominanti, o la volontà di riscatto delle masse.
In base a quanto si è detto l’ultimo termine dell’ipotesi centrale dell’opera, cioè la struttura autoritaria del carattere – di cui è espressione l’etnocentrismo – acquista subito un significato meno ovvio e più problematico. Anzitutto, il termine è riduttivo, nei confronti della ricchezza e molteplicità di significati a cui esso in pratica si riferisce. Se l’etnocentrismo è un atteggiamento psicologico, un insieme di comportamenti, un modo di porsi valutato e misurato nel suo aspetto di ideologia (cioè nelle sue razionalizzazioni ideative e nella sua dimensione esplicita di falsa coscienza operativa), l’autoritarismo ha invece un significato più strutturale e più stabile, più implicito, meno direttamente operativo, in quanto si riferisce alla personalità stessa del soggetto.
Ciò non significa tuttavia che il problema dell’autoritarismo debba essere esaminato solo nel suo aspetto individuale, o come conseguenza del potere acquisito in circostanze storiche favorevoli da persone dotate da un certo tipo di costellazione naturale di caratteristiche psicologiche personali. La personalità autoritaria è il risultato di una situazione più complessa: è causa, ma anche conseguenza e luogo di comportamenti e razionalizzazioni sociali, è struttura portante di una ideologia che può avere altre cause, tipologia di un modo caratteristico e relativamente coerente di definire se stessi e i propri rapporti con gli altri. La personalità autoritaria è la personalizzazione di una tematica storico-sociale: essa è il modo, storicamente determinato, in cui i meccanismi di proiezione si cristallizzano dando luogo a una tendenza (o disponibilità) al fascismo. Del resto nel corso dell’opera anche gli autori non distinguono chiaramente tra termini e concetti quali «struttura autoritaria della personalità», «tendenze anti-democratiche implicite» e «potenzialità (personale) al fascismo».
Leggi anche: