Han Kang e la fodera del tempo
Di Han Kang, a cui nel 2024 è stato conferito meritatamente il Premio Nobel per la letteratura, si conosce da tempo l’ostinata capacità di sviscerare le pieghe più minute della sofferenza umana e di indagare le sottili sfumature dei sentimenti che si accompagnano al dolore sia nella sua configurazione soggettiva sia nella sua rappresentazione esteriore.
La vegetariana, ad esempio, il primo romanzo pubblicato in traduzione italiana da Adelphi nel 2016, seguiva la genesi e la progressione della solitudine di una donna nella cornice di una vicenda familiare del tutto ordinaria. Il dramma della protagonista non aveva tinte forti ma i gesti che l’accompagnavano e le azioni di resilienza con cui essa si difendeva dall’oppressione di chi le viveva accanto avevano qualcosa di altamente icastico che si imprimeva nella visione che il lettore aveva di quella vicenda.
La stessa straordinaria visionarietà caratterizza Non dico addio, di cui sono protagoniste due donne di mezza età, amiche fin dagli anni giovanili, che conducono vite solitarie nella ripetizione di una gestualità quotidiana che si rivela un blando antidoto a una sofferenza profonda. Fin dalle prime pagine del romanzo si capisce che entrambe si sentono schiacciate da un senso di perdita, di mancanza, afflitte da una ferita che né l’amicizia, né i tentativi di dare un ordine alle proprie vite riescono a rimarginare.
Di Gyeong-ha, la voce narrante, veniamo a sapere che era redattrice di una rivista che si avvaleva della collaborazione di fotografi esterni. Fu così che Gyeong-ha conobbe In-seon, che per alcuni anni collaborò stabilmente con lei nella realizzazione di numerosi articoli e reportage.

Ma poi la collaborazione cessò, l’amica fotografa si ritirò sull’isola di Jeju, per accudire la madre anziana.
Gyeong-ha diede anch’essa un taglio netto alla sua vita precedente fatta di lavoro e famiglia, per chiudersi in una dimensione solitaria, in una sorta di ritiro consapevole e sofferto dalla vita.
E qui, nella vigile disperazione di un’esistenza spogliata di qualsiasi aspettativa, ridotta alla mera sopravvivenza, si consuma l’infelicità senza desideri della protagonista.
«Tra me e il mondo si è instaurata una desolante linea di confine», afferma e si chiede: «Quando aveva cominciato a sgretolarsi tutto? Quale era stato l’istante della biforcazione? Quale il punto di svolta, la crepa, la frattura?»
Si viene a sapere quasi di sfuggita che Gyeong-ha ha pubblicato un libro su uno dei massacri più atroci della Guerra di Corea e che quelle immagini e quelle vicende sono penetrate in lei e le hanno cambiato la vita.
In particolare c’è un sogno che si presenta come un incubo ricorrente dominato da un cupo scenario di morte. Nel sogno appare un lugubre paesaggio invernale, una montagna bassa su cui spiccano una moltitudine di tronchi neri di altezze diverse piantati nel terreno, «inclinati e storti, sembravano migliaia di uomini, donne e bambini emaciati, curvi sotto la neve. Sono in un cimitero? mi chiedevo. Queste sono tutte lapidi? Camminavo tra quegli alberi dalle cime recise, sui quali si erano posati fiocchi di neve simili a cristalli di sale. Dietro a ciascun tronco si ergeva un tumulo».
Poi, inaspettatamente, appare il mare, una marea che sale, quella che sembrava la linea dell’orizzonte di una pianura era un’enorme distesa d’acqua che finirà per sommergere le tombe. Allora, al culmine dell’angoscia, l’io narrante si rende conto che deve agire.
«Per le tombe già sommerse non potevo fare più nulla ma dovevo spostare almeno i resti sepolti in alto. Prima che il mare li raggiungesse. Adesso, subito! Ma come? Senza l’aiuto di nessuno! Senza neppure una pala! Come salvarli tutti? Correvo incerta tra gli alberi, fendendo l’acqua che ormai mi era arrivata alle ginocchia».
Dalla prima apparizione notturna di quel sogno la protagonista non riuscì a riprendersi, la sua immaginazione era definitivamente colonizzata dalle atrocità della guerra e dalle infinite icone di morte che la memoria di quei tragici eventi si portava dietro.
«Nei quattro anni trascorsi tra la prima volta che feci il sogno degli alberi neri e quell’alba estiva avevo detto più di un addio. Alcuni per scelta; altri invece erano stati fulmini a ciel sereno e avrei dato qualunque cosa per impedirli. Se, come sostengono le antiche credenze, da qualche parte nel regno celeste o nell’oltretomba esiste un gigantesco specchio che vede e registra ogni nostro movimento, i miei ultimi quattro anni devono apparire in quello specchio come una specie di lumaca che ha lasciato il guscio e avanza lungo una lama. Un corpo che vuole vivere. Un corpo trafitto e lacerato. Un corpo che respinge, abbraccia, si aggrappa. Un corpo in ginocchio. Un corpo implorante. Un corpo che perde incessantemente non si capisce se sangue, pus o lacrime».
La lumaca che ha lasciato il guscio è l’immagine del compiuto disincanto: l’abbandono di un sistema di sicurezze domestiche e affettive per affrontare a viso scoperto l’essenza della vita che non è fatta di consolazioni e di illusioni ma di atrocità, di morte e di abbandono.
Ciò che colpisce in questo romanzo è la capacità di dare forma e immagine alla fine delle illusioni: il racconto è dominato dal nero degli alberi, dal buio delle veglie notturne a cui fa da contraltare la violenza del vento e il biancore della neve che si stende implacabile su qualsiasi segno di vita.
La lumaca che esce allo scoperto è anche una presa d’atto che di fronte agli orrori della storia qualsiasi narrazione che non sappia restituire quel destino di morte è un’inutile panacea, un mero esercizio consolatorio che distoglie lo sguardo da una cognizione vera di ciò che è stato.
Per questo la scrittura di Han Kang è fatta di continue sinestesie, di alternanze tra sogno e realtà, di passato e presente. Perché la vita tutta – e in modo particolare le distruzioni del passato, le rovine della storia, i massacri di Gwangju – non si lasciano declinare nello schema ordinato di una narrazione.
Perché anche per lei, come per i protagonisti dei racconti e dei romanzi di Sebald che hanno conosciuto l’orrore della shoah, il plot, il racconto ordinato dei fatti, non può e non deve esistere. La stessa Storia con la s maiuscola, quella che presume di dare un ordine ai fatti realmente accaduti, appare come un’invenzione ex post per calmare l’ansia provocata dalla distruzione e dalla fine dell’umano.
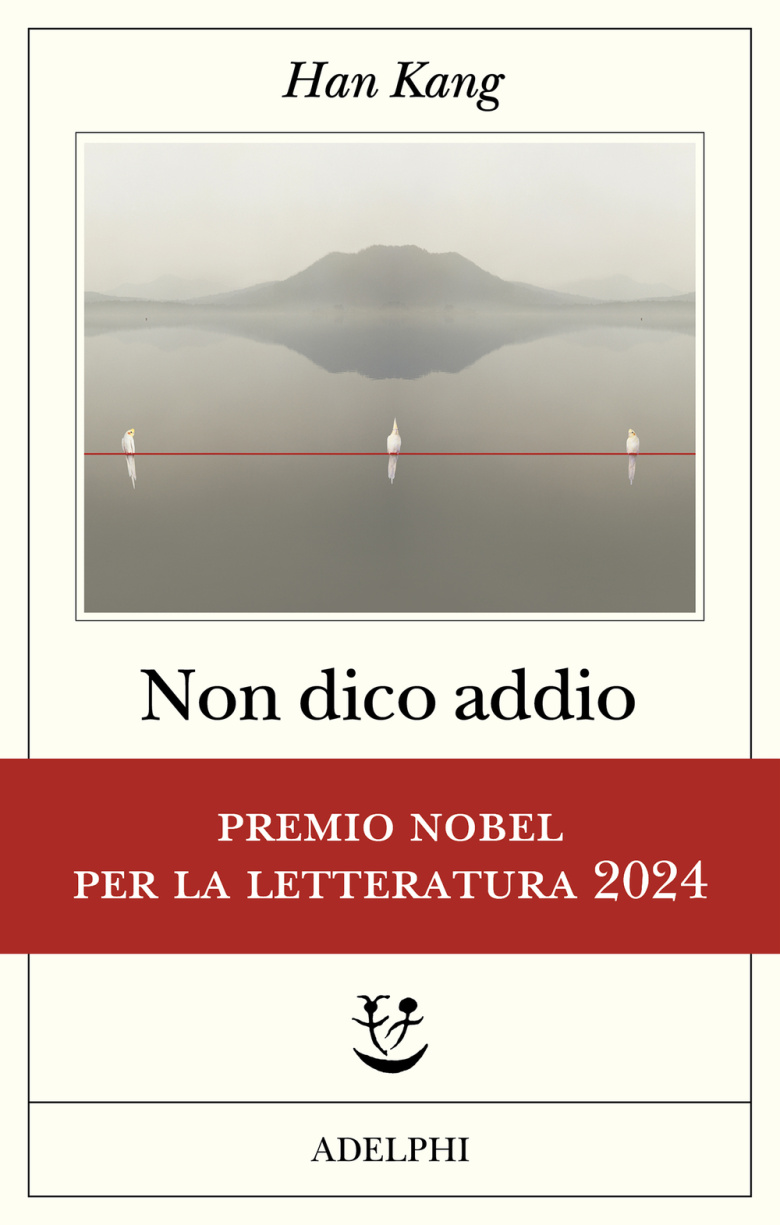
Se la Storia è finzione, la narrazione romanzesca tradizionale è una finzione al quadrato.
E allora, se il romanzo rinuncia alla sua funzione consolatoria, cosa resta?
Resta il sogno, l’apparizione improvvisa, l’alternanza caotica delle immagini e la commistione dei sensi, le sinestesie e gli ossimori percettivi: il colore che si fa suono, il ghiaccio che si converte in calore o la vita che si rapprende improvvisa nell’immobilità di un cristallo.
«Ogni volta che mi sento scivolare nel sonno come risucchiata in una luce calda, provo a sollevare le palpebre ma non ci riesco; non so se a causa della sonnolenza, o perché le ciglia sono sigillate da una patina di ghiaccio.
In quello stato di torpore, mi appaiono dei visi. Non di sconosciuti che sono morti, ma di persone vive, che sono lontane da qui, sul continente. Sono di una nitidezza spettacolare. Ricordi vividi come fossero accaduti ieri si srotolano davanti a me. Senza ordine né contesto.
Simili a tanti ballerini entrati contemporaneamente in scena, per eseguire ciascuno una propria coreografia. Istanti congelati in volo che brillano come cristalli».
Il sogno in cui scivola la protagonista di questo romanzo pare dunque possedere una capacità di lettura del tempo che alla veglia non è concessa. Nella dimensione onirica si genera una strana commistione tra percezione e memoria, tra passioni e straniamento che consente di cogliere il senso dell’accadere non dalla specola della progressione lineare ma dalla visione simultanea del passato e del presente.
«E chi mai – si chiedeva Walter Benjamin – potrebbe infatti con un gesto rivoltare la fodera del tempo? Eppure raccontare dei sogni non significa altro che questo».
I sogni della protagonista in questo ‘addio’ sempre procrastinato, sempre insidiato dalla tentazione di morire, producono uno sdoppiamento prospettico che è costitutivo del romanzo stesso come genere letterario: la realtà osservata dalla prospettiva onirica assume un tratto paradossale e mette in luce la sua vanitas e le sue effimere strategie di dare un senso all’accadere.
Nello stesso tempo il sogno osservato dalla specola della sofferenza della vita reale si svela come la chiave che permette di capire la genesi del male e del dolore che procura.
Quando le due amiche si accorgono di essere due naufraghe della storia il loro vivere non può che trasformarsi in un sopravvivere.
E la sola forma di sopravvivenza che ad esse pare ancora possibile non è la speranza ma la pietas: riuscire a salvare i resti di coloro che sono stati travolti dalla storia, cercare le ossa nelle fosse comuni che ora, a distanza di decenni dalla fine della guerra, riaffiorano, ad esempio ai margini di una pista di decollo di un aeroporto o nei cunicoli di una miniera dismessa.
Un lavoro di ricostruzione in cui si impegnano con dedizione assoluta.
La loro missione salvifica fa pensare all’angelo della Storia di cui parla Benjamin nella nona delle Tesi di filosofia della storia: l’angelo che sospinto da un vento violento vola ad ali spiegate al di sopra di un immenso cumulo di macerie verso un destino di redenzione.
Nel romanzo di Han Kan, tuttavia, si cerca invano una prospettiva salvifica, per le sue due protagoniste la sola salvezza possibile è la condivisione di un destino comune, la memoria dei propri affetti familiari e la cura reciproca.
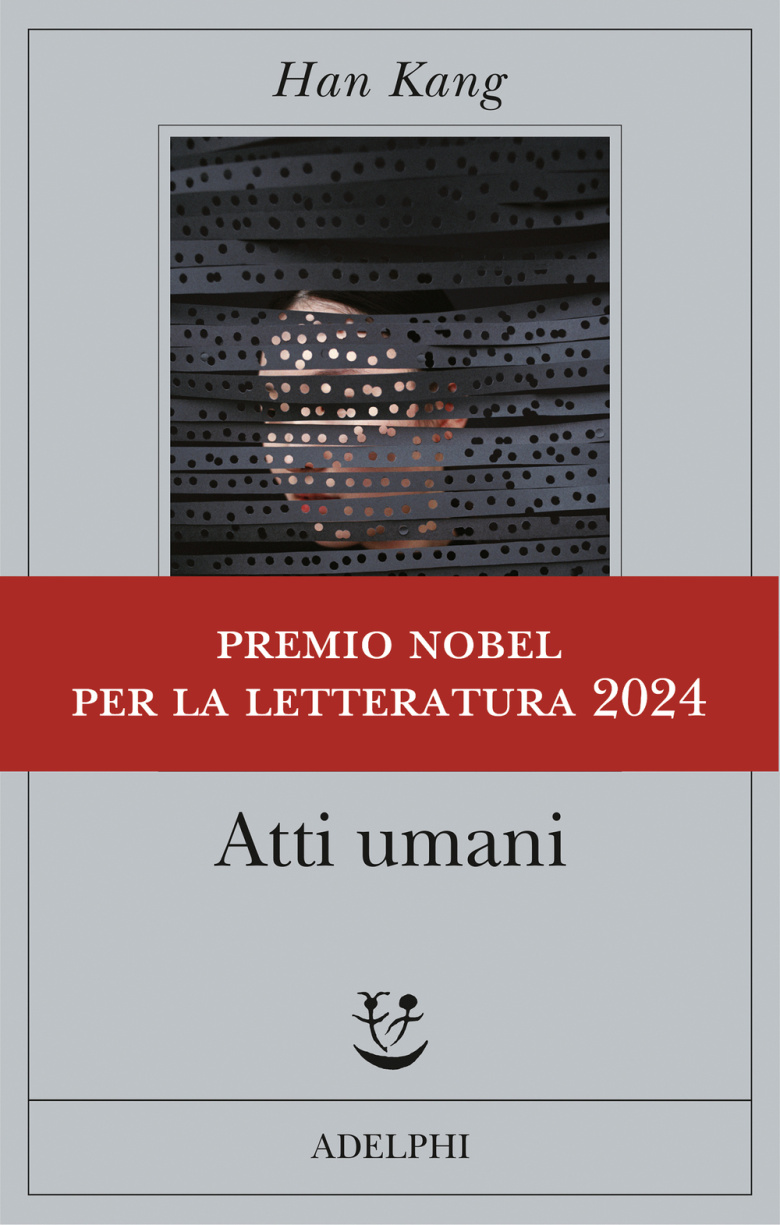
Quando In-sheon sarà ricoverata in ospedale per le ferite alle mani causate da un incidente nella lavorazione di un oggetto di legno l’amica si precipiterà sull’isola di Jeju in cui vive ormai da anni e raggiungerà in modo fortunoso la sua casa sperduta in un bosco, lontano da ogni centro abitato. Si prenderà cura dei suoi animali, di un pappagallino a cui In-sheon è particolarmente affezionata e che le è stato raccomandato di nutrire ma che non riuscirà a salvare. Inizierà però una lenta e minuziosa esplorazione della casa da cui emergeranno oggetti, cibi, scaffali, ripiani, cataste di legna, schegge improvvise di memorie, tutte tracce di una vita in bilico tra il desiderio di fare e la malinconia della memoria, tra rassegnazione e desiderio.
Han Kang ha, come si diceva, una capacità straordinaria di dare ai temi che esplora una dimensione visiva, a trovare nella quotidianità ordinaria o nella natura un correlativo oggettivo che assume una qualità simbolica immediata.
In La vegetariana i sacchetti di carne accumulati nel freezer della coppia diventavano l’icona della sottile violenza subita dalla donna. In Atti umani, il romanzo sui massacri di Gwangju, compiuti dalle forze governative nel maggio del 1980, la violenza è politica, e i suoi equivalenti simbolici affiorano come figurine del terrore: i fucili, le foto dei generali e i corpi accatastati della repressione armata.
In Non dico addio la memoria degli orrori della guerra civile assume la forma di alberi spettrali mossi dal vento, le cui fronde sembrano avvolgere i vivi con un gesto macabro di protezione.
Nel discorso di Stoccolma, in occasione del conferimento del premio Nobel, Han Kang ha dichiarato che la molla che la spinge a scrivere sono le molte domande che si pone e che la scrittura può evidenziare.
A proposito delle ricerche che hanno preceduto la stesura di Atti umani, ha spiegato:
«Sapevo con assoluta chiarezza da che parte doveva andare il romanzo. E che le mie due domande dovevano essere:
Il passato può aiutare il presente? I morti possono salvare i vivi?
Più tardi, mentre scrivevo quello che sarebbe diventato Atti umani, in alcuni momenti ho percepito che il passato stava davvero aiutando il presente e che i morti stavano salvando i vivi. Di tanto in tanto tornavo al cimitero e in qualche modo il tempo era sempre sereno. Chiudevo gli occhi e i raggi arancioni del sole mi illuminavano le palpebre. Lo sentivo come la luce della vita. Sentivo la luce e l'aria avvolgermi in un calore indescrivibile.»
Ha poi aggiunto che le domande non trovano risposte ma la letteratura è ciò che le permette di formularle e di condividerle con il suo pubblico.
Anche in Non dico addio la condivisione delle domande è già di per sé un merito che ripaga ampiamente l’assenza delle risposte.
Leggi anche:
Francesca Saturnino | La vegetariana, poesia e insubordinazione
Rossella Menna | Han Kang/Daria Deflorian. La vegetariana in scena
Bianca Terracciano | Han Kang maestra di passioni tristi
Roberto Gilodi | Il nuovo romanzo della scrittrice Han Kang / La Vegetariana
Riccardo Venturi | Han Kang, autobiografia bianca









