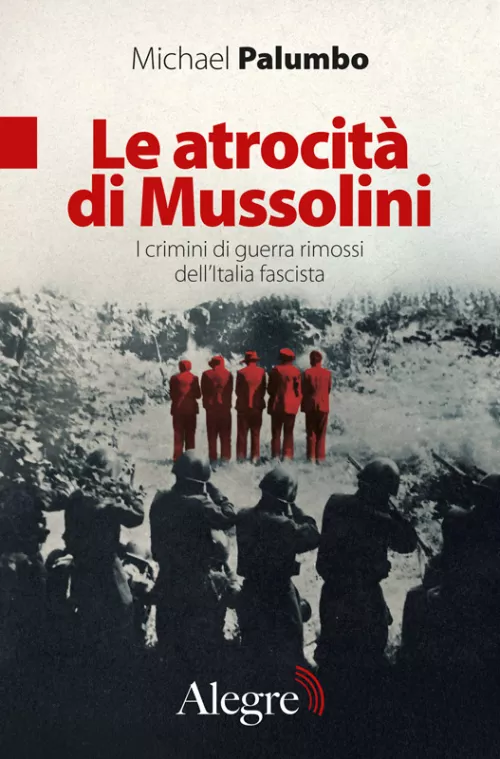Fascismo: un libro censurato
A volte la storia editoriale di un libro è interessante almeno quanto il suo contenuto. È il caso del saggio storico Le atrocità di Mussolini di Michael Palumbo (Alegre 2024). Il libro era già fatto e finito sin dal 1992; migliaia di copie della prima tiratura erano pronte a essere distribuite in Italia con il titolo L’Olocausto rimosso, ma Rizzoli decise di ritirarlo dalla commercializzazione e di mandare al macero i volumi stampati. È a partire da uno dei volumi superstiti che Alegre – casa editrice che ha fatto della controinformazione storica una bandiera – ha proceduto, oltre trent’anni dopo, alla ripubblicazione con un'introduzione di Eric Gobetti (autore di una recente sintesi sui medesimi temi).
Del titolo originario – non felice – resta un richiamo nella sottotitolatura (I crimini di guerra rimossi dell’Italia fascista) che chiarisce di cosa si occupano le quasi quattrocento pagine della ricerca.
Una doppia censura
Cosa impedì, nel 1992, la regolare uscita del libro? Per rispondere è necessaria una premessa che riconduce a un’altra vicenda di censura. Sono di Palumbo – storico italo-americano non accademico e giornalista d’inchiesta – le indagini storiche che costituiscono l’ossatura del documentario Fascist Legacy di Ken Kirby, prodotto dalla BBC e trasmesso nel Regno Unito nel 1989. Alfio Bernabei lo aveva recensito su l’Unità dell’epoca: «un agghiacciante documentario sulle atrocità commesse dagli italiani durante l’ultima guerra – scriveva – è stato trasmesso dalla Bbc nel quadro di un’inchiesta intesa a scoprire come mai 1.200 criminali di guerra italiani, a differenza di quanto accadde a quelli tedeschi e giapponesi, non furono mai processati».
Il documentario, che presentava al grande pubblico la sistematicità delle violenze italiane nei territori sotto occupazione, era una condanna senza appelli: il mito degli “italiani brava gente” ne usciva distrutto. L’immagine delle forze armate del Belpaese ne risentiva a tal punto che una nota ufficiale di protesta contro la Bbc era stata emanata dall’ambasciata italiana a Londra. Vi aveva replicato lo stesso Palumbo invitando, senza risposta, l’allora ambasciatore, Boris Biancheri, a presentarsi in televisione per un contraddittorio. Anzi, c’è da dire che nel 1991 la Rai aveva acquistato i diritti del documentario e ne aveva avviato il doppiaggio in lingua italiana, ma la pellicola, nonostante la spesa di non poco conto, non sarebbe mai stata mandata in onda dal servizio pubblico italiano. Solo nel 2004 stralci di Fascist Legacy si sono visti all’interno di un programma su La7.
Tra l’acquisto da parte della Rai del documentario e il ritiro dal commercio dei volumi de L’Olocausto rimosso trascorse un anno. Nei primi anni Novanta Palumbo non solo toccava un nervo scoperto per l’establishment politico e culturale ma lo faceva con strumenti altamente divulgativi e in un momento di transizione politica delicato e tumultuoso.
Il ritiro del libro va letto nel contesto di un'Italia in cui, nel 1992, alla vigilia delle stragi di mafia e con le avvisaglie del crollo delle forze politiche tradizionali, l’apparato istituzionale non intendeva riaprire i conti con il passato fascista.
Nello specifico, a indurre a una tale scelta l'editore Rizzoli, sembra fosse stata la minaccia di querela da parte di Giovanni Ravalli, ex ufficiale del Regio Esercito di stanza in Grecia, in seguito all’8 settembre unitosi alla Resistenza, come molti altri militari italiani nella penisola ellenica. Sulla base dei documenti alleati usati per la ricerca, Palumbo addebitava all’ex militare italiano l'aver compiuto “atrocità estremamente gravi” nel corso dell’occupazione della Macedonia greca, in particolare nel villaggio di Kastoria. Nel 1992, Ravalli, con alle spalle una carriera nelle istituzioni statali come prefetto in Sicilia, dopo aver letto scorci del saggio anticipati da «Panorama» aveva intrapreso via legali per diffidare la Rizzoli dal procedere alla pubblicazione.
Come rivelato da Palumbo nella prefazione all'edizione 2024 la casa editrice temeva un "effetto domino" di cause legali da parte di reduci o loro eredi, in un clima dove la memoria della guerra era ancora terreno di scontro politico. Che la vicenda greca fosse, tra i tanti orrori ricostruiti nel libro, la più inaccettabile per una parte di opinione pubblica lo rivela anche un altro particolare. Proprio nei primi mesi del 1992 aveva appena vinto un Oscar come miglior film straniero Mediterraneo di Gabriele Salvatores, pellicola di grande successo nelle sale. Pur firmato da un regista progressista – che avrebbe detto che l’ambientazione nel secondo conflitto mondiale era solo uno stratagemma narrativo –, il film cristallizzava il mito degli "italiani brava gente" attraverso la rappresentazione edulcorata dell'occupazione della Grecia. Mentre al cinema si celebravano i buoni soldati italiani – ora musicisti, ora poeti, innamorati e benvoluti dalla popolazione greca – Palumbo documentava, basandosi su rapporti della Commissione delle Nazioni Unite sui Crimini di Guerra (Unwcc), le fucilazioni di civili, il funzionamento dei campi di prigionia, la distruzione dei villaggi e il saccheggio di risorse alimentari, causa di una diffusa e deliberata carestia che comportò, secondo alcune stime, oltre 300.000 morti. Mentre la popolazione moriva di fame – ad Atene si arrivò a 10.000 morti al mese nell’inverno 1941-42 –, i soldati fascisti saccheggiavano i villaggi, bloccavano gli aiuti della Croce Rossa e vendevano al mercato nero il cibo sottratto ai civili. Nei rapporti delle Nazioni Unite si legge che, mentre vi erano bambini che mangiavano la corteccia degli alberi, gli italiani colpivano con fruste metalliche la popolazione che osava protestare contro i sequestri di cibo operati dalle truppe di occupazione. Palumbo evidenzia una logica cinica, tipica del dominio coloniale, in cui il controllo sul cibo è il controllo sull’intera vita. A queste acquisizioni la storiografia sarebbe arrivata solo in tempi più recenti, come ci dimostra un saggio di Paolo Fonzi del 2020.
La coincidenza temporale tra la censura di Palumbo e il riconoscimento a Salvatores è rivelatrice di un meccanismo tipico dell’approccio culturale italiano al passato: l’incapacità di reggere il confronto con la propria storia fa sì che alla rimozione delle tragiche responsabilità dell’esercito italiano si sovrapponga l’invenzione e l’esaltazione della sua bonarietà.

Fermare l’oblio
Il saggio di Palumbo non si limita a elencare i crimini di guerra e le feroci repressioni dell’epoca coloniale ma ricostruisce il sistema di violenza istituzionalizzata che sostenne il fascismo, chiarendo le radici imperialiste e le origini del progetto di supremazia fascista nel Mediterraneo. Mentre Mussolini si faceva rappresentare come un nuovo Scipione l'Africano, i suoi soldati incendiavano villaggi in Cirenaica e deportavano oltre centomila beduini in campi di concentramento nei quali la mortalità raggiungeva un tasso del cinquanta per cento. Palumbo approfondisce il caso dell’Etiopia, in cui l'uso sistematico di gas tossici e le stragi di civili – come i massacri di Addis Abeba e di Debre Libanos (https://www.doppiozero.com/i-massacri-del-1937-addis-abeba-e-debre-liba…) – smentiscono qualsiasi retorica sulla "missione civilizzatrice" del colonialismo.
Ampio spazio è quindi dedicato all’occupazione dei Balcani, con quattro capitoli, uno molto corposo dedicato alla Grecia e gli altri tre in cui si presentano le vicende del confine orientale, del Montenegro e della Croazia: oltre alla rassegna delle rappresaglie antipartigiane e del terrore inflitto a tutta la popolazione civile, sono descritte le modalità di funzionamento dei campi di concentramento per la popolazione slava. Un altro capitolo cruciale è dedicato all’instaurazione della Repubblica Sociale Italiana, chiarendo le responsabilità italiane nell’identificazione, arresto e deportazione degli ebrei durante la RSI e evitando ogni indulgenza sugli apparati repressivi repubblichini, i quali, a tratti subalterni all’alleato-occupante nazista, erano sempre intenti a ritagliarsi margini per agire autonomamente nelle più spietate forme di rappresaglia. Palumbo dimostra come le atrocità fasciste non fossero "eccessi" isolati ma parte di una strategia di annientamento deliberata e intrinseca al regime.
I capitoli finali del libro sono dedicati al confronto emblematico e paradossale tra il processo al generale Nicola Bellomo – unico condannato a morte italiano da un tribunale inglese, nonostante si fosse poi distinto, dopo l’8 settembre, per la difesa del porto di Bari dal tentativo di distruzione nazista – e i mai realizzati processi di epurazione dell’apparato repressivo fascista e la mancata costituzione di una Corte internazionale per giudicare i criminali di guerra italiani.
Ciò che colpisce il lettore di oggi non è tanto la ferocia della violenza fascista – su cui si sono poi concentrate opere monografiche successive – quanto il profondo oblio che l’ha seguita. Vale la pena soffermarsi su un'ipotesi controfattuale: se questo libro fosse stato pubblicato e diffuso oltre trent’anni fa avrebbe forse contribuito a evitare la riscrittura revisionista del passato? Quella cioè che conduce oggi a subire la sostanziale equiparazione tra fascismo e antifascismo in una parte significativa e simbolica della comunicazione pubblica.
Recentemente la sensibilità sul tema si è finalmente attivata in propositiva forma di discussione pubblica, ma a lungo ci si è limitati a una strategia reattiva rispetto all’offensiva revisionista scatenata nella seconda metà degli anni Novanta e nei primi anni Duemila. Oggi si distinguono azioni pubbliche come quelle messe in campo dalla Federazione delle Resistenze, una rete, nata su iniziativa del “cantiere culturale permanente” Resistenze in Cirenaica, il cui scopo è collegare varie esperienze territoriali di “storia pubblica dal basso”, accomunate dalla volontà di fare i conti con il passato. A volte si tratta di “guerriglia odonomastica”, cioè di un’opera di disvelamento, volta a sanzionare e decostruire nelle città italiane le intitolazioni acritiche di vie, piazze, strade o spazi pubblici a nomi e simboli dell’epoca coloniale. In altri casi il focus è sulla necessità di contrastare la vulgata nazionalista riguardo alle vicende del confine orientale, dell’esodo istriano-giuliano-dalmata e delle foibe. Si tratta di pratiche che provano a scuotere la coscienza pubblica rispetto alla rimozione del nostro passato. In questi contesti il libro di Palumbo – del quale si organizzano presentazioni e discussioni – si rivela un prezioso documento, ricco di dati, e che propone una lettura generale di temi su cui l’interesse è crescente. Rispetto ai crimini del fascismo in Africa o alla conflittuale memoria relativa all’occupazione della Jugoslavia, tuttavia, se c’è un ambito che ancora resta in gran parte misconosciuto è proprio quello, a cui abbiamo già accennato, delle efferatezze che hanno contraddistinto l’occupazione della Grecia. Su questo varrebbe davvero la pena iniziare a costruire un controcanto alla narrative nazionalista dominante. Restituire alla memoria collettiva i crimini italiani contro il popolo greco non sarebbe solo un atto di giustizia verso il passato, ma anche un modo per uscire dalle secche del discorso pubblico sul confine orientale e sulla Jugoslavia.
Un lavoro rigoroso, con qualche limite
Evitando, anche attraverso lo stile di scrittura, di comunicare l’immedesimazione nelle vittime, Palumbo adotta un tono generalmente sobrio, affidandosi alle fonti. Le efferatezze emergono attraverso dati, testimonianze dirette, telegrammi cifrati tra generali e gerarchi. Questa scelta, lontana dalla cifra stilistica del sensazionalismo, rende la lettura scorrevole: la violenza non ha bisogno di essere enfatizzata quando i fatti parlano da soli.
Pur riconoscendo il valore documentario e il coraggio civile del saggio, è tuttavia doveroso segnalarne alcuni limiti metodologici. Palumbo costruisce la sua narrazione su un’impressionante mole di fonti d’archivio, in particolar modo i già citati rapporti della Unwcc e a questi affianca materiali d’archivio italiani, inglesi, statunitensi e tedeschi. Alle fonti archivistiche si aggiungono testimonianze scritte coeve o di poco successive ai fatti ricostruiti. In qualche caso si fa riferimento a una storiografia che oggi definiamo “pionieristica”: i primi studi di Del Boca e le ricerche di Giorgio Rochat.
A tratti sembra, tuttavia, emergere qualche difficoltà di metodo nel sistematico cross-checking dei documenti, in altri casi l’acribìa del mestiere di storico pare un po’ offuscata. Nonostante la documentazione presentata, manca talora un'analisi critica più profonda, che permetta al lettore di valutare il peso dei diversi documenti, il loro contesto produttivo e le eventuali distorsioni prospettiche o ideologiche.
Va ricordato che molte delle vicende erano, nel 1992, scarsamente trattate da altri studiosi e va considerato che gran parte della ricerca risale agli anni '80 quando molti archivi erano meno accessibili di oggi. Allo stesso modo, non era semplice reperire ulteriori fonti in grado di mostrare il punto di vista delle vittime, se non attraverso il filtro processuale delle deposizioni nei tribunali alleati. A volte, nello svolgimento del libro, succede che ad accompagnare le ricostruzioni per più pagine sia un unico report dell’Unwcc. In altri casi, per ovviare a questo problema, Palumbo prova a ricorrere alla memorialistica, senza però evidenziarne i limiti intrinsechi; in alcuni casi le fonti non sono bilanciate da altra documentazione e questo rende talune pagine meno inattaccabili di altre. Nonostante queste criticità metodologiche, la sostanza delle ricostruzioni, basate su prove documentali convergenti, non risulta inficiata.
In questo senso Le atrocità di Mussolini va inteso come uno stimolo per continuare a sfidare, una volta di più, la narrazione consolidata degli "italiani brava gente", e per indicare piste per ricerche che possano integrare e approfondire il lavoro di Palumbo. Il portato più significativo è infatti aver orientato lo sguardo verso un’interpretazione del fascismo come di un sistema di violenza organizzata. Ormai nella storiografia l’idea di un preciso progetto politico imperiale del fascismo – un “nuovo ordine mediterraneo” (Davide Rodogno) – è stata riconosciuta.
La domanda che resta non è quindi "perché questo libro fu censurato nel 1992?", ma "come possiamo oggi accoglierlo nel senso comune?". La risposta sta nel modo in cui decideremo di continuare, nella ricerca e nelle attività di storia pubblica, le pratiche di resistenza culturale alla normalizzazione del passato fascista.