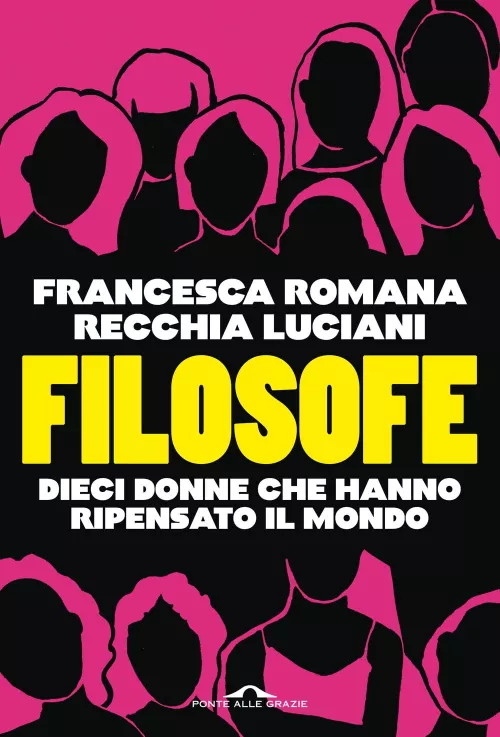Filosofe. Molte certezze, qualche dubbio
Nella selezione di dieci filosofe, dieci donne che hanno riflettuto sul mondo, come recitano titolo e sottotitolo del saggio (Francesca Romana Recchia Luciani, Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo, Milano, Ponte alle Grazie, 2025, pp. 232, € 18) l’autrice, professoressa Ordinaria di Storia della filosofia e Saperi di genere all’università di Bari, è visibile, a mio avviso, un particolare criterio discriminante; discriminante nel senso neutro di introdurre una scriminatura, come fa il pettine nei capelli separandoli; non è che quelli di qua siano più belli di quelli di là. Il criterio è che le prime sei sono filosofe (Salomé, Zambrano, Arendt, de Beauvoir, Weil, Heller), talvolta anche filosofe femministe (de Beauvoir); le seconde quattro (Lonzi, Lorde, Federici, Butler) sono femministe, alcune anche femministe filosofe (Lonzi, Butler). Non fanno parte della decina le donne del femminismo aurorale, più protofemministe che filosofe, Christine de Pizan e Olympe de Gouges, o Mary Wollstonecraft, femminista e teorica del pensiero politico. Ma nemmeno filosofe contemporanee di grande spessore, vedi Martha C. Nussbaum, filosofa anche femminista. Per chiarire questa confusione di termini, dirò che intendo per «filosofe» tout court, pensatrici che hanno anche riflettuto sulla condizione femminile, alcune davvero di sfuggita. Per filosofe femministe intendo invece le pensatrici che hanno coscientemente e deliberatamente pensato il mondo da donne. Nel suo libro, Recchia Luciani, seguendo questa doppia traccia, evidenzia che c’è un modo altro di fare filosofia da parte delle filosofe, soprattutto perché quando le donne hanno avuto finalmente accesso all’istruzione, con un ritardo secolare rispetto agli uomini, hanno interpretato il mondo principalmente a partire proprio dalla dimensione corporea e materiale cui la storia patriarcale le aveva relegate. In qualche modo hanno portato dentro la filosofia una prospettiva derivata dalla loro stessa condizione storica di escluse dall’universo astratto delle idee. Oltre a ciò Recchia Luciani, che è anche coordinatrice di un imponente Dottorato Nazionale in Gender Studies e autrice di saggi e monografie anche su filosofi uomini, parla di «ripensare il mondo». E questo non soltanto perché il cosiddetto patriarcato, malgrado le rivoluzioni femministe degli ultimi due secoli, traspira da molti, troppi pori, ma anche perché le filosofe sono state, molto più dei loro omologhi maschili, considerate irrilevanti nell’imporre un cambiamento concreto della realtà.
Torno alle filosofe del primo tipo, quelle che sono riuscite a entrare a pieno titolo nell’«universo maschio della filosofia». Penso a María Zambrano, scoperta per noi da Carlo Ferrucci nei primissimi anni Novanta, con Chiari del bosco e I beati, e poi tutto il resto della sua produzione di poesia filosofica e filosofia poetica, e il sapere dell’anima, e le viscere, e soprattutto l’esilio. Zambrano riuscì come pochi a cogliere le contraddizioni, gli svantaggi ma anche i privilegi dell’esiliato, a vedere e giudicare la patria standone fuori. Zambrano capì che la condizione di esiliata ti dà una carta in più, e non sa se odiarla o amarla, questa esperienza, nota Recchia Luciani, «così dirompente e per certi aspetti ineffabile». Zambrano rimase in ogni caso fedele alla lingua patria, e continuò a scrivere in spagnolo.
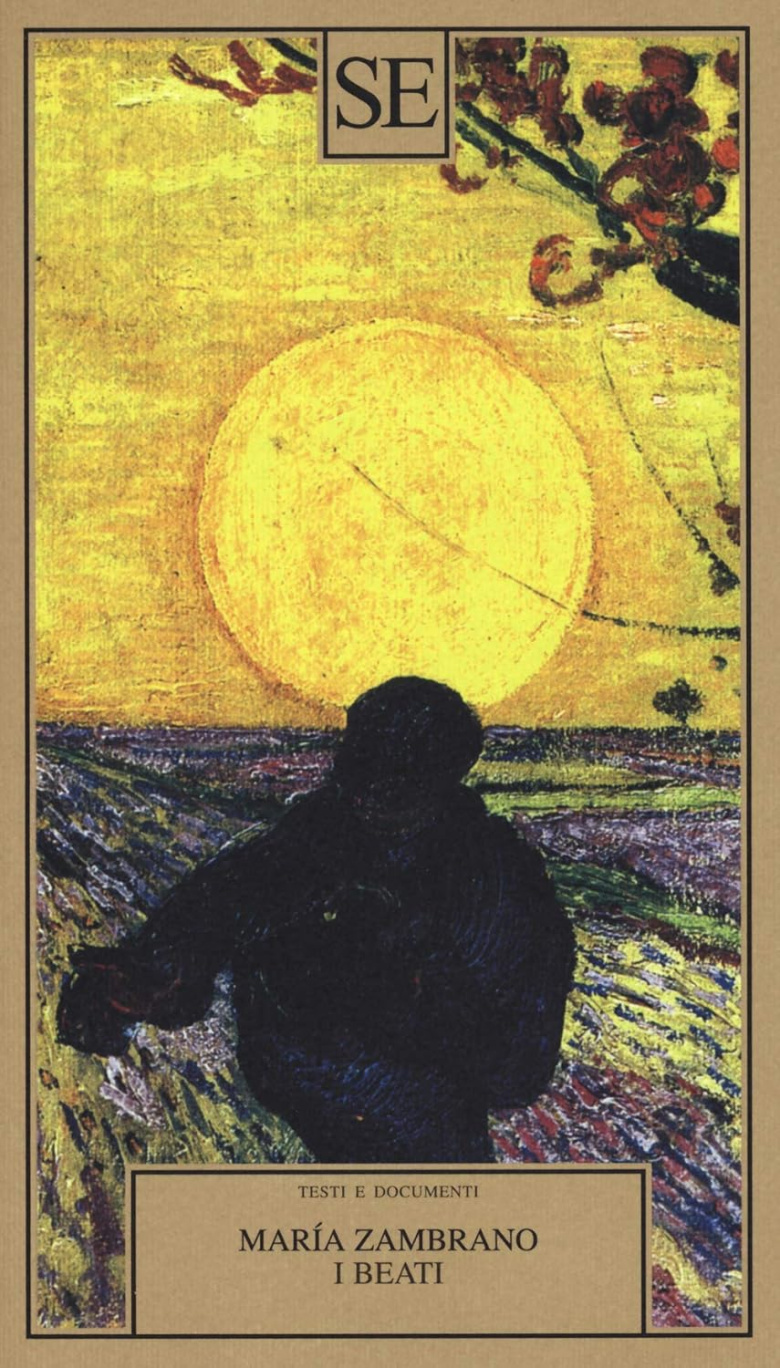
Diversamente da Hannah Arendt, altra filosofa del primo tipo, che si adattò alla lingua inglese per scrivere (anche se spesso si autotraduceva dal tedesco) e per parlare in pubblico, mantenendo la lingua tedesca per parlare in privato e forse anche per pensare, per capire, ciò che a più di ogni altra cosa ambiva. Recchia Luciani nel definire «di genere» la sensibilità politica di Arendt prende le distanze dalle interpreti «differenzialiste», poiché più che evidenziare il tema della «natalità», del vivere per nascere, contrapposto al vivere per morire di tutta la filosofia occidentale, ben condensato nella maggiore del famoso sillogismo che inizia con «tutti gli uomini sono mortali», mostra che l’impatto di Arendt con la realtà materiale delle cose produce anche un radicale cambiamento di attitudine ermeneutica, generando una politica non astratta, ma intrisa di realtà, concretezza, fattualità, corpo, viscere.
Ancora del primo tipo, e mi limito a queste tre, Simone Weil, figura controversa di filosofa/mistica, con la sua idea sublime di proporre l’educazione classica, le tragedie di Sofocle, al ceto operaio invece di lasciarlo nell’ignoranza; con la sua difesa della libertà individuale e del ruolo essenziale dell’individuo contro cui oggi si spara a zero; ma anche con gli scivoloni sul lavoro e sul radicamento. Da una parte Weil apprezza il lavoro, lo ritiene fonte di saggezza, binomio perfetto di pensiero e azione, e poi se ne ritrae, non vede soluzioni o arriva a proporne di improbabili, conservatrici, come il radicamento, il titolo dell’ultima opera, L’enracinement, ove auspicava la fioritura delle comunità locali, il richiamo alle tradizioni, agli spazi di vita condivisi, il ritorno alle radici religiose e spirituali, la mistica del lavoro. Quasi una traiettoria che inizia come eversiva e finisce come reazionaria, come scrive Michela Nacci nel suo recente Simone Weil, Roma, Carocci, 2024, volumetto della collana su Donne e pensiero politico in cui è presente anche un contributo su Mary Wollstonecraft, di Serena Vantin, e un altro su Madame de Staël e altri: tutta la collana è pregevole.
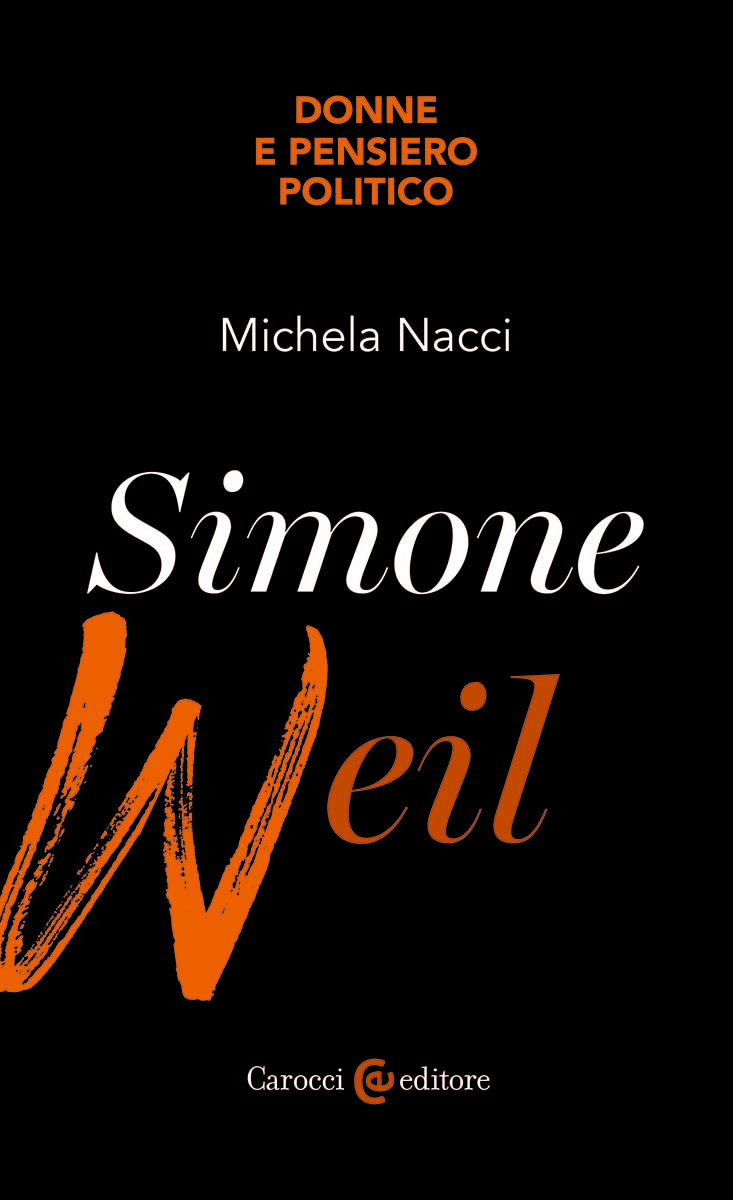
Le seconde quattro, dicevo, sono pensatrici femministe, teoriche del femminismo o come Lorde, del lesbofemminismo: per trovare delle filosofe femministe dobbiamo rivolgerci in parte a Lonzi, ma più compiutamente a Butler, nonostante l’incomprensibilità di molte sue asserzioni, o forse proprio per quello, come se per fare della buona filosofia occorresse essere di necessità oscure e oscuri a mo’ di Eraclito.
Butler, sprezzantemente definita sacerdotessa, anzi «papessa» degli studi di genere dai suoi tanti detrattori, riceve invece nella disamina dell’autrice un giudizio sostanzialmente positivo, che coincide con l’essersi fatta promotrice nel 2023 del conferimento a Judith Butler, da parte dell’Università di Bari, del dottorato h.c. Immagino poi che di questi tempi una studiosa come Butler che si definisce «teorica queer», nonché fuori dal codice binario Maschio/Femmina, rappresenti il bersaglio diretto degli strali di Donald Trump contro i Gender Studies e più in generale nel suo programma di lotta alla mentalità woke e ai residui del politicamente corretto; lotta facile dal momento che si tratta di tematiche malviste dalla destra e anche da parte della sinistra. Da aggiungere che Martha Nussbaum, la grande assente di queste pagine, aveva criticato pesantemente Butler, già nel 1999, per il suo «esercizio narcisistico di autorappresentazione personale che... prescrive pagliacciate teatrali ricorrendo a un linguaggio astruso». La critica di Nussbaum non è infondata. Lo spiega, con chiarezza, Maria Giulia Bernardini in Judith Butler, un altro prezioso volumetto di Carocci della stessa benemerita collana sul contributo delle donne alla storia del pensiero politico: basta provare a leggere uno dei suoi testi: il linguaggio è ostico, difficilmente comprensibile, pare fatto apposta per confondere chi legge; in assenza di tesi sostanzialmente originali, è come se si volesse dare l’illusione che ci si riferisca a un valore di verità superiore e inaccessibile al senso comune.
È un po’ come l’altra faccia della medaglia del modo di scrivere di presunti filosofi che echeggiando pensieri altrui, riproponendoli senza segnalare il pensiero originale, in piccoli testi facilissimi quanto di una disarmante banalità, e tanto per non fare nomi mi sto riferendo ai trattatelli del «filosofo» Byung Chun-Han e del suo collega storico Yuval Harari. Nell’uno e nell’altro caso, basta che se ne parli. Ma mentre nel caso di Butler si spera che il suo pensiero, se non da lei stessa, possa essere reso comprensibile dagli esegeti, nel caso del filosofo corean-tedesco temo che sia impossibile parlare di un pensiero originale e innovativo.