L’imperialismo degli italiani brava gente
A ventitré anni di distanza dalla prima, Nicola Labanca licenzia una nuova edizione aggiornata di Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana (il Mulino, 2025). Della prima edizione, il volume mantiene la struttura, che intende servire come introduzione agli studi sul colonialismo italiano e, allo stesso tempo, come loro sintesi. La necessità di un'opera di questo genere era già stata chiarita nel 2002: l'autore voleva fornire le conoscenze essenziali per la comprensione di un fenomeno che ha avuto un profondo impatto sulla storia e sulla mentalità degli italiani, ma la cui memoria è in gran parte evaporata e spesso sostituita con la «rassicurante favola» degli «italiani brava gente». «Con la conseguenza – scriveva Labanca – che alcuni fenomeni storici attuali risultano poco o per niente comprensibili».
Luoghi e protagonisti del colonialismo italiano, per esempio, si ritrovano ancora in abbondanza nell'odonomastica ma il loro significato è sconosciuto alla maggior parte dei cittadini. Non a caso il primo paragrafo del libro si intitola Contraddizioni e si chiude con una serie di domande, fra le quali spiccano le seguenti: «Cosa è avvenuto fra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo che ancora impatta sul nostro attuale XXI secolo?»; «Perché fra gli italiani alberga un diffuso razzismo nei confronti dell’Altro?».
Le contraddizioni e l’evanescenza della memoria hanno anche spiegazioni storiografiche: gli studi sull'espansione in Africa, infatti, furono dapprima rarefatti nel periodo dell'Italia liberale, quindi intossicati dalla propaganda durante il fascismo. Per settant'anni, all'opinione pubblica italiana non vennero forniti i dati più elementari sulla politica estera del proprio Paese. La situazione non migliorò nel primo trentennio dell’Italia repubblicana. Il panorama degli studi iniziò finalmente a modificarsi soltanto alla metà degli anni Ottanta, dopo che Angelo Del Boca ebbe completato la sua ricostruzione complessiva della vicenda degli italiani in Africa e una nuova generazione di storici (italiani, africani e di altri Paesi) si accostò allo studio del colonialismo italiano. Infine, nei primi anni del XXI secolo si è registrata una svolta e hanno preso slancio una crescita quantitativa e un rinnovamento radicale della ricerca storica.
Da quest'ultima considerazione, Labanca si è convinto dell'utilità di un aggiornamento di Oltremare alla luce delle nuove acquisizioni storiografiche. Prima di esaminarne i nuovi contenuti, vale la pena richiamare le pagine, già presenti nella prima edizione del 2002, in cui lo storico evidenziava i problemi incontrati da chi si accingeva alla stesura di un'opera di sintesi sulla storia del colonialismo di qualsiasi Paese europeo. In primo luogo, come era possibile «scrivere una storia quando ogni suo capitolo era il frutto di almeno due realtà: quella europea e quella africana o asiatica»? L'autore riconosce poi altre difficoltà: come si può «scrivere una ricostruzione unitaria di storie fra loro assai diversificate geograficamente», «padroneggiare discipline assai diverse fra loro – dalla storia all’antropologia, dalla linguistica agli studi religiosi», «superare la visione settoriale e militante» di tanti storici del passato e non limitarsi a «essere ancora solo una storia politica, diplomatica e militare?». Appunto di queste difficoltà hanno tenuto conto le ricercatrici e ricercatori nei loro recenti lavori di cui Labanca riferisce: «fornire le conoscenze essenziali per la comprensione del fenomeno» dell'espansione coloniale italiana «nella maniera più aggiornata possibile» dovrebbe permettere «di legare la storia coloniale italiana tanto alla storia nazionale quanto a quella dell’espansione europea nel suo complesso».
D'altro canto, aggiunge l'autore in uno dei nuovi capoversi della Premessa, «appare opportuno non accontentarsi mai di generalizzazioni, formule e teorie considerate valide per ogni imperialismo coloniale. Occorre invece, nei limiti del possibile, cogliere i caratteri di fondo e unificanti ma anche individuare le differenze, tenere presenti le diversità, interrogarsi attorno alle dissimiglianze: una buona storia non è fatta di slogan e teorie ma di distinzioni e sfumature».
In quanto alle peculiarità italiane, Labanca si sofferma, come esempio particolarmente significativo, sulla necessità di indagare il collegamento esistente tra il razzismo diffuso nella società italiana odierna e il «suo antenato coloniale oggi (a caso?) dimenticato». L’Oltremare rappresentò uno dei grandi miti trainanti dell’Italia liberale, e poi di quella fascista. Costruendo il loro «impero», gli italiani si sentirono più forti e moderni, incuranti dei delitti di cui si macchiarono nei confronti dei loro «sudditi». Non è inutile chiedersi oggi cosa sia rimasto nella mentalità comune di quella indifferenza alla sofferenza altrui, che invariabilmente accompagna le azioni di chi si ritiene appartenente a una «razza superiore».
Alla crescita degli studi è corrisposta l'introduzione di un diverso punto di vista: sono nate la storiografia africana e quella asiatica, che hanno, a ragione, contestato l’immagine dei rispettivi continenti come territori senza storia, che solo i colonizzatori europei avrebbero rivitalizzato. Un eccellente esempio è dato dai volumi curati da François-Xavier Fauvelle, come L'Africa antica (Einaudi, 2020) e il recente L'Africa e il mondo (ADD editore, 2024). Il colonialismo europeo, dunque, può essere considerato come una «parentesi» nella più lunga storia di questi continenti. Altrettanto vale per il periodo successivo: sarebbe un errore «coloniale» – scrive Labanca nella Conclusione del volume – «interpretare la storia postcoloniale delle popolazioni, dei territori, degli Stati usciti dalla dominazione italiana soltanto o prevalentemente alla luce della storia del colonialismo italiano».
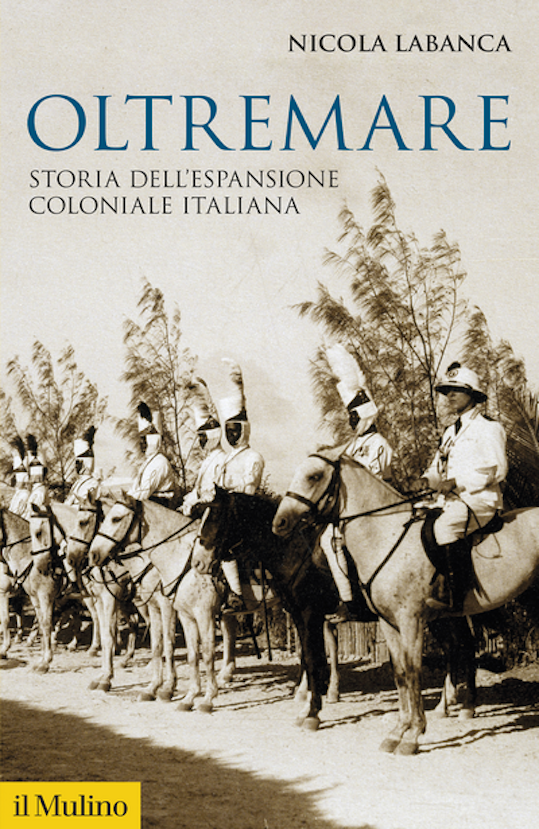
I principali aggiornamenti del testo riguardano il capitolo ottavo, “Italia senza colonie, memoria delle colonie”. La Repubblica si ritrova «senza colonie, ma tarda a essere postcoloniale». Le esigenze politiche dell’Italia repubblicana – spiega Labanca – hanno influenzato l’opportunità di ricordare, o non ricordare, o di come ricordare. Inoltre, bisogna tenere conto della situazione economica e dell’atmosfera culturale. Per quanto riguarda la dimensione economica, nella nuova edizione sono stati aggiunti e commentati i dati relativi alle importazione e alle esportazioni italiane da e verso l'Africa, messi a confronto con quelli totali a partire dal 1861 fino al 2015: diventa così evidente che «l’Italia di oggi è avvinta all’Africa in misura maggiore che nel passato». Dati che stimolano una riflessione sulla presunta «centralità» dell’esperienza coloniale degli italiani. D'altro canto, secondo l'autore «c’è una quota maggiore, oggi, di italiane e italiani che non tollera più le chiusure razzistiche del passato, quelle nei confronti degli africani di oggi quanto quelle verso i “sudditi coloniali” di ieri»; una quota, si potrebbe aggiungere, che è maggiore rispetto al passato ma non riesce a diventare maggioranza.
Labanca suddivide la storia della Repubblica italiana nella sua relazione con l’Africa in quattro fasi: la prima (dal 1945 al 1960) coincide con gli anni della decolonizzazione politica dei grandi imperi coloniali europei; la seconda comprende gli anni Sessanta e Settanta; la terza copre all'incirca gli anni Ottanta e Novanta; la quarta, «globale e postcoloniale», riguarda il nostro secolo.
A proposito della prima fase, un interessante aggiornamento si concentra sulla mancata epurazione e decolonizzazione degli ambienti politici e culturali legati all’impero africano: «Nessun generale italiano fu condannato o epurato per crimini coloniali, e gli “esperti” che avevano monopolizzato la “cultura” dell’espansione coloniale di norma rimasero negli istituti o negli apparati dell’anteguerra». Le ricerche più recenti dimostrano che, anche per questo motivo, nel discorso pubblico italiano gli africani e le africane continuarono a essere una presenza razzializzata. Colonialisti, coloni e “reduci” ebbero un ruolo attivo nell'elaborazione della memoria del passato coloniale e l'Italia, di conseguenza, «evitò l’urto di una decolonizzazione culturale». In un paragrafo opportunamente intitolato “Soggetti diversi, esperienze diverse”, Labanca ricorda che diverse furono le identità degli italiani coinvolti nell'espansione coloniale e perciò «sarebbe bene continuare a distinguere e precisare, prima di tutto, che parlare di unica memoria “nazionale” sarebbe improprio».
Gli anni della seconda fase furono completamente diversi dai precedenti, anche se, in campo economico come in quello politico, le realizzazioni non furono all'altezza delle intenzioni. I ricordi dell'esperienza coloniale scolorivano e il concetto di “memoria” prendeva sempre più il significato di «un discorso generico sull’Africa e un’affermazione sul colonialismo in genere», rispetto ai quali gli italiani si divisero «fra chi aveva maturato un antimperialismo e chi invece rimaneva ancora avvinto ai vecchi miti».
Nella terza fase, a cavallo della fine della Guerra fredda, le divisioni della società italiana si approfondirono. La decolonizzazione culturale era ormai avviata e si registrarono i primi gesti politici e istituzionali di riconoscimento dei crimini coloniali; contemporaneamente, «risorgeva con una forza impressionante il razzismo fra gli italiani».
Con la quarta fase, la conoscenza del passato coloniale italiano è indubbiamente aumentata e si è affermato un approccio più critico ed esplicitamente postcoloniale, interessato alle conseguenze dell'imperialismo sulle popolazioni aggredite e sfruttate. Sarebbe tuttavia «sbagliato ritenere che il Paese abbia davvero “fatto i conti” con quel passato, e che ne abbia derivato una maturazione critica». Al contrario, si sono addirittura udite voci nostalgiche di quel passato. Pare persistere immutato un substrato colonialista, da indagare per comprendere il consenso di cui godono i sostenitori dei miti imperialisti. Significativamente, Labanca ha mantenuto invariato il titolo del quarto capitolo,”Il discorso e la propaganda”, anche se – scrive egli stesso – «negli ultimi decenni, nella ricerca storica, in luogo di «discorso» e «propaganda» sempre più si usa il temine di “cultura”, o cultura diffusa». Lo storico, però, ritiene che i due termini «desueti» indichino più chiaramente l’origine dei modi di pensare e di dire: «propaganda» specifica che si tratta di rappresentazioni volute dal potere politico, mentre «discorso» rinvia a quanto nella società circola “dal basso”. Per comprendere il successo della propaganda è indispensabile l'analisi del discorso: «la propaganda colonialista del fascismo del 1935-1936 ebbe presa – spiega per esempio Labanca – perché non nasceva dal nulla. La sua forza consisteva anzi nel far leva su antichi stereotipi e vecchi retaggi». Quanto poi la propaganda fascista sia diventata un “discorso” tuttora in circolazione è materia di studio di chi si occupa del razzismo italiano contemporaneo. Sul razzismo «diffuso e quotidiano degli italiani d’Africa, nell’Italia liberale come sotto il fascismo», restano preziose le considerazioni esposte nel capitolo settimo, anche se Labanca ricorda che «gli studi sono ancora insufficienti».
L'ultimo dei nuovi paragrafi è dedicato al lavoro degli storici, «difficile e contrastato», dal momento che il mancato intervento delle istituzioni ha lasciato l’opinione pubblica (e la scuola) «in balia delle vecchie spiegazioni e dei vecchi miti, degli episodici e sensazionalistici interventi di giornalisti non sempre informati».
Della «impetuosa» ondata di nuovi studi, comunque, Labanca dà conto – e questo è uno dei maggiori pregi della nuova edizione di Oltremare – nelle ben settantasei pagine dedicate ai riferimenti bibliografici. Qui vengono segnalate le novità storiografiche degli ultimi due decenni, in particolare per quanto riguarda le ricerche sulla struttura della società coloniale, sui «diversi italiani d'Africa», sulla resistenza e la collaborazione delle popolazioni locali, sul periodo repubblicano e sulla memoria coloniale, fra tardiva decolonizzazione e rapida postcolonizzazione.
Leggi anche:
Marco Aime | L’Africa non è un paese
Enrico Manera | Una favola sull'ingiustizia / Igiaba Scego. Prestami le ali
Alberto Volpi, Carlo Greppi | Angelo Del Boca, partigiano e storico del colonialismo italiano









