Jamaica Kincaid alla ricerca delle piante perdute
Può capitare di incontrare per caso nelle nostre città uno sconosciuto, o una sconosciuta, in un caffè o in un’osteria, magari davanti a un cappuccino servito bollente o a un gelido bicchiere di birra. Durante tali incontri la conversazione, dai temi quotidiani, può virare improvvisamente sulla letteratura e sulla politica. Quella persona che ci si trova davanti, a causa degli sconvoglimenti e delle crisi moderne – più precisamente le atroci guerre in Europa e in Medio Oriente – appare confusa. Ciò avviene anche di fronte a una nuova presidenza americana che solo la mente del Nobel Philip Roth in Complotto Contro l’America aveva immaginato (sulla scia delle opere di George Orwell). Il nostro/a interlocutore ad un certo punto confesserà di avere un problema non da poco: non sa più cosa leggere. A suo giudizio il piacere della lettura appare ormai qualcosa di lontano, relegato ad altre epoche, che sebbene recenti, erano più facili da gestire emotivamente. Non sa cosa leggere, non perché manchino i titoli nella propria biblioteca, oppure le idee, ma per un’altra ragione che riesce però ad articolare e a descrivere: Tutto quello che leggo mi provoca ansia. Questa persona – nella quale possiamo riconoscere molti di noi – è sopraffatta dall’ansia dell’attualità. Viene a mancare quella fiducia che non dovrebbe essere difficile trovare tra le pagine della grande letteratura. Genera ansia la mancanza di concentrazione, la disattenzione cronica, lo scorrere spasmodico delle epilettiche, seducenti quanto promiscue Stories che appaiono e scompaiono velocissime sui nostri smartphone. Il frusciare rassicurante delle pagine di carta del libro è ormai un ricordo del passato.
Se per coincidenza, durante quella conversazione, si è appena ritornati da un viaggio a Trieste, città dotata di arcani poteri letterari, nonché vera e propria mecca della letteratura europea, si estrae allora dal proprio zaino di pellegrino laico sul tavolo del luogo di convivio un possibile rimedio ai problemi che affliggono il nostro interlocutore. Si tratta di un volumetto rosa, non di letteratura europea ma americana, ripubblicato di recente da Adelphi. Autrice del volumetto terapeutico è una scrittrice americana, ancora oggi vivente, originaria dell’isola di Antigua e nata alla fine degli anni ’40, quando l’isola caraibica era ancora dominio coloniale britannico. Il suo nome è Jamaica Kincaid e il libro in questione s’intitola Passeggiata sull’Himalaya.
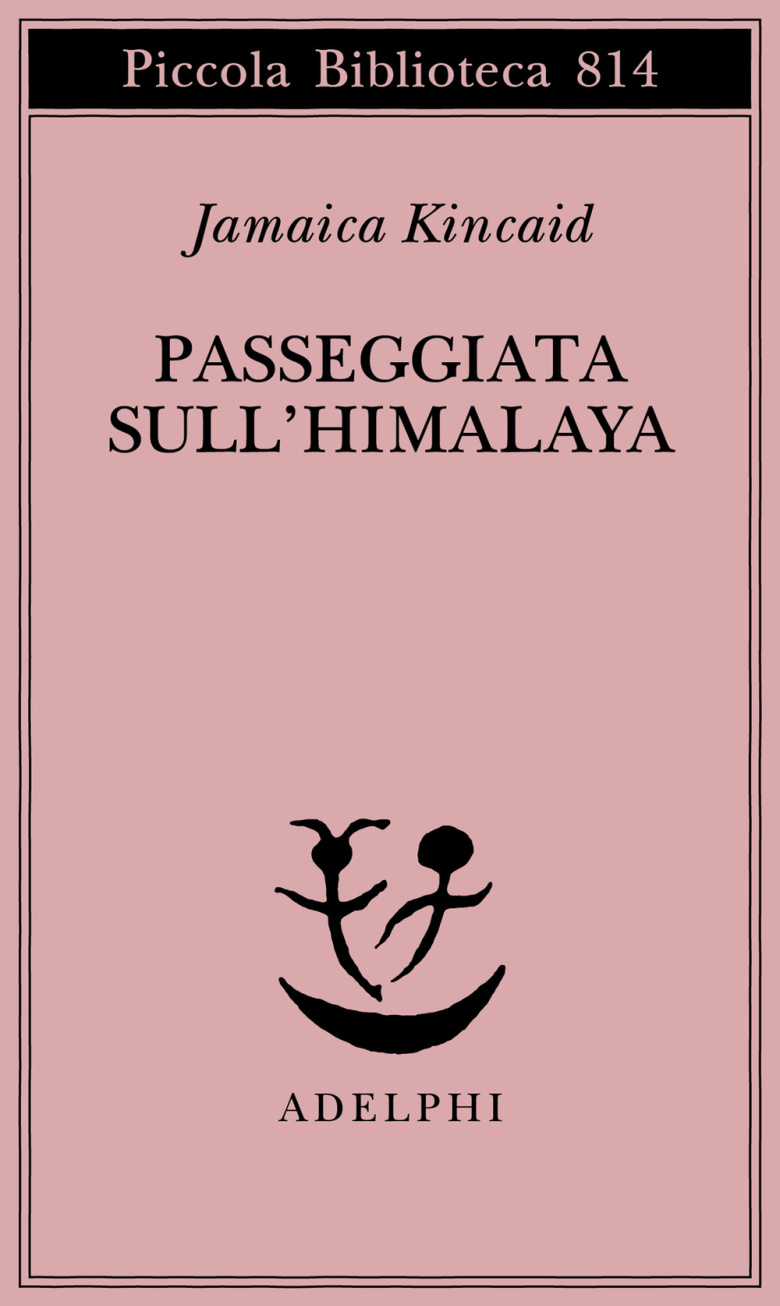
A lungo staff-writer per il New Yorker, oggi docente di letteratura e scrittura creativa all’Università di Harvard, Kincaid nasce all’anagrafe Elaine Cynthia Potter Richardson, nome che ha poi tramutato in quello attuale perché la sua famiglia disapprovava che lei scrivesse. Jamaica Kincaid è una delle voci più originali della letteratura globale. Prima del successo era stata costretta dalla madre ad emigrare dalle tropicali, lussureggianti quanto povere Antille, approdando a New York a soli 16 anni. Non per studiare ma per lavorare presso una famiglia come ragazza alla pari. L’esperienza non durò molto. Jamaica non sarebbe diventata una domestica, ma con un gesto di grande ribellione avrebbe seguito proprio quella strada che le era stata proibita dalla famiglia, diventando una scrittrice. La fama arriva con diverse opere, la maggior parte delle quali vengono ormai ritenute dei classici della letteratura post-coloniale, in gran parte tradotte in italiano dalla casa editrice Adelphi. Ricordiamo in particolare Lucy, traduzione di Andrea Di Gregorio (Lucy, 1990), Adelphi, 2008; Autobiografia di mia madre, traduzione di David Mezzacapa (The Autobiography of My Mother, 1995), Adelphi 1997; Mr. Potter Adelphi 2005, tradotto (come del resto anche Passeggiata sull’Himalaya) dalla scrittrice e critica letteraria Franca Cavagnoli. Come ha scritto la studiosa americana Diane Simmons nel suo studio biografico sull’autrice (Jamaica Kincaid, New York: Twaine 1994), Kincaid rappresenta un caso d’avanguardia per un’intera generazione di quel particolare tipo di letteratura. I suoi libri vengono particolarmente apprezzati oggi per la loro franchezza, per la scrittura accessibile, intuitiva, caratterizzata da analisi introspettive, oneste, che riguardano le complesse relazioni all’interno del mondo famigliare. Inoltre, per i temi che si connettono al fertile intreccio delle radici africane, come l’allegorico-mitologica fine dell’Eden sulla terra, oltre che il dialogo tra le diverse etnie di appartenenza nel contesto post-coloniale.
Quando si inizia a leggere Passeggiata sull’Himalaya si avverte subito il complesso rapporto dell’autrice con la madre, così come la controversa eredità di quel preciso mondo coloniale dal quale lei proviene. Il libro trova le sue radici proprio nel Giardino dell’Eden, nella Bibbia di Re Giacomo e nelle frasi decisive, praticamente scolpite sulla pietra, della Genesi. Furono queste tutte letture decisive, assorbite con sollievo e dolore nel letto dell’ospedale di Antigua, dove un’infante Jamaica Kincaid era stata ricoverata, costretta da diverse infermità, essendo per sua stessa ammissione “una bambina malaticcia”.

Ora però è necessaria un’ulteriore riflessione. Non si intende qui fare di Kincaid un’autrice da leggere per il proprio svago personale o per cercare qualche conforto dai mali della nostra epoca. In realtà vi sono più registri che ci consentono di interpretare Passeggiata sull’Himalaya così come più in generale la scrittura dell’autrice. Come lei stessa ha affermato, in alcune interviste recenti, “la scrittura non ha a che fare con il comfort” e “tutto è politica”. In questi drammatici giorni per gli Stati Uniti e per il mondo che hanno visto Donald Trump far cancellare con le ruspe sui marciapiedi di Washington l’iscrizione a caratteri cubitali BLACK LIVES MATTER (che il presidente Biden aveva voluto), Jamaica Kincaid non ha esitato a definire l’attuale presidente americano suprematista un incrocio tra “il Padrino” e “Satana”.
Questo delizioso, leggibilissimo (forse persino troppo leggibile, sempre se si può peccare in letteratura di eccesso di leggibilità) libro di viaggio venne concepito in realtà nei primi anni Duemila. Una passione quasi innata per la botanica aveva portato l’autrice, nello stesso anno del Millenium Bug, su commissione del proprio editore, ad aggregarsi a una spedizione piuttosto eccentrica nel Nepal. L’autrice si ritrovò a camminare da turista–viaggiatrice, in compagnia di tre illustri botanici americani tutti partiti alla ricerca di semi di piante esotiche. Semi che l’autrice ha intenzione di piantare una volta tornata a casa nel Vermont, tra le mura protette del proprio giardino. Prima di partire, una cinquantenne Kincaid ricava spazio tra le sue giornate di accademica ad Harvard allenandosi intensamente per l’impegnativo viaggio nell’Himalaya che l’attende. Questa volta non è più malaticcia come da bambina ma può sottoporsi invece a corse lunghe “chilometri con uno zaino pieno di sassi sulla schiena” così da ottenere la forma fisica necessaria per l’arduo trekking ad alta quota che l’aspetta. Dopo aver ricevuto i visti necessari ed essersi fatta inoculare i vaccini contro le più strane e pericolose malattie, come l’encefalite giapponese, accade qualcosa che cambierà per sempre la storia contemporanea: l’11 settembre 2001, quel tragico giorno che noi tutti ricordiamo come fosse ieri.

Il viaggio in Nepal viene allora posticipato all’anno successivo. Nel 2002 avranno realmente inizio le settimane di faticoso cammino alla ricerca di una flora selvatica e misteriosa dai nomi in latino con l’obiettivo di raccogliere esemplari significativi, come avevano fatto ad esempio i botanici al seguito del Capitano Cook nel XVIII secolo. Jamaica Kincaid ricorda all’inizio del libro le imprese dello scienziato della Royal Society Joseph Banks, citato tra gli episodi chiave del colonialismo, assieme a Cristoforo Colombo (con il quale provocatoriamente in realtà l’autrice si immedesima). Banks era partito con Cook alla ricerca dell’albero del pane, che considerava un alimento potenzialmente utile per facilità di trasporto e apporto calorico a sfamare gli schiavi neri delle piantagioni coloniali caraibiche.
L’autrice viaggia sovrastata dalle vette alte ottomila metri del Manaslu e del Kanchenjunga. Tra paesaggi spettacolari, di una bellezza da capogiro, strapiombi, vallate, frane, tempeste, temperature rigide, la convivenza frequente con le orribili sanguisughe e la presenza inquietante dei guerriglieri maoisti, la “passeggiata” himalayana diventa presto un arduo trekking dai pernottamenti in tenda. La spedizione viene facilitata dall’aiuto dei portatori sherpa, ma si rivela comunque un’estenuante serie di severe tappe, scandite dall’amico botanico Dan Hinkley. Dagli inizi in cui ci si perde un po’ tra la letteratura comparata sui Caraibi e sugli esploratori-botanici coloniali in Asia, il libro diventa un racconto di viaggio contemporaneo. Ma Passeggiata sull’Himalaya è anche qualcosa di più: un talismano che conduce il nostro sguardo verso paesaggi primordiali e ci fa aprire i polmoni verso atmosfere rarefatte, rendendoci allo stesso tempo partecipi del cosmo letterario di una scrittrice molto speciale. Ciò accade proprio in un momento in cui sentiamo l’urgenza di (ri)leggere la grande letteratura afro-americana, in questo caso quella delle Americhe e delle isole dei Caraibi, confrontandole con le drammatiche e sempre più ardue sfide del nostro tempo. Il questo senso vale la pena di citare da questo libro una frase dell’autrice:
“Avrei fatto questo viaggio anche se non avessi nutrito alcun interesse per il giardinaggio. Il solo vedere la terra raggrinzirsi verso l’alto, il solo fare esperienza del mondo fisico come una serie interminabile di verticali che andavano in su e poi in giù – con quanto c’è di orizzontale, o di diagonale, lì solo per rendere questo mondo essenzialmente verticale un po’più semplice – mi calmava.”
La viaggiatrice si ritrova allora non più al centro di un mitico Eden, ma di un’esperienza umanistica totalmente immersa nel nostro mondo.









