Contro la felicità
«Felici i felici», scriveva Borges. Era la fine degli anni Sessanta e si poteva ancora dire che non ci sono formule per la felicità ma serve piuttosto una predisposizione, oltre alla fortuna di incontrarla e saperla riconoscere, oltre alla saggezza, all’autonomia e perfino a una dose di indolenza per non restare annichiliti dalla sua assenza. Era prima che il significato di felicità subisse una mutazione, che la sua democratizzazione sembrasse sempre di più una tirannia, e la sua commercializzazione diventasse uno dei più grossi business della storia.
Oggi la felicità è forse la merce più pervasiva della nostra economia e uno degli strumenti più efficaci dell’ipercapitalismo per alimentare se stesso. Troviamo qualcuno che ci insegna a raggiungerla e formule di cambiamento e successo personale alla televisione, al cinema, nei giornali, nello sport, negli ospedali, a scuola, nei consigli per l’alimentazione, sulle confezioni di quello che mangiamo. Siamo o non siamo gli artefici del nostro destino?
Sul web ci affidiamo a qualche algoritmo per ottenerla nel più breve tempo possibile. Non abbiamo nemmeno bisogno di cercare quello giusto per noi: nella rete è tracciato ogni nostro bisogno, sarà l’algoritmo stesso a trovarci.
Negli uffici e nelle fabbriche si fanno corsi di crescita personale e ottimismo per aumentare la produttività. In America, il Positive Psycology Center ha elaborato un progetto per istruire i membri dell’esercito affinché, in caso di guerra, possano fare ricorso alle emozioni positive e alla spiritualità: in questo modo saranno «soldati felici», e quindi imbattibili. La questione si complica ulteriormente per il genere femminile: la felicità di una donna ha sempre più a che fare con un corpo che non vuole e non deve invecchiare, che non è mai abbastanza attraente e performante e allora bisogna lavorarci sodo, in una specie di isteria di salutismo e giovinezza a oltranza che crea frustrazione senza fine. «Siamo programmate per uccidere noi stesse», diceva Deborah Levy.
«La felicità permea l’immaginario comune», spiegano Eva Illouz e Edgar Cabans in un libro che si intitola Happycracy. «Sembra l’unica meta per dare un senso alla vita, l’unico metro per misurare il valore di una persona». C’è un ulteriore problema, però: se siamo convinti di essere gli artefici del nostro destino e l’unica cosa che siamo riusciti a ottenere è un destino mediocre, allora abbiamo fallito. Una persona infelice non è solo una persona infelice, è soprattutto una persona che ha fallito.
È così che la felicità a tutti i costi ha trasformato l’infelicità in un tabù. Lo sconforto, la depressione, il senso di inadeguatezza diventano uno stigma, non sono comunicabili perché sottintendono il proprio insuccesso, la propria bancarotta.
Ma qual è stato il momento in cui il concetto di felicità ha cambiato pelle? E perché? Le prima avvisaglie della mutazione genetica si sono viste negli anni Cinquanta, con la corrente di pensiero economico fondata dalla Scuola di Chicago, il primo laboratorio del Neoliberismo: fiducia incondizionata nel mercato, sfiducia altrettanto cieca nello Stato e l’individuo che smetteva di essere parte di una collettività e diventava impresa. L’obiettivo di ogni essere umano era investire su di sé, minimizzando i costi e i rischi e massimizzando i ricavi in qualunque campo della vita, gestendo con efficienza mente, corpo, emozioni, educazione, relazioni e tempo libero. L’identità smetteva di corrispondere all’appartenenza a una comunità e diventava brand.
Da quel momento in poi, i problemi sociali cominciano a essere sempre meno sociali e sempre più individuali: una visione del mondo che fa abbastanza comodo alla tecnocrazia che si deresponsabilizza: disuguaglianze, disoccupazione, precarietà, segregazione sociale, disparità di genere, crisi della democrazia non sono più effetti sistemici ma sono il frutto dell’incapacità dei singoli.
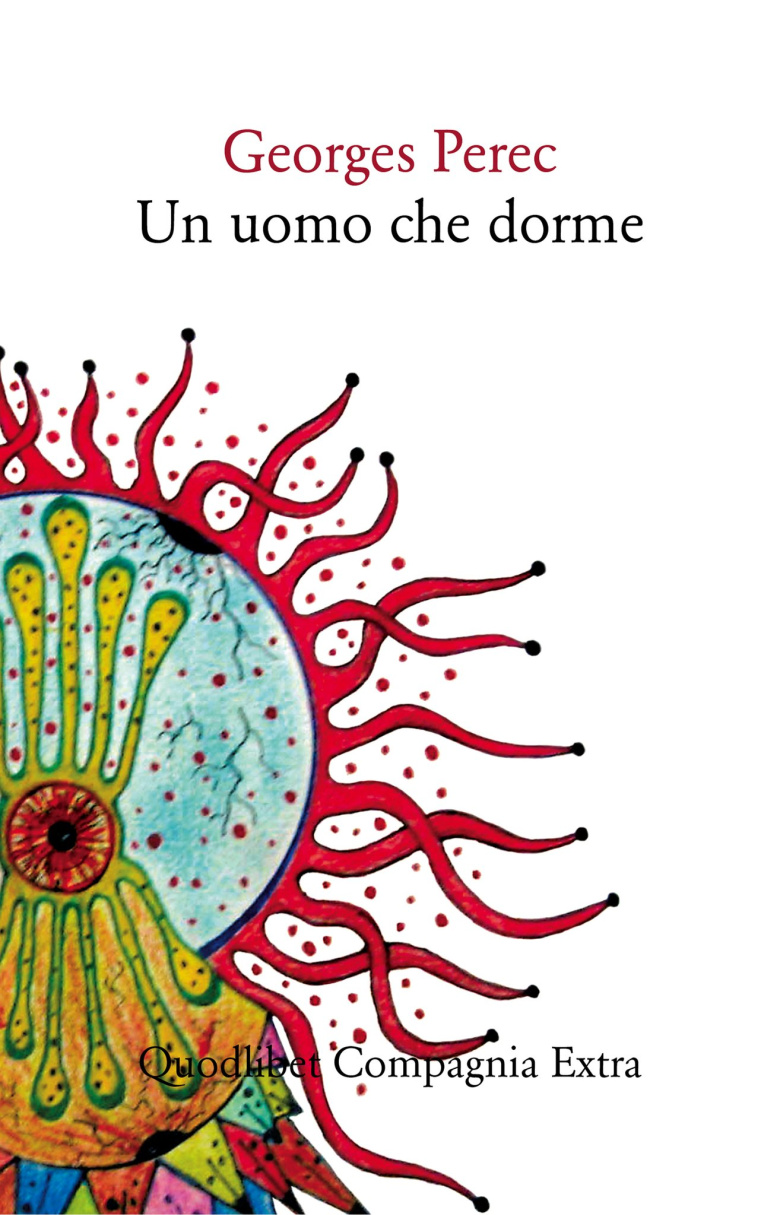
Poi negli anni Ottanta arrivano Reagan e Thatcher e lo smantellamento dello stato sociale subisce un’accelerazione pazzesca. E poi arriva la psicologia positiva di Martin Seligman, all’inizio del Duemila, che con un’intuizione geniale e a tratti diabolica capisce che non solo la malattia mentale e il disagio meritavano di essere trattati e sostenuti dalla psicologia, che non bisognava intervenire solo quando le cose andavano male ma anche quando le cose andavano bene, diffondendo il credo che felicità o infelicità, ricchezza o povertà, successo o fallimento siano solo una questione di scelte personali. Incrementando il grado di felicità anche tra le persone allegre, fiduciose e sane, e massimizzando le potenzialità dell’individuo, fa intendere Seligman, è possibile sviluppare scientificamente un’esistenza densa di significato e degna di essere vissuta. Ed ecco che migliaia (milioni?) di psicologi, coach, influencer, imbonitori, guru, imprenditori, dispensatori di rimedi si mettono in gioco, avviando un mercato di molte centinaia di miliardi per aiutarci ad attirare il genere di mondo che ci piace.
Aiutare le persone a stare meglio non è certo una colpa, ma con il tempo – poco tempo, il processo è stato piuttosto veloce – la felicità trasformata in norma, in obbligo sociale, in dittatura, è diventata un nemico del nostro reale star bene nel mondo. A volte il nostro peggior nemico. Cercare di essere sempre la versione migliore di noi stessi, di superare i limiti, adattarci all’imprevisto con grazia, eleganti e resilienti, attraversare il trauma, qualunque trauma, per farne un’opportunità sociale, può essere pericoloso.
Il contraccolpo psichico, quando l’illusione del tutto è possibile, basta volerlo si sgretola, ci trascina nel senso di colpa e nel vuoto del fallimento. Come se non fossimo stati abbastanza svegli per prenderci quella vita meravigliosa che ci stava aspettando. Se solo avessimo allungato la mano al momento giusto. E invece eccoci qua, a guardare in faccia l’inadeguatezza, ché come artefici del nostro destino siamo stati dei brocchi, capaci di costruire una vita mediocre che non ci basta. Come potrebbe bastarci?
Una recente ricerca condotta da Ipsos su un campione di oltre trentamila persone tra i 18 e i 74 anni dice che l’Italia è ultima in Europa per benessere mentale. Siamo una collettività di ipocondriaci, stressati, depressi, narcisisti, delusi. I soggetti più a rischio sono le donne e i giovani. La disparità di genere avvertita nella vita quotidiana è una delle cause. Poi si aggiungono il senso di inadeguatezza rispetto alle aspettative della famiglia e della società e un uso alienante delle tecnologie e dei social, attraverso i quali cerchiamo di costruirci un’immagine performante e appagata che raramente corrisponde alla realtà. Un’altra indagine condotta dal Musa, gruppo di ricerca legato al Cnr, sostiene che il 10 per cento dei giovani italiani vive in una condizione che si può definire di isolamento sociale. Tutto questo per dire che, nonostante il nostro inseguimento forsennato di una forma di felicità che ci renda speciali e invincibili, non stiamo messi tanto bene.
«Il potere, – afferma Byung-Chul Han, – non è più repressivo, è seduttivo e non è più visibile come sotto il regime disciplinare o quello delle società industriali. Non c’è una controparte evidente, non c’è un nemico che opprime la libertà e contro cui sarebbe possibile opporre resistenza». Il potere diventa sempre più «smart, invisibile e inattaccabile». «Il soggetto sottomesso non sa nemmeno di esserlo, e anzi crede di essere libero». Incapaci di opporci alla libertà che pensiamo di aver scelto, quindi, «ci autosfruttiamo», sostiene il filosofo tedesco, inseguendo la versione migliore di noi, il piacere e la soddisfazione dei desideri, che non finiscono mai, perché ci sarà sempre qualcosa capace di renderci ancora più felici e ancora più speciali. Un’auto, una casa, una faccia nuova, un’impresa pazzesca da fotografare e condividere sui social, un algoritmo costruito a nostra immagine e somiglianza che ci faccia smettere di pensare, la Groenlandia. Protect me from what I want, dicevano le installazioni dell’artista Jenny Holzer e le canzoni dei Placebo. «L’autosfruttamento senza scrupoli porta al collasso della mente. La concorrenza brutale suscita una freddezza, un’indifferenza verso gli altri che finisce per collimare con quella nei confronti di noi stessi», scrive Byun-Chul Han. Esagerando, si potrebbe dire che riconoscere con orgoglio il diritto a essere infelici, dare cittadinanza all’infelicità, rivendicarla, sarebbe una forma di rivoluzione all’economia disumanizzante della felicità.
Nel suo romanzo Un uomo che dorme, Perec parla dell’angoscia delle vite già tracciate da altri. Il protagonista tenta di sfuggirle. È uno studente, un giorno non si alza dal letto, non va a dare l’esame e il suo posto in aula resta vuoto. Da lì inizia la sua diserzione da un ruolo sociale che qualcun altro gli ha assegnato. L’eroe di Perec sceglie così il suo nuovo ruolo del mondo: essere il pezzo mancante del puzzle. Ogni tanto, rileggere Perec può far bene.
Questo testo verrà letto il 12 aprile, presso il Circolo dei lettori di Torino, all'anteprima di Contemporanea Festival, che quest'anno propone come tema degli incontri "Al cuore dei tabù".









