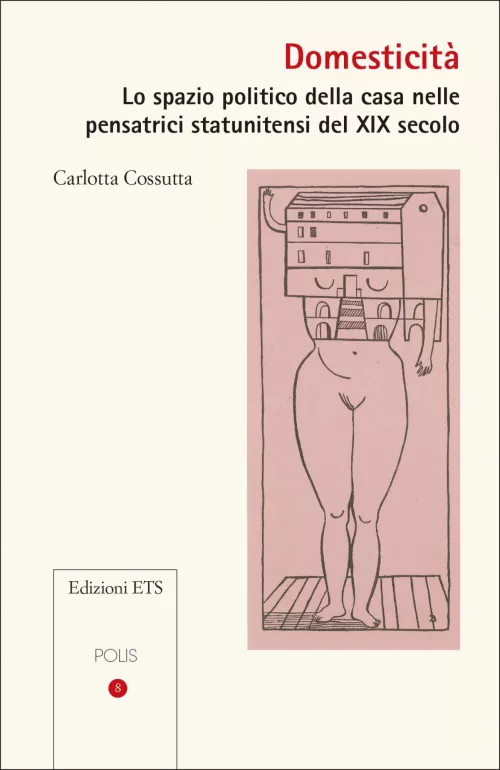Ripensare la casa
Mia madre gioca tutto il giorno. O almeno così le piace dire quando, alle prese con le faccende domestiche, qualcuno le chiede cosa sta facendo. In alternativa, risponde che ha aperto una qualche attività commerciale, ogni volta diversa a seconda della mansione del momento: ora un’impresa di pulizie, ora una sartoria, ora un ristorante, ora una lavanderia. Antifrasi e iperboli a parte, dietro queste due battute si cela un doppio sguardo sul lavoro domestico, che è quello irriflesso del senso comune. Da un lato, l’idea, dura a morire, che non si tratti di un vero e proprio lavoro. A sostenerla è la retorica ancora viva, nutrita dal positivismo tardo-ottocentesco, fatta propria dalle ideologie più tradizionaliste e conservatrici: la cura della casa e della famiglia sono attività gratuite, svolte per istinto e per amore da quella figura, a tratti grottesca, dell’angelo del focolare, a metà tra una mamma pancina e una tradwife. Dall’altro, invece, l’idea che sia una professione a tutti gli effetti, con il suo sapere e saper fare specifico se non addirittura specialistico. Una visione che presuppone, al contrario della precedente, che nei gesti quotidiani di cura non ci sia nulla di naturale, spontaneo o immediato, e implica, di conseguenza, che questi debbano essere appresi. Come a dire che per fare un uovo al tegamino bisogna prima seguire un corso di alta cucina. Ma basta anche solo pensare ai manuali di economia domestica diffusi a partire da fine Ottocento che prescrivono metodi parascientifici per svolgere al meglio le faccende di casa fino a trasformarle, sotto le influenze tayloriste, in una sorta di attività manageriale da gestire secondo il principio di Pareto. Un’idea che ritroviamo, mutatis mutandis, su TikTok, nei profili delle varie guru del meal prep o cleaning influencer.
Modellate dall’associazione tra domestico e femminile, che la cultura ha costruito e solidificato facendola apparire come evidente e assiomatica, queste due maniere di intendere il lavoro domestico hanno attraversato l’intera storia occidentale, presentandosi di volta in volta come il risultato di posizioni ideologiche differenti rispetto al ruolo delle donne nelle case e in società. Scontato forse dire che hanno favorito il perpetuare di discriminazioni e gerarchie di genere, restituendoci l’immagine di una femminilità votata alla cura della casa e della famiglia (la prima) o condannata come l’operaio in fabbrica a una sequenza di gesti calcolati (la seconda). Meno evidente, ma non per questo meno rilevante, che siano state utilizzate dalle stesse donne come grimaldello per aprire le porte di quell’oikos in cui per secoli sono state relegate.
È ciò che si scopre leggendo il libro di Carlotta Cossutta Domesticità. Lo spazio politico della casa nelle pensatrici statunitensi del XIX secolo (2023, Edizioni ETS, pp. 236), che esplora il rapporto tra spazio domestico e pensiero politico femminile. La filosofa politica prende in esame le riflessioni teoriche e le proposte architettoniche di alcune intellettuali d’oltreoceano attive negli anni della battaglia per il suffragio femminile, per mostrare come la casa non sia stata solo un luogo di repressione femminile ma anche un laboratorio di resistenza e rielaborazione politica, sociale e culturale. Dalla lotta per l’indipendenza economica delle donne, portata avanti da Melusina Fay Peirce e Catharine Beecher, ai tentativi di collettivizzazione del lavoro domestico nella colonia di Topolobampo, progettata da Marie Howland. Dalla messa in discussione dei rapporti tra potere e sapere di Jane Addams, al più generale ripensamento della democrazia nell’ottica di una reciprocità, comprensione e coesione sociale che prende forma nel settlement di Hull House. Dalle critiche di Antoinette Brown Blackwell ed Eliza Gamble rivolte alle teorie evoluzioniste, sfruttate per favorire la subordinazione femminile, alle proposte di esternalizzazione dei servizi essenziali da parte di Charlotte Perkins Gilman, messe in pratica infine da Alice Constance Austin nelle case senza cucina progettate per Llano del Rio.

Come sottolinea Cossutta, pur nelle differenze di ciascuna proposta, il paradigma politico a cui le varie Peirce, Beecher, Addams o Gilman si rifanno è quello fondato sulla cooperazione armonica che vede le ingiustizie come errori da correggere in vista del progresso comune. Un paradigma, dunque, che predilige un’azione politica riformista ma non reazionaria, progressista ma mai violenta, orientata all’educazione ed evoluzione sociale piuttosto che al conflitto aperto. Il che non sminuisce né minimizza il lavoro di queste intellettuali e la forza propulsiva del loro pensiero. Del resto, come il semiologo della cultura Jurij Lotman ha osservato, i cambiamenti sociali, i “movimenti in avanti”, le trasformazioni all’interno dei sistemi culturali non avvengono solo attraverso rivoluzioni, scoperte inattese e rotture epistemologiche forti, ma anche mediante processi lenti, graduali, costanti che, al contrario di quelli esplosivi, assicurano una certa continuità con il sistema. Così, laddove molte delle letture politiche del periodo in materia di emancipazione femminile tendono ad assegnare un ruolo quasi esclusivo ai movimenti suffragisti – battaglie più vicine per modalità e impatto a quei processi esplosivi di cui parlava Lotman – Cossutta sembra invece muoversi su una linea, per così dire, minore, dando voce a intellettuali che, anziché concentrare ogni sforzo sull’allargamento del diritto al voto, puntano i fari sulla casa.
Si potrebbe pensare, in questo senso, che Domesticità sia l’esito di un’operazione archeologica, tesa a recuperare le tracce di un passato da riscattare per scrivere una nuova storiografia femminista. Eppure, lo sguardo che l’autrice rivolge al lontano XIX secolo non è quello di chi colleziona e ordina dati per consegnarli, ripuliti da errori, calcoli sbagliati e cattivi apprezzamenti, alla cultura. Cossutta, infatti, non si esime dall’evidenziare i limiti, le impasse e le contraddizioni delle varie proposte che vaglia, mettendone in luce anche i lati più controversi, come la vicinanza con alcuni paradigmi razzisti e classisti (il potere, direbbe Foucault, è qualcosa che circola e non che si detiene). E tuttavia, il suo non vuole essere un resoconto totalizzante che segue uno sviluppo lineare. Piuttosto la filosofa politica lungo tutta la sua trattazione si preoccupa di individuare una serie di nodi critici e metterli in relazione tra loro, rintracciando parallelismi, rovesciamenti e deviazioni e chiedendo a noi lettori di cogliere la sfida che le diverse intellettuali, con le loro idee e i loro progetti, lanciano all’organizzazione sociale e ai modi di abitare. Se Domesticità è una storia, allora non è certo una storia-ricordo, la fotografia di qualcosa che è destinato a rimanere cristallizzato in un tempo passato e di cui non resta che dire “è stato”. Piuttosto, la scommessa di Cossutta è che questi lavori possano parlare ancora al nostro presente. Non tanto individuando l’origine di certe strutture di potere, forme di relazione sociale e modi di concettualizzazione del domestico, quanto invece per la loro capacità di informare il nostro sguardo, rendendolo più consapevole, affinato e attento – in una parola: critico – per affrontare le sfide d’oggi e quelle di domani. La posta in gioco, in fondo, è la stessa che Foucault attribuiva alla sua genealogia della psichiatria: scrivere una storia che possa essere strategicamente efficace.
È sotto questa luce, quindi, che vanno osservati i tentativi femminili e femministi di riscrittura del domestico presentati in Domesticità, i quali non mirano solo a migliorare la condizione delle donne, sollevandole dalle fatiche quotidiane, ma, più radicalmente, tentano di produrre un cambiamento di più ampia portata che investe vari aspetti della vita sociale. Cosa che risulta particolarmente evidente nel caso delle proposte abitative concrete a cui Cossutta dedica alcune pagine densissime. Prendiamo ad esempio Topolobampo e Llano del Rio, le due colonie utopiche progettate rispettivamente da Howland e Austin, che pongono al centro della loro architettura concettuale i principi di condivisione, cooperazione, coabitazione e comunitarismo. Accumunate da una visione socievole dell’abitare che rifiuta l’individualismo più estremo, a Topolobampo e Llano del Rio la casa non è più pensata come uno spazio privato affidato alle donne, ma parte di un sistema più ampio di servizi collettivi in cui cucine e lavanderie, collocate fuori dalle mura domestiche, si fanno condivise per favorire la collaborazione tra donne e il coinvolgimento degli uomini in una più equa distribuzione dei compiti. Si tratta quindi di iniziative che incarnano valori ancora oggi condivisibili ma la cui sostenibilità si rivela difficile da mantenere. A pochi anni dalla loro fondazione, entrambe spariscono. Cosa è andato storto? Siamo sicuri che sia stato solo un mix di cattiva gestione, deficit di risorse e stratificazioni culturali difficili da scardinare? O forse l’idea che una diversa organizzazione spaziale potesse di per sé generare e garantire un cambiamento sociale ha influito sul loro fallimento? Che questi progetti riflettano una concezione fin troppo deterministica tanto dello spazio quanto dell’agire umano, ridotti a variabili connesse da un rapporto di causa-effetto? Che il loro limite fosse proprio l’illusione che bastasse ripensare l’architettura per trasformare la società, dimenticando che l’una e l’altra si modellano reciprocamente?

A suggerirlo è di fatto la stessa Cossutta. A infrangere il sogno di Topolobampo, si legge in Domesticità, sono le resistenze della comunità maschile nell’accettare i principi di equità di genere su cui si fonda la colonia: nonostante l’esternalizzazione dei servizi in edifici collaborativi, la loro partecipazione alle attività quotidiane resta minima, generando proteste tra le donne e portando infine la stessa Howland ad abbandonare la colonia. È chiaro però che non si tratta solo di un problema di disallineamento tra donne e uomini, di ritmo di trasformazione dei valori. Howland, nel progettare Topolobampo, prevede un Abitante Modello, un fruitore ideale della città inscritto nello spazio cittadino, che condivide i valori alla base della collettivizzazione delle faccende domestiche. Tuttavia, chi abita davvero la colonia si distacca da questa immagine implicita, dimostrando di non conformarsi all’aspettative. Lo stesso si può dire per il progetto di Austin, il cui abbandono, avvenuto poco dopo l’avvio dei lavori, si lega a un ulteriore fattore. Infatti, come sottolinea Cossutta, nel caso di Llano del Rio, sorta in una località desertica, la scarsità d’acqua e di case e infrastrutture in grado di stare al passo con la crescita esponenziale della comunità, portano a un diffuso malcontento e allo sviluppo di un sentimento di attaccamento alle cose, finendo per erodere i principi egualitari e di derivazione marxista a fondamento della colonia. Un esempio sfortunato di efficacia simbolica, per dirla con Lévi-Strauss. Come nel caso analizzato dall’antropologo, in cui il canto dello sciamano, ponendosi come significante, è in grado di agire efficacemente sul corpo della partoriente, suo significato, garantendo la riuscita del parto, allo stesso modo l’insediamento di Llano del Rio mette i suoi cittadini nelle condizioni di appassionarsi negativamente, riorientando il loro agire e sentire in un’ottica individualistica.
Ecco che riprendere esperimenti come quello di Topolobampo o Llano del Rio non è utile solo a vedere come le donne cercassero di riorganizzare materialmente lo spazio fisico affinché riflettesse una diversa concezione dei rapporti di genere, ma consente anche di trarre qualche insegnamento. A condizione, è chiaro, di dar voce anche ai loro fallimenti e di non considerare eventuali successi come soluzioni pronte all’uso. Ogni idea, del resto, come osserva Merleau-Ponty, è un’idea situata, radicata nel tempo e nello spazio da cui origina e, inevitabilmente, ne porta con sé le tracce. Lungi dall’essere un gesto anacronistico, che nega la distanza tra il loro e il nostro tempo, recuperare il passato significa quindi non semplicemente ripeterlo ma confrontarlo e soppesarlo con il presente, costruendo un sistema di traduzione tra i due. È solo così che Topolobampo o Llano del Rio smettono di essere esperimenti di un tempo lontano e, sollecitando una riflessione più ampia sul rapporto tra spazio e società e sul tema del vivere insieme, si trasformano in strumenti critici per ripensare la separazione tra pubblico e privato, facendosi lenti attraverso cui osservare anche le attuali tendenze nelle forme di abitare, così vicine a quelle sperimentate da Howland e Austin.
Negli ultimi anni, infatti, si stanno diffondendo modalità abitative basate sulla collaborazione e la collettivizzazione, con soluzioni che liberano le case da alcune funzioni e le aprono verso spazi condivisi. Una tendenza che non si riscontra solo nei classici condomini, in cui spazi supplementari a servizio dei residenti (palestra, orto, biblioteca, area giochi, etc.) si fanno sempre più spesso imprescindibili, ma anche nei vari co-living, co-housing o cluster-flat che fanno del vivere insieme la cifra specifica dell’esperienza abitativa offerta. Soluzioni che, tuttavia, sembrano soffrire un po’ della stessa concezione aprioristica e deterministica delle colonie utopiche. Basta trascorrere qualche giorno in un co-living per accorgersi che gli utenti, anche quando si servono degli spazi comuni, tendono a ripiegare sulla dimensione privata, limitando l’effettiva condivisione della quotidianità e finendo per ricreare nelle quattro mura della propria camera una casa in miniatura. Così, ad esempio, nelle grandi sale da pranzo si mangia fianco a fianco ma senza condividere convivio e convivialità, oppure ci si ritira nelle proprie stanze, consumando il proprio pasto a letto davanti allo smartphone. Ritorna la figura fantasmatica, di barthesiana memoria, della camera da letto, su cui Gianfranco Marrone è tornato di recente (si veda qui). Insieme casa e cella, rifugio e prigione, la camera è in grado di funzionare come sintesi mitica tra vita collettiva e individuale, realizzando quella nuova forma di vivere insieme che Barthes chiamava idioritmia. A patto, è chiaro, che la porta resti aperta.