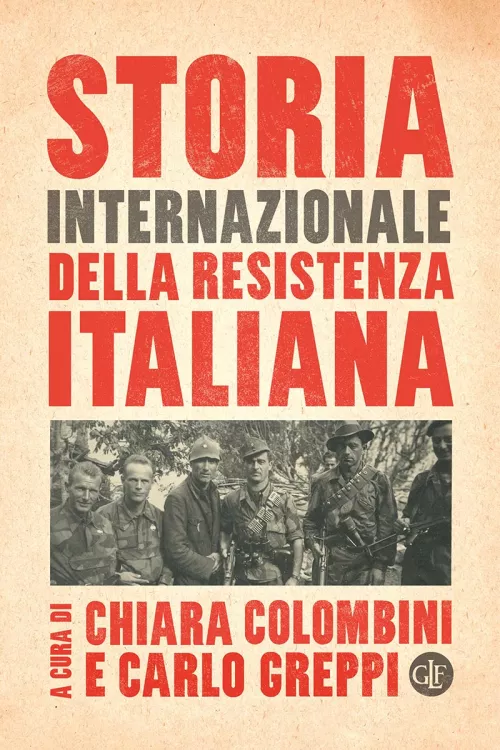Il volto internazionale della Resistenza
«Oggi noi, partigiani, sentiamo un fratello nel tedesco antihitleriano, un nemico mortale nell’italiano fascista». Così si legge in un opuscolo GL, redatto da Massimo Mila (e citato da Claudio Pavone in Una guerra civile, 1991), con parole che da un lato riconoscono un movimento europeo di resistenza nei paesi occupati dall'Asse e dall'altro inquadrano la guerra come una guerra civile europea che ha un carattere ideologico e valoriale, così ovvio per i suoi destinatari che non necessitava di ulteriori spiegazioni.
Il focus nazionale, tipico delle storiografie del primo secondo Novecento e il riferimento alle motivazioni patriottiche nella memoria dei decenni successivi hanno – con alcune significative eccezioni – caratterizzato la narrazione dominante sulla Resistenza, che in Italia secondo un tropismo diffuso è stata letta come un secondo Risorgimento; allo stesso modo, nel parlare di Resistenza europea si sono moltiplicati gli sguardi sulle lotte antinaziste ma non sempre si sono colti gli intrecci e il carattere transnazionale, e non solo europeo, del fenomeno. Tutto questo appare ancora più straniante in Italia, per il ruolo dell'imperialismo fascista e per la sua centralità nell'andamento bellico sullo scacchiere mediterraneo e sul fronte africano. Senza dimenticare la specificità che li riguarda, le colonie italiane in AOI sono infatti i primi territori liberati dal nazifascismo già dal 1941 e le sconfitte dell'Asse del 1942 sono un turning point del conflitto.
A partire da queste premesse la Storia internazionale della Resistenza italiana (Laterza 2024) – una sintesi collettanea di ricerca coordinata da Chiara Colombini e Carlo Greppi – indaga la presenza di combattenti “stranieri” nella Resistenza italiana.
Il libro sistematizza con interventi originali quanto, pur noto alla ricerca di settore, sembra rimanere confinato nella dimensioni locale e nell'attenzione di quanti siano interessati alle eredità politico-valoriali della resistenza, rimanendo ignorato dal discorso egemone sulla storia contemporanea.
Una visione di insieme del lavoro restituisce l'intreccio di storie e attraversamenti che rendono l'immagine della Resistenza più complessa di quanto la possa cogliere l'uso politico e semplificato della storia. Enrico Acciai descrive gli effetti dell'esperienza della guerra di Spagna sul partigianato, con la sua generativa militanza internazionalista; Eric Gobetti scrive sulla presenza degli jugoslavi, la cui identità è costitutivamente negoziata, mista, stratificata; Isabella Insolvibile si occupa dei soldati alleati, ex prigionieri del fascismo, di cui una minoranza decide di riprendere le armi per difendere la gente che li ha accolti. Mirco Carrattieri marca la presenza ossimorica, esigua quanto significativa dei “partigiani tedeschi”, disertori e oppositori non militari; Laura Bordoni raccoglie le storie frammentate e poco decifrate di soldati sovietici, polacchi e cecoslovacchi, disertori dai reparti puntivi della Wermacht in cui erano stati arruolati in alternativa all'internamento nei campi. Valeria Deplano e Matteo Petracci raccontano le vicende pressoché ignote delle decine di partigiani “neri”, meticci e afrodiscendenti, sudditi delle colonie, per i quali la lotta di Liberazione è stata anche lotta anticolonialista; Liliana Picciotto indaga il passaggio dalla fuga alla lotta degli ebrei stranieri presenti sul territorio italiano (in particolare nelle Valli Cuneesi) a seguito dei provvedimenti e degli eventi che li hanno colpiti; analogamente, Luca Bravi parla di combattenti rom e sinti, altri soggetti le cui vite si intrecciano con le persecuzioni e il desiderio di riscatto che ne deriva. È in particolare in queste storie, minoritarie e di minoranze, che le storie individuali mostrano con particolare evidenza l'uscita dai confini, prima di tutto quelli della definizione stereotipica e razzializzata di appartenenti a un gruppo, per riprendersi la vita e l'identità personale negata.
La documentazione sul partigianato e gli studi più recenti permettono di individuare decine di nazioni di nascita e provenienza tra i combattenti, con situazioni differenziate a seconda dei contesti territoriali. Questo dice molto su quante persone siano state travolte dalla furia militare e ideologica del nazionalsocialismo (e del fascismo suo alleato) e sul ruolo che hanno avuto le contingenze di luoghi ed eventi nella decisione di combattere nella Resistenza. I due principali vettori di provenienza sono stati la diserzione dalle forze armate tedesche e la prigionia in seguito alla cattura da parte dell’esercito italiano: i partigiani stranieri nella Resistenza italiana sono dunque parecchie migliaia, non meno di quindici o ventimila (circa un decimo del partigianato), entrati singolarmente nelle formazioni incontrate lungo la strada o in gruppi caratterizzati proprio dall'eterogeneità (coma la Banda Islafran nelle Langhe o la Banda Mario nelle Marche).

Ne risulta l'immagine di una lotta partigiana in Italia che «fu anche una storia cosmopolita» e che mette in crisi innanzitutto la storia per medaglioni identitari, che credevamo consumata ed estinta (ed è invece oggi uno dei perni della pedagogia nazionale che informa i documenti ministeriali sull'istruzione). Di più: dal mosaico di storie e spaesamenti risulta chiaro che, se alla base della guerra ci sono le meastasi delle identità fattesi fascismi, la lente della nazione non può cogliere, se non grossolanamente, i fenomeni storici. Le storie di vita ricostruite nei saggi che compongono il libro sono paradigmatiche proprio per la loro eccezionalità: le traiettorie individuali nel loro fondersi nel movimento collettivo mostrano come le appartenenze vengano dopo e indipendentemente dalle identità nazionali stereotipate e si costruiscano nel farsi dell'esperienza, sul terreno e in base agli eventi subiti e alle scelte fatte di conseguenza.
I contesti e la valutazione numerica dei combattenti fanno emergere un interessante discorso su quanto questa Resistenza senza confini, transazionale, internazionalista o meticcia abbia saputo realizzare. Il saggio introduttivo, di Colombini e Greppi, mostra i problemi epistemologici e metodologici della presenza dei partigiani non italofoni, a partire dalle difficoltà innanzitutto linguistiche, di identificazione e di tracciamento sui documenti disponibili e al tempo stesso sottolinea la spinta valoriale e i significati della loro presenza: l'obiettivo della liberazione dall’occupante significa anche il contrasto attivo dell’oppressione e della violenza dei fascismi, la reazione alla guerra ai civili e il rigetto di un’ideologia di dominio. Colpisce che i partigiani “non nativi” cerchino di ri/prendere le armi, al posto di nascondersi o arrendersi, cosa più facile e diffusa; oltre la necessità, questa scelta manifesta il surplus di motivazione implicato da una scelta radicale senza ritorno garantito. Cosa altro è se non questo, il prendere le armi in un esercito di volontari contro l'Asse nei venti mesi del 1943-45?
Da qui emerge la spinta euristica a indagare ancora su una ulteriore dimensione universalistica, «una guerra ideologica internazionale accanto alla guerra patriottica, alla guerra civile e alla guerra di classe» – già individuate da Pavone – che si stratificano nella Resistenza e nella sua moralità.
L'eccezionalità dell'esperienza resistenziale è stata tale da “curvare” lo spazio e il tempo, ha sfarinato il primo e accelerato il secondo; è stata capace di trasformare le persone dando loro spazi di autonomia e autodeterminazione prima altrimenti impensabili, facendole uscire da ruoli, status e da precedenti nozioni di sé stessi, oltre i confini di classe, ideologia, genere... Qualche cosa di simile sembra succedere con le identità statualizzate, con uno scioglimento dell'idea di nazione chiusa in se stessa e cristallizzata e l'ampliamento della nozione di patria, una cornice più larga, indefinita e “calda” che prevede una «più vasta solidarietà fra i popoli liberi» e per cui si può morire, sperando di poterci vivere in futuro.
Questo fa a mio avviso della Storia internazionale della Resistenza italiana un libro importante per l'ottantesimo anniversario della Liberazione: la ricostruzione si salda con un impegno interpretativo capace di interagire con un presente in cui – su scala mondiale – lo Stato nazione mostra al tempo i suoi limiti e il suo fallimento e proprio per questo insiste nella sua recrudescenza. (Rimando per questo alle analisi – mi pare poco recepite quanto lucide – di Rana Dasgupta)
Con la fine della guerra e del nazifascismo arriva la pace e anche il ritorno all'ordine. Tornano i confini, ancora una volta diversi e non sempre giusti. Dove è ora la casa? Il rientro dei combattenti nei loro paesi avviene con frontiere cambiate, conti da regolare e memorie da aggiustare, vite da reinventarsi e un passato in Italia che si inabissa e sparisce nelle pieghe della memoria. Sono molte le storie chiuse in scatole per decenni e riemerse solo recentemente, con la morte dei protagonisti e le domande rimaste alla generazione dei nipoti. Continuano a esserci corrispondenti e turisti che chiedono informazioni agli Istituti per la storia della Resistenza, portano testimonianze e tracce da decifrare del passaggio di loro parenti antenati sui territori.
E poi ci siamo noi, che in questo ottantesimo Venticinque aprile troviamo strano ciò che all'epoca era «del tutto naturale e logico», come scrive Roberto Battaglia: allearsi per combattere i fascisti dopo essersi trovati in un Paese straniero. Anche questo è un discorso sul presente.
«Dove sono William, Jhon, Boris, Wladimiro, Jean, Hans? Saranno ritornati alle loro case. Noi siamo convinti che non hanno mai dimenticato le felici giornate trascorse insieme ai monti. […] Lo stesso ideale ci univa: l'amore per la libertà. Vorremmo rivederli e dire loro che la lotta non è ancora terminata; che il mondo sognato ai monti è ancora di là da venire.»
(29 novembre. Numero Unico della Brigata d'Assalto Garibaldi “Ugo Muccini”, Sarzana 1947)
Leggi lo speciale sul 25 aprile e gli articoli di Doppiozero dedicati alla Resistenza.