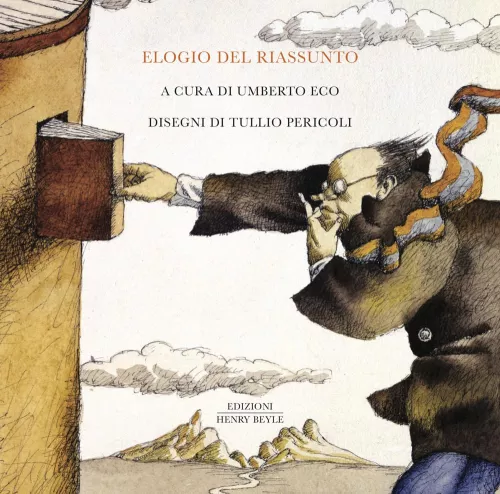La difficile arte del riassunto
Il riassunto sembra semplice ma non lo è affatto. Si crede ne esista un solo tipo ma non è vero. Siamo abituati a considerarlo come la banale riduzione di un testo, un esercizio per condensare in poche righe ciò che è già stato detto. È così che, per fare un esempio, il riassunto viene inserito come modello di scrittura tra le indicazioni della Commissione ministeriale scuola dell’infanzia e Primo ciclo di istruzione. “Scrivere è vivere”, si legge – senza alcuna retorica, per carità – nella grida del ministro Valditara, e poiché riassumere è scrivere, se ne deduce che riassumere è vivere. Per questo, “carta e penna, lettura ad alta voce e piccole biblioteche d’aula devono convivere armoniosamente con assistenti virtuali e augmented learning (…). È noto infatti (a chi? e perché?) che saper scrivere equivale a saper concettualizzare, strutturando il pensiero in un orizzonte di senso che è anche introspezione, cura di sé”. Leggendo queste parole, oltre alla modesta proposta di associare e scrivere le paroline magiche in modo chiaro, verrebbe da dire che manca loro solo il rosolio della signorina Felicita per brindare all’idillio tra una scuola alla De Amicis e un’Heidi del terzo millennio.
Ma lascio i concetti ai concettismi per concentrarmi sul fatto che il riassunto non è mai solo una mera riduzione. Richiede una riflessione sui contenuti da selezionare, una scelta ragionata, una prospettiva interpretativa e un punto di fuga da un testo che diventa un altro. Per questo dev’essere innanzitutto un inventario ordinato: riorganizza i tratti essenziali di un’opera senza mai intaccarne il nucleo di senso e la struttura originaria. Quali sono allora i tratti da evidenziare in un riassunto? Può dirsi tale una riduzione basata sull’assemblaggio di tratti non essenziali o non pertinenti al testo di partenza? Viceversa, chi decide cosa sia essenziale e cosa no nel testo di arrivo? Che dire poi dei sunti evocativi, quelli che mostrano come non si sia mai in presenza di una riduzione oggettiva e neutrale? Prendiamo Pamela di Richardson. Più di 600 pagine di libro che narra della virtù premiata e contrapponiamola alla sua feroce parodia, An Apology for the Life of Mrs. Shamela Andrews, con cui Henri Fielding in poco meno di 200 pagine (quasi un meme per l’epoca) mette alla berlina ipocrisie e strategie di autoaffermazione della nostra eroina, con tanto di moralismo a buon mercato. Quanto il riassunto influisce sulla parodia? Quanto intacca i tratti essenziali del mondo messo in pagina da Richardson? Per orientarmi, anche grazie agli interventi che mi hanno preceduto su queste colonne, devo tornare al dibattito sull’Elogio del riassunto, sorto nei primi anni Ottanta del secolo scorso in seguito alla sfida lanciata da Umberto Eco ad alcuni suoi illustri colleghi scrittori.
Riassumo brevemente. Uscito il 10 ottobre 1982, l’“Elogio del riassunto” di Eco, che già rievocava nel titolo quello ben più celebre di Franti, fissa le regole del gioco: il riassunto da solo non basta e fa male; è più importante farlo che leggerlo; insegna a scrivere e il tempo narrativo spesso coincide con quello della scrittura; bisogna lasciar cadere qualcosa e prendere una decisione su ciò che è centrale; il riassunto di un romanzo, in particolare, non è mai un caso di semplice informazione: è un atto critico. Una settimana dopo, Calvino riprende il testimone e rilancia su La Repubblica con un altro pezzo da maestro e dal titolo geniale: “Poche chiacchiere”. Calvino separa il riassunto dal suo ben più nobile parente, il Commento. Le regole sono simili a quelle di Eco, tranne in un paio di punti: il riassunto ideale non deve essere un commento in sedicesimo e deve contenere pensieri e parole presenti nell’opera di partenza.
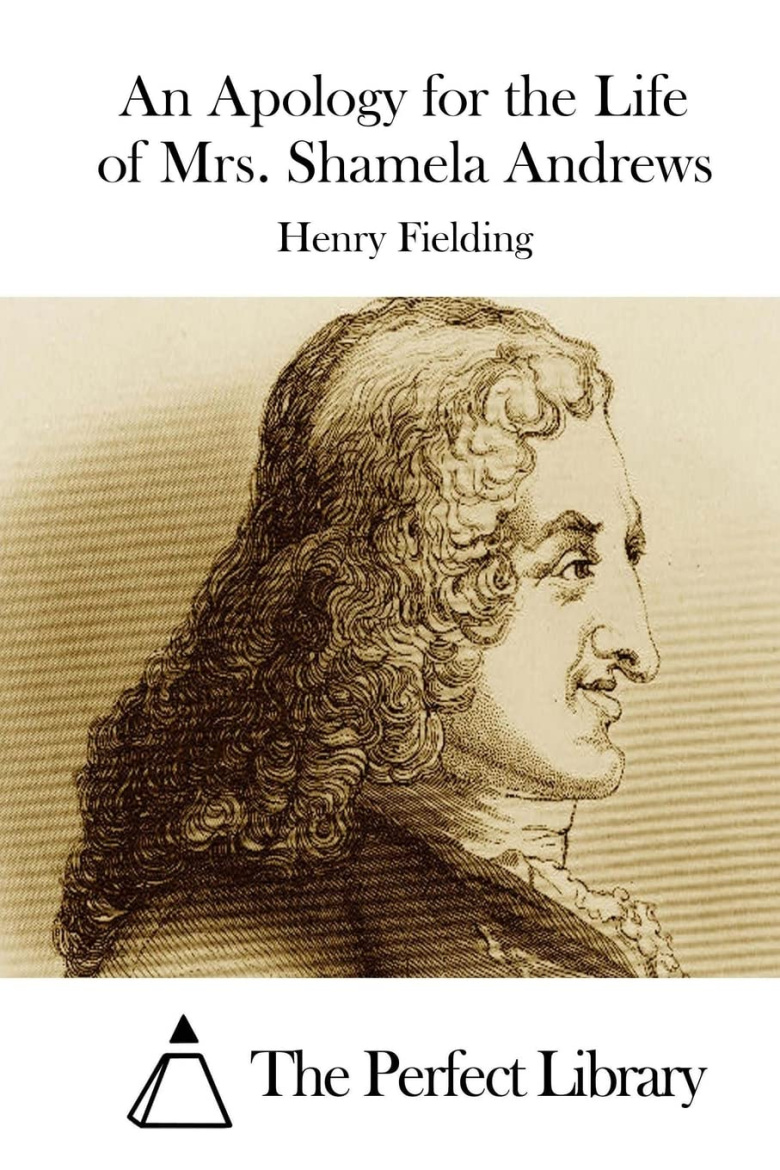
Detto con le parole della logica, per Calvino il riassunto si distingue dal commento perché deve – o quantomeno dovrebbe – raggruppare elementi individualmente necessari e congiuntamente sufficienti per rientrare in una lista chiusa che riduce il testo di partenza. Viceversa, più i tratti della lista sono aperti, più ci si avvia verso la totale emancipazione dal testo di partenza. Il che è quanto, a detta di Calvino, fa Arbasino, autore di un “commento divagazione”, cioè di un testo in cui le somiglianze di famiglia con il capolavoro di Flaubert dicono tutto sull’autore del riassunto e sul suo stile, e poco sull’essenza della fonte. Ma avrebbe mai potuto andare diversamente? Con Arbasino alle prese con Madame Bovary?
Anni dopo, in piena era Twitter, Marco Belpoliti ha raccolto il testimone e ha preso di petto la questione: i 150 caratteri sono riassunti, commenti o riscritture? Il dibattito su Doppiozero è ancora vivo. A corredo, invito i lettori a leggersi l’Elogio del riassunto uscito da qualche settimana per i tipi delle edizioni Beyle e adornato dai riassunti (o commenti visivi?) di Tullio Pericoli, divertendosi a tracciare i confini tra un genere e l’altro e giocando con gli esercizi di stile dei vari scrittori. Rispetto al commento, per me l’essenza del riassunto sta nell’aggiungere qualcosa al testo mentre si seleziona qualcos’altro. Servendosi di un’immagine musicale, è come un battere che mantiene e rivela il levare.
Ma non mi fermo qui e rilancio. Perché diverso ancora è invece il caso della sintesi, strumento principe delle intelligenze artificiali generative. Esse marcano infatti le fasi salienti di una registrazione compresa nel testo di partenza, e lo fanno perché serie anche contraddittorie di termini siano individuate per frequenza in depositi documentali. La registrazione di testi sulle piattaforme web, oggi, precede l'iscrizione, mentre, come ci spiega da tempo Maurizio Ferraris, una volta il processo seguiva un ordine opposto: prima si scriveva, si fissava l’informazione, poi si procedeva con la registrazione su un supporto che fungeva da protesi esterna di una memoria da tradire. Così, un libro non era che il tardo tradimento di un altro precedente. Ora, invece, la registrazione fa rientrare in un ordine i dati, trasformandoli poi in qualcosa di comprensibile. È qui che la sintesi si caratterizza come forma distintiva della civiltà della registrazione. Se lasciata al livello di una semplice lista di istruzioni essa non prefigura ma piuttosto conferma quanto generato dall’intelligenza artificiale.
Letto oggi, in piena rivoluzione nella cosmologia della conoscenza, l’Elogio del riassunto svela un elemento di continuità con l’evo analogico. Pur nel cambiamento epocale, esso intercetta ancora quell’atto critico che Eco sanciva e che Calvino approvava. L’intenzione, cioè, di chi ha operato certe scelte, perché l’ha fatto e come ha governato il processo di formazione di un sapere nuovo. Così, mentre la sintesi si fonda su caratteristiche intrinseche e chiuse del testo, imponendone la struttura, il commento si appoggia su una testualità oramai emancipata. In mezzo sta il riassunto.