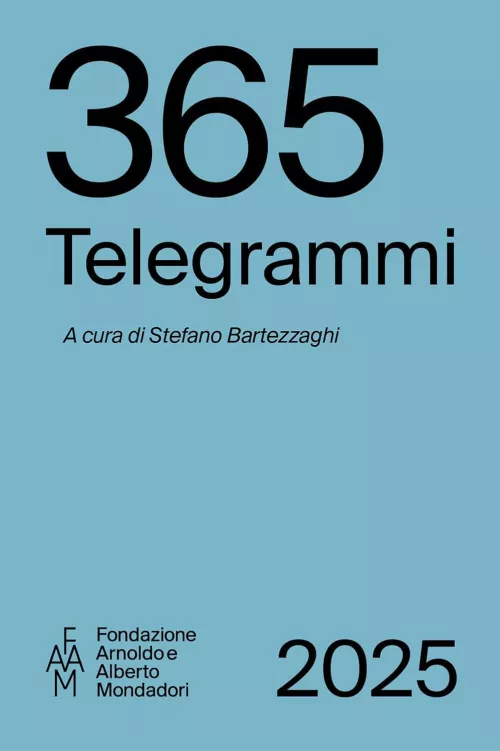Telegrammi d'autore
Per quanto oggi non esiteremmo a inserirli ai primi posti in una lista di oggetti di comunicazione oramai defunti, i telegrammi e il loro strumento, il telegrafo, hanno segnato e segnano ancora la nostra storia. Un lungo filo ininterrotto lega, infatti, le sacre profezie condizionali (Ancora Quaranta giorni e ninive sarà distrutta stop vendicativamente, YHWH) ai messaggi telegrafici e alle istantanee su Twitter/X e Instagram. Sono tutti modi di comunicare accumunati dal tentativo di cogliere l’istante nella concisione del messaggio e dal fatto che il loro esito richiede o impone, se non esige, una reazione.
Nel Conte di Montecristo, Dumas individua proprio nel potere di sviare messaggi da parte di un povero telegrafista, corrotto dal Conte, la malapianta della manipolazione dell’informazione. Dire che il Montecristo agiva a fin di bene non è di grande sollievo, pensando all’oggi. Vero è che lo strumento che ha in mente Dumas non è quel telegrafo che funzionava su cavi elettrici e che, servendosi dei segnali di Morse, portò al primo telegramma inviato da Washington D.C. a Baltimora, il 24 maggio 1844 con un messaggio, guarda caso, biblico: «che cosa ha fatto dio!» (Numeri, 23:23). Fu da quello che, per metonimia, generarono quei gualciti e ripiegati fogli giallognoli o verdini, con brevi frasi appiccicate: i telegrammi. Piuttosto, Dumas ha in mente una piattaforma che lancia messaggi luminosi. Una sorta di semaforo, inventato nel 1792 da Claude Chappe, che il genio dello scrittore immagina come un lungo e dinoccolato coleottero «che lancia strani segnali che fendono l’aria con precisione e trasportano a trecento leghe di distanza la volontà sconosciuta di un uomo seduto a un tavolo a un altro uomo seduto a un altro tavolo all’estremità della linea (…) per la sola forza di volontà di quel capo onnipotente: allora credevo ai geni, alle silfidi, agli gnomi, insomma ai poteri occulti e ridevo».
Ma è innegabile che, al di là degli strumenti e dei supporti, lo scrittore francese coglie appieno l’essenza del telegramma, cioè l’istantaneità dello scrivere e del leggere a distanza. A riprova del successo di questo mezzo di comunicazione, forse non è un caso che, pochi decenni dopo, nelle pagine di Flatlandia il reverendo Abbott così s’immagina l’incontro con il re del Mondo: «Nella notte feci un sogno. Mi vidi davanti una vasta moltitudine di piccole linee Rette (…) mescolate ad altri Esseri ancora più piccoli e della natura di punti luminosi, che si muovevano tutti avanti e indietro lungo un’unica Linea Retta, e, per quanto potei giudicare, con la stessa velocità. A intervalli, mentre si muovevano, emettevano un suono confuso simile a un cinguettio o a un frinire molteplice, poi interrompevano ogni moto, e allora tutto era silenzio».
Eppure, nonostante abbiano incarnato promesse, richieste e conferme di un impegno, così come gioia (o mestizia) per un accadimento, o ancora il richiamo o il rispetto di un patto, i telegrammi, al contrario di più nobili parenti come le lettere, non hanno ottenuto la stessa nobiltà di genere. Né si può dire che per questo basti la telegrafica apertura dello Straniero di Albert Camus, «Oggi è morta mamma. O forse ieri. Non so. Ho ricevuto un telegramma dall’ospizio: “Madre deceduta. Funerali domani. Distinti saluti”. Non significa niente. Forse è stato ieri». Ai telegrammi sono riservati frammenti, citazioni, brevi scene nei romanzi e nel cinema, per lo più di genere, dal Dracula di Stoker, all’Agente segreto di Conrad, dal Mastino dei Baskerville, a Notorius. Ma il nostro pezzo di carta con i suoi punti e stop, le congiunzioni e disgiunzioni in latino, veloce e capitalista come un citizen Kane, subisce la sorte della sua essenza: perentorio nel messaggio quanto accessorio nella presenza. Non ci sono Vermeer che hanno immortalato intense scene di lettrici immerse nei loro telegrammi, né questi sembrano rivivere, come ci si aspetterebbe, nei giornali-collage di Braque, tra le spire delle velocità futuriste, negli interni di Hamilton o nelle collezioni di Joseph Cornell. Consegnato alla nostra memoria dalla voce con cui Enzo Jannacci ci ha fatto conoscere la poesia brasiliana di Cassiano Ricardo Leite, ci resta solo il povero Giovanni, telegrafista, chiuso tra le linee e i punti della sua sperduta stazione in attesa di un’Alba che non tornerà più: Píri-pirí-pirí-pirí-ppíppi. STOP.
I criteri per delimitare un genere ci sarebbero tutti. Eppure, questo non c’è. Meglio, non c’era. Se n’è fatto carico, e lo ha fatto da par suo, Stefano Bartezzaghi con un delizioso volumetto uscito per i tipi della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori: 365 Telegrammi. Al genere, il curatore-tassonomista ha aggiunto anche la specie, editoriale, e la differenza specifica: Mondadori.
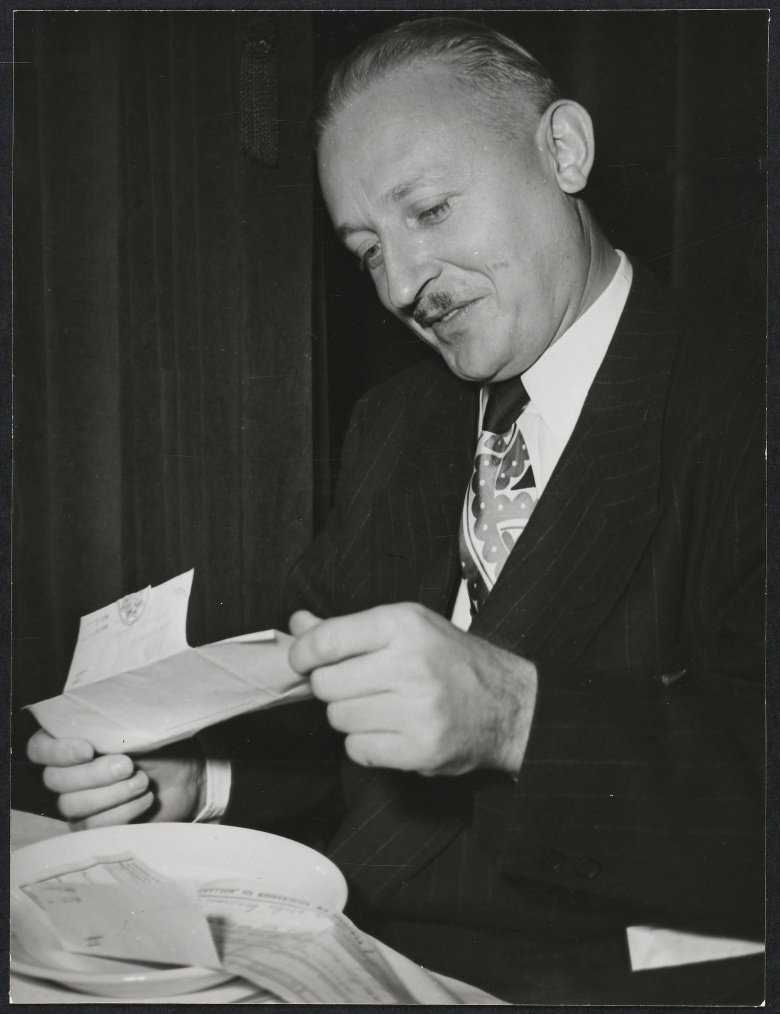
Seri ma non seriosi, Bartezzaghi e i curatori dei fondi Mondadori hanno prodotto una collezione di 365 piccoli testimoni di carta che sono a buon diritto parte della storia, non solo editoriale, e non solo italiana. Non si tratta di una semplice lista, ma di qualcosa di più: è una lista ordinata, un inventario, una collezione di oggetti che dice più della somma delle sue parti. Manco a dirlo, i criteri di assemblaggio sono il tempo e la puntualità: un telegramma per ogni giorno dell’anno, con cinquantadue (più una) riproduzioni fotografiche, anzi: 52 PLUS 1. STOP.
Lascio al lettore godersi, giorno dopo giorno, la lettura del suo telegramma quotidiano, sgranando un rosario di felicitazioni, richieste, promesse, ingiunzioni, illusioni e allusioni. Un vero e proprio paradiso di testi che rimandano a romanzi, racconti, traduzioni, premi letterari, raccolte di poesie, nascite, partenze, tradimenti e dipartite. Un racconto del qui e ora, di cui vale la pena di riportare qualche esempio. Ci sono i telegrammi di lusinga, in cui Arnoldo eccelle: «OGNI VOSTRO DESIDERIO È PER NOI UN ORDINE» (ad Annie Vivanti nel febbraio del 1926); quelli nei quali la lusinga dissimula, nel contempo, la mancata uscita di un libro: «AVETE FATTO OPERA D’ARTE PERFETTA E PROFONDAMENTE UMANI SONO I VOSTRI PROTAGONISTI STOP MI CONGRATULO TANTO TANTO CON VOI MIA ILLUSTRE AMICA E MI DOLGO SOLO DEL RITARDO CHE FORSE MI IMPEDIRÀ DI USCIRE IN QUESTA STAGIONE. STOP. SALUTI CORDIALISSIMI. MONDADORI» (sempre ad Annie Vivanti, il 25 aprile del 1927). Peraltro, Vivanti richiedeva pazienti lusinghe se, come si evince da un telegramma del 6 gennaio 1932, scriveva: «RICEVO PRIME COLONNE BOZZE DEPLORO VIVAMENTE SCELTA CARATTERE CHE SECONDO INTESA DOVEVA ACCORDARSI CON NAIA ANCHE IN PREVISIONE TRILOGIA STOP INOLTRE RIGHE MOLTO TROPPO LUNGHE FATICANO LETTORE CONFIDO RICOMPORRETE ATTENENDOVI MARGINATURA CARATTERI MIE OPERE SOPRATTUTTO MEACULPA MARJON RASSICURATEMI TELEGRAFICAMENTE SALUTI = VIVANTI». Una sottile sfumatura separa poi il lusingare dal blandire, e questo da un velato lamento non privo di un ricatto morale: «VI ABBIAMO OFFERTO CARA OSPITALITÀ CON TUTTO IL CUORE STOP SONO VERAMENTE DESOLATO CHE MIE PROMESSE NON RISPONDANO VOSTRE SPERANZE. AFFETTUOSAMENTE ARNOLDO MONDADORI». Meno lusinghieri e più rivelatori della mano del padrone, sono i dispacci ai colleghi editori e collaboratori, a partire dai blasonati francesi di Gallimard: «PER SIGNOR MASCOLO STOP STUPITI LETTERA SARTRE ANCHE AT VOI COMUNICATA ESPRIMIAMO NOSTRO RAMMARICO DICHIARANDOCI NON D’ACCORDO CON SUO CONTENUTO STOP CERTI CHIARIRE AMICHEVOLMENTE SITUAZIONE STOP SALUTI = MONDADORI». Sempre per Sartre: «PER DIABLE ET BON DIEU SARTRE PREGO TELEFONARE SE VOLETE PER STABILIRE CONTRATTO ALTRIMENTI GALLIMARD CEDE DETTA OPERA AT EINAUDI CHE EST PRONTO FIRMARE CONTRATTO = CORTESE» (Gianni Cortese ad Alberto Mondadori il 20 novembre 1952). E ancora: «DOPO DANNOSA PUBBLICAZIONE SU RADIOCORRIERE LEGGO ODIERNO TUO ARTICOLO VIAGGIO ITALIA CHE MOLTO DANNEGGIA PRESTIGIO EPOCA CHE NE AVEVA ESCLUSIVA DI STAMPA STOP NE SONO PROFONDAMENTE UMILIATO ARNOLDO MONDADORI». Immediata la risposta del destinatario, guido Piovene, con ovvio e italico addebito della colpa a terzi: «RIENTRANDO BENEVENTO TROVO TUO TELEGRAMMA RISPEDITOMI DA ROMA STOP PUBBLICAZIONI GIORNALE RAI AVVENGONO SENZA CHE IO NE SIA INFORMATO STOP IN QUANTO ARTICOLO STAMPA COME PUOI CREDERE AVREI IO VOLUTO FARE COSA LESIVA EPOCA ET MIO EDITORE? MIA INTENZIONE INVECE AUMENTAVA ATTESA LIBRO STOP SEGUE LETTERA MIO INDIRIZZO HOTEL EXCELSIOR NAPOLI STOP DESIDERO VEDERTI PRESTO. AUGURI AFFETTUOSI TE ET DONNA ANDREINA PER PASQUA ANCHE DA MIMY – PIOVENE». Già, le mogli: lari delle relazioni telegrafiche: «DOVENDO RESTITUIRLO IMMEDIATAMENTE PREGOTI DARCI MODO RINTRACCIARE MANOSCRITTO BANFI SALUTI MONDADORI» (20 ottobre 1927). «SCRITTO SUBITO MIA MOGLIE. CORDIALITÀ = BORGESE» (21 ottobre 1927).
Felicitazioni per accadimenti privati e pubblici successi editoriali (e per gli uni e gli altri assieme) toccano Sartre, Mann, Montale, o politici come Badoglio, De Gasperi, l’ambasciatrice Usa in Italia Claire Boothe Luce, Nehru, Togliatti e Berlinguer. Così, tra autori, editori e quelle intelligenze angeliche intermedie che furono i funzionari (da Sereni a Polillo) si snodano le opere e i giorni di questo bellissimo lunario editoriale, con un Arnoldo dallo stile più secco e un Alberto che cerca di dare sfumature poetiche a punti e linee: «RIENTRATO IERSERA DA FERRARA VIOLENTEMENTE STRAPAZZATO NELLO INTIMO PIÙ SEGRETO DELLA TUA IMPAREGGIABILE PITTURA […] PERCHÉ MI PRESE DELLA TUA OPERA PIACER SÌ FORTE CHE COME VEDI ANCOR NON M’ABBANDONA» (a Guttuso).
Pagina dopo pagina, si va alla chiusa dell’anno e, con questa, alle sentite condoglianze: prime fra tutte quelle per la scomparsa del «CAVALIERE DEL LAVORO ARNOLDO MONDADORI», firmate da Giovanni Agnelli, alle quali una precisa mano, che immaginiamo dedita ad altrettanto compianti giri di bozze, aggiunge a matita: «AVV.»