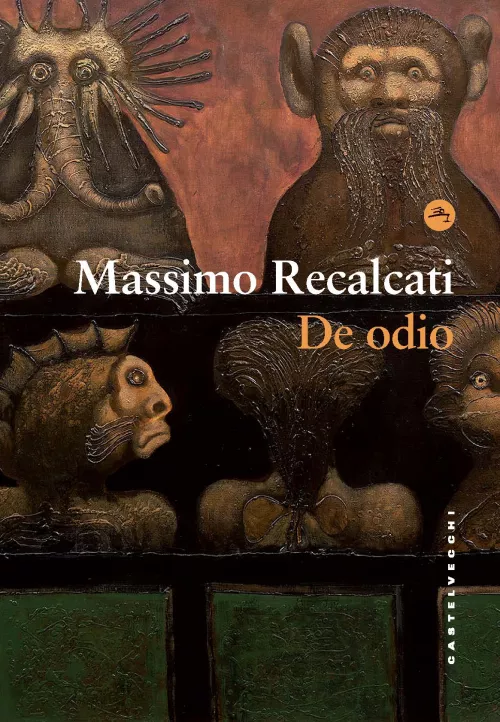L’odio: un errore logico?
Un luogo comune ci ha abituati a concepire le passioni come sommovimenti archetipici della vita umana, imperituri e immodificabili. Odio, invidia, collera, amore, gioia sarebbero passioni radicate a tal punto da essere strutturalmente immodificabili, quasi fossero l'altro nome che prende la natura quando si cerca di caratterizzare l'affettività umana. Ciò vorrebbe dire che qualsiasi siano le acquisizioni del pensiero, i percorsi del sapere, le avventure della verità, quelle passioni resterebbero ferme a segnare l'invariante della storia umana, indifferenti ai movimenti dell'intelligenza. Si tratta di un inganno. Siamo spinti a pensare così, perché il pensiero corre più veloce dei corpi e delle passioni e tale ritardo crea l'illusione che questi ultimi siano meno soggetti alla trasformazione. Più lenti equivarrebbe a dire fermi, immobili, senza storia.
In che senso, allora, diciamo che l'odio resta indietro, è in ritardo rispetto alle acquisizioni del sapere? In cosa consiste l'anacronismo che lo caratterizza? Potrà mai l'odio assumere forme che siano all'altezza dei tempi che viviamo? Che nome prenderebbe quella "passione dell'essere", come la definiva Lacan per distinguerla da quelle dell'anima, se potesse modellarsi sulla grammatica della cultura, sul ritmo del pensiero e della scienza? Occorre diventare onomaturghi, creatori di nomi, sfidare il principio di non contraddizione, proprio come ha fatto Lacan in più di una occasione. Il termine "odio" non va più bene, è l'espressione di un errore logico, pur stentando a morire. Sarà necessario torcere la lingua, piegarla, come se si volesse imitare quelle figure che non cambiano quando viene effettuata una deformazione senza strappi o incollature. E deformare una lingua secondo queste modalità significa sottrarla al destino paranoico. Come dire, il mondo contemporaneo avrebbe tutti gli strumenti logici e concettuali per liberarsi da una gestione paranoica dell'odio, e tali strumenti avrebbero la capacità di catturare nelle loro maglie la diffusa conflittualità. Tuttavia ci vuole del tempo: il tempo necessario affinché si creino le condizioni di una intercettazione. Perché di questo si tratta. La grammatica non è lì per disciplinare, ingabbiare, imporre forme, ma per intercettare, avendo essa stessa una natura pulsionale.
L'odio ha a che fare con lo spazio. Forse non ce ne stupiamo più, da quando abbiamo smesso di pensare lo psichismo all'insegna di una intimità inestesa, e ci siamo inoltrati nei suoi paesaggi, negli ambienti, nelle atmosfere che ne disegnano i contorni. Ma di quale spazio stiamo parlando quando vi associamo l'odio? La risposta a questa domanda è tutt'altro che semplice e immediata. Con molto azzardo, ma con una certa convinzione, potremmo avanzare l'ipotesi che lo spazio dell'odio sia uno spazio metrico che occulta la sua più generale matrice topologica.
Se c'è un antidoto all'odio, questo è proprio lo spazio topologico. È una frase sibillina, che richiederebbe molto tempo per sciogliersi, e che pure ci aiuta a capire qualcosa di questa passione triste, tanto drammaticamente attuale quanto idealmente anacronistica. Quanto più la vediamo scatenata intorno a noi, nelle infinite forme che prende nella storia contemporanea fin dentro le pieghe più riposte del tessuto sociale, quanto più la percepiamo in ritardo rispetto alle nuove grammatiche che ci pare di afferrare col pensiero. È come se l'odio, l'iracondia, l'invidia – quelle che Spinoza chiamava "passioni tristi" – fossero anche passioni rassicuranti perché adagiate su abiti mentali consolidati e al riparo dalle vertigini spaesanti delle avanguardie del pensiero. In fondo l'odio è quella passione che assicura una casa al soggetto, lo localizza da una parte della barricata, e colloca al di là della soglia il nemico. Si tratta di un meccanismo che la psicoanalisi descrive bene attraverso il concetto di proiezione. Un dispositivo di difesa inconscio attraverso il quale il soggetto, per ridurre la conflittualità interna e il senso di angoscia che ne deriva, tende ad attribuire ad altri i propri pensieri, le proprie emozioni o i propri impulsi inaccettabili. Lo aveva visto molto bene Freud, quando si era accorto della natura bivalente dell'odio in tutte le sue sfumature. Il fatto è che – si tratta della grande intuizione lacaniana – non basta sottolineare l'ambivalenza dell'odio, il suo oscillare tra distruzione e amore, tra interno ed esterno, tra annientamento del soggetto e occasione della sua apparizione, per essere all'altezza della nuova grammatica del pensiero. Occorrerebbe semmai sollevare l'odio all'altezza di un pensiero topologico. Un pensiero che cerca di articolare matematicamente il "non senza" di cui ci parla Lacan. Qui non c'è un odio che poi si rivela amore e viceversa, ma un odio non-senza amore, dove quel "non senza" che non coincide con il "con", chiama in causa uno spasmo tutto trattenuto sul posto.
Il pensiero contemporaneo, in quasi tutte le sue declinazioni, ci consiglia di collocare il soggetto in una posizione interstiziale, come fosse una sorta di commutatore che, in quanto tale, abita solo luoghi di transizione. Il soggetto si coglie laddove un taglio lo converte in oggetto, così come la vita la si coglie nello spasmo topologico che la fa battere come morte e l'odio nello spasmo che lo fa insistere sul posto come amore. E viceversa naturalmente. Il pensiero ha imparato a guardare in filigrana la rigidità delle localizzazioni, dei dualismi, delle contraddizioni per scorgere lo sfondo che fa di essi un caso particolare di uno spazio assai più metamorfico. Una volta colto con la forza dell'intuizione, ma anche del calcolo, un paradigma spaziale in cui continuità e discontinuità, interno ed esterno non sono in contraddizione, ma appaiono compossibili, allora un'idea solo metrica di distanza e vicinanza apparirà riduttiva o incompleta. Così come, per certi versi, diventa anacronistico lo spazio metrico quando se ne intravede in filigrana lo spazio topologico. Ecco allora che l'odio si presenta come una sorta di rigurgito inerziale che ci inchioda a un passato non più attuale. Un errore logico, si diceva. Una volta che abbiamo intuito qualcosa dello spazio topologico, lo spazio metrico perderà ogni rigidità. Che cos’è allora uno spazio topologico? Si tratta di uno spazio non rigido, non definito dai parametri metrici della distanza, della direzione o dell'angolo, perché tali parametri sono solo un caso particolare dello spazio topologico. Se per calcolare la vicinanza tra due punti mi baso sulla loro distanza metrica, sto applicando un concetto particolare di vicinanza che non esaurisce il campo della vicinanza topologica. Potremmo così dire, l'odio è metrico, mentre la matematica, la filosofia, la psicoanalisi ci familiarizzano con gli spazi topologici, in cui il distante può essere vicino, l'esterno può essere l'interno, l'estraneo l'intimo. L'odio non è una passione all'altezza di questa nuova grammatica, è in ritardo, è una passione pigra oltre che triste, abitudinaria che è rimasta agganciata a un'altra logica e ora stenta a liberarsene. Non è del resto una novità che il pensiero corra più veloce dei corpi e degli affetti. I corpi e gli affetti hanno difficoltà a sganciarsi dalle vecchie logiche per accedere alle nuove e quando a questo ritardo si aggiunge una svalutazione politica, programmatica e populista delle nuove frontiere dell'intelligenza e del sapere, queste appariranno via via più lontane dalla gestione ordinaria della vita, scavando una pericolosissima fenditura tra pensiero e realtà.
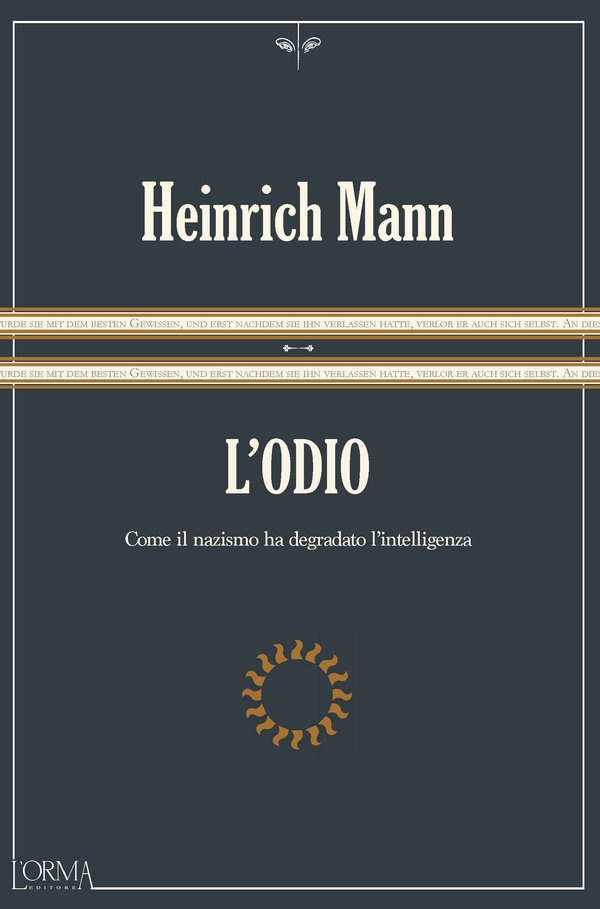
È stata la grande intuizione di Heinrich Mann (fratello maggiore di Thomas), scrittore, saggista e polemista tedesco, divenuto, dopo un esordio incerto, strenuo oppositore del regime nazista e autore nel 1933 di un saggio insieme diagnostico e profetico, dal titolo L'odio. Come il nazismo ha degradato l’intelligenza, ora disponibile in una traduzione italiana integrale grazie a Eusebio Trabucchi e all'Editore L'Orma. "Previdi in anticipo quel che sarebbe accaduto in Germania: me lo fecero pagare come se l'avessi causato io". Così commentò, anni dopo, la fortuna che ebbe questo suo libro. Veniamo al punto. Cosa ha permesso al nazismo di impadronirsi del potere? Heinrich Mann avanza la sua proposta fin dalla prima pagina: è accaduto che "l'armonia classica tra realtà e pensiero è diventata sempre più difficile da ottenere". E quando il pensiero perde terreno, perché osteggiato, deriso, allontanato dal tessuto sociale, la realtà diventa amara e foriera di intolleranza. Racine, ci ricorda Mann, sentiva, viveva e scriveva in armonia col suo tempo, condivideva i fondamenti etici e intellettuali del regno di Luigi XIV. Goethe non percepiva il sistema di potere vigente nella "meravigliosa cultura popolare della Germania" in contrasto con la propria vena creativa. Una volta compromessa la solidarietà tra cultura e società, già a partire dal 1871, il cammino della storia si è avviato verso la dittatura. “La dittatura – scrive Mann – è quella particolare condizione delle strutture sociali in cui pensiero e realtà non sanno più nulla l'uno dell'altra. Nel caso tedesco si è raggiunto addirittura il punto in cui l'uno esclude l'altra. A chi appartiene il futuro, chi lo plasmerà? Sarà appannaggio di un potere che finge di richiamarsi a idee ormai obsolete ma in realtà cerca solo di conservare se stesso? O spetterà a chi desidera vivere e conoscere? Finora questi ultimi hanno tentennato. Il potere li teme e per questo si radicalizza sempre più. In ultima istanza, chi difende la conoscenza dovrà cominciare a fare sul serio. Soltanto di rado si è potuto osservare un diverso corso degli eventi" (p. 12). Heinrich Mann sembra qui un nostro contemporaneo, le sue parole si adattano perfettamente ai nostri tempi, soprattutto quando nota, proseguendo, che questa disarmonia tra realtà e pensiero si è manifestata come una costante preparazione alla guerra, all'inizio come necessità di armamento e poi come appello sempre più urgente al riarmo (sic), in una cospirazione tra lo Stato e i grandi conglomerati industriali.
Tornando allora al nostro tempo, così sorprendentemente simile a quello descritto da Mann (1871-1933), possiamo ripetere che il proliferare dell'odio nella sua anacronistica declinazione sia il sintomo di una perdita di aderenza della cultura, del pensiero, del cammino della verità. Se si recuperasse un po' di questa aderenza, allora la parola "odio" dovrebbe quantomeno lasciare il posto a un neologismo topologico: quello suggerito da Lacan, nel Seminario, Libro XX, Encore, quando ci invita a usare il termine enantiosemico hainamoration (odioinnamoramento) da opporre al concetto freudiano di ambivalenza: non si tratta infatti di alludere a una oscillazione da un sentimento all'altro, ma di pensare l'uno non senza l'altro. La psicoanalisi, la filosofia, la matematica, la fisica ci spingono a valorizzare in chiave topologica l'enantiosemia. Se questo fenomeno linguistico che ha insospettito e tormentato i linguisti, fosse la chiave di volta per emanciparci da quell'errore logico che alimenta l'odio? Bisognerebbe percorrere una breve storia che va dal filologo tedesco, Karl Abel, autore nel 1844 di un libretto dal titolo Über den Gegensinn der Urworte (Sul significato opposto delle parole primordiali), a Freud (1909) autore di una sintetica e partecipata recensione a quel libretto, a Lacan che utilizza i suoi neologismi per adattare la lingua, forzandola e stiracchiandola, all'intuizione topologica, a Derrida che in La doppia seduta (1970) torna sull'enantiosemia, sottolineandone la natura sintattica più che etimologica. Non è, in fondo, un fenomeno di enatiosemia pensare simultaneamente l'odio e l'amore, la continuità e la discontinuità, la vita e la morte? È tale contemporaneità che va indagata, questa simultaneità spasmodica, questa pulsazione sur place, se vogliamo cogliere qualcosa di quella “relazione senza-rapporto” che a un certo punto si è insinuata nel dibattito filosofico ed epistemologico non solo francese.
È sulla delicatezza di questo snodo che si soffermano Recalcati in uno dei suoi testi più intensi, De odio, ora disponibile in una nuova edizione rivista, grazie all'Editore Castelvecchi, e un numero monografico della Rivista "Frontiere della psicoanalisi" (2-2024) interamente dedicato alla Passione dell'odio. Si tratta di dire bene quella bivalenza che anima e sostiene l'odio. E "per dirla bene" forse non basta parlare di interna contraddittorietà, di ambivalenza, alla maniera di Freud. È necessario spingersi più avanti, in un luogo del pensiero di cui Freud non poteva ancora padroneggiare gli esiti, pur preconizzandoli, e che Lacan ha provato con tutte le sue forze ad aprire. Un luogo del pensiero in cui, come scrive Recalcati, "viene a mancare l'efficacia del dispositivo paranoico che trasferisce verso l'esterno il nemico localizzandolo, perché come in un tragico nastro di Möbius, non c'è più differenza in realtà, nell'epoca della globalizzazione, tra l'interno e l'esterno, tra il locale e il mondiale, tra il proprio e l'improprio"(De odio, p. 106). Si apre la domanda su cosa sia uno spazio senza localizzazioni. Difficile intuirne la configurazione se non attraverso quelle forme complesse che la topologia ha sottoposto alla nostra attenzione. In questa ambientazione matematica, davvero mi pare non ci sia più spazio per l'odio, preso allo stato puro, solido. E sarebbe uno sfratto auspicabile. Esso dovrebbe ripiegare in minacciosi ambienti lontani dal pensiero, anacronistici, conservatori. Come di fatto oggi, malauguratamente accade.
Quanto stiamo dicendo presuppone di aver mosso un primo passo tutt'altro che scontato, quello che ci porta a riconoscere l'esistenza di una grammatica degli affetti e delle passioni. Il pathos non si inabissa in oscurità irrazionali ma ha una sua grammatica, così come ogni grammatica ha una radice pulsionale. E che si tratti di una grammatica topologica ci viene suggerito dal fatto che nella pulsione il soggetto umano non distingue tra soddisfazione e insoddisfazione.
La natura grammaticale del pathos ci consente di mettere in discussione parzialmente l'assunto che l'economia pulsionale non sia modificabile attraverso il pensiero, l'inferenza, il discorso, il ragionamento. È vero. Non si convince una persona affetta da anoressia ad abbandonare il suo sintomo ragionando con lei sulla pericolosità delle sue condotte alimentari. Ciò accade non a causa di una presunta, strutturale indifferenza del pensiero alle condotte libidiche, ma perché ci vuole del tempo affinché una nuova grammatica agganci gli affetti avvinghiati come mitili a logiche obsolete. Nel numero monografico che "Frontiere della psicoanalisi" dedica all'odio, Luca Bagetto coglie molto bene le pericolose derive di una gestione paranoica della conflittualità, basata sulle justae causae, anziché sullo justus hostis. Nelle attuali letture giuridico-politiche della conflittualità, l'intera sfera pubblica "si trasforma in una comunità ansiosa di individuare i colpevoli delle imperfezioni del mondo, e di sottoporli a rituali di pubblico disonore. Trionfa allora l'essenza del moralismo, che consiste nella ricerca ossessiva di qualche colpevole al cospetto di qualunque fenomeno, anche al cospetto di quei fenomeni che non prevedono colpevoli perché non prevedono una sola causa bensì molte e nessuna" (p. 388). Familiarizzare con gli spazi topologici che hanno, prima fra tutte, la caratteristica di non prevedere rigide localizzazioni potrebbe essere di aiuto nel tentativo di riagganciare lo justus hostis, vale a dire quel nemico che, non essendo più solo il difensore di una causa ingiusta, non è un criminale o un nemico assoluto da sterminare.
Troppa fiducia nel pensiero, nella grammatica, nel calcolo, nella logica, nella scienza? Non credo, soprattutto se portiamo in luce la natura ritmica, nonché la prossimità distale del pensiero con la pulsione. Una grammatica è lì, non per condurre lontano dal mondo della vita, ma per agganciarla grazie all'omologia ritmica che la tiene legata al "vai e vieni" pulsionale.