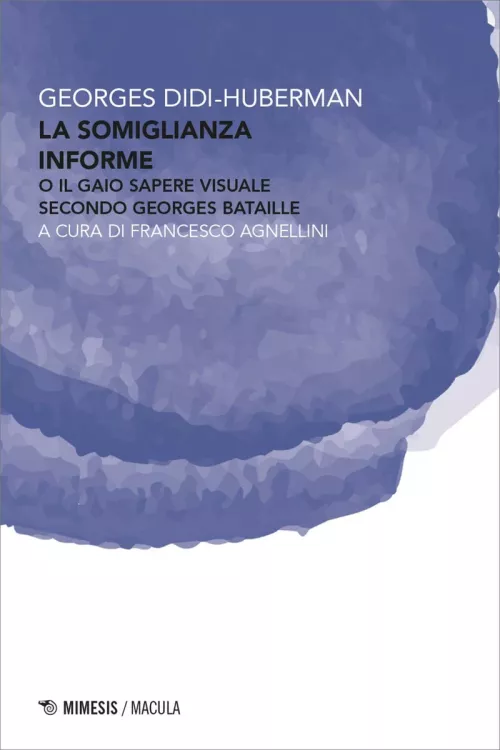Georges Didi-Huberman e la somiglianza sovversiva
Eleggiamo una forma, un’immagine. Ad esempio quella dell’occhio. Portiamola in primo piano, isoliamola dal contesto. Proprio come faceva Bacon quando cerchiava le sue figure o le evidenziava inondandole di un fascio di luce, o come faceva Jacques-André Boiffard quando con la perizia anatomica propria del medico, quale era, fotografava l’alluce femminile conferendole la dignità di un volto in primo piano. Osserviamo il nostro occhio con attenzione, affezionandoci ad esso quel che basta, rivolgiamogli uno sguardo puerile, meticoloso e gaio. Ebbene, cosa stiamo facendo? Stiamo, in poche parole, regalando spazio e tempo all’immagine dell’occhio. Mentre le rivolgiamo un’attenzione intensiva, le concediamo aria. La facciamo respirare in un tempo e in uno spazio dilatati.
Le accordiamo un tempo, cioè un movimento, e uno spazio, cioè una lacuna, un vuoto, un bianco. Un tempo e uno spazio non imbrigliati. Un tempo e uno spazio ribaldi, non intesi cioè come condizioni trascendentali della sensibilità, bensì essi stessi come processi morfogenetici sempre diversi. In una sorta di creatività replicante, quell’occhio si ripresenterà in tutt’altre fattezze. Basta dargli tempo e spazio, appunto. Tornerà come uovo, ad esempio. Avrà quasi la stessa sorte della duplice natura corpuscolare e ondulatoria della materia, la quale si presenta a volte come onda, altre volte come particella. Un occhio di vitello, forse. Del resto il bianco dell’uovo non è il bianco dell’occhio? E la forma dell’uovo non somiglia a quella dell’occhio? C’è qualcosa di simile tra di loro. Ma questa somiglianza, deformandosi, si apre alla dissomiglianza più radicale, alla spontanea creazione di un’alterità assoluta.
Il simile si presenta come dissimile. È il contatto incessante della somiglianza che genera la sua smentita. O altrimenti detto, più ci si lascia toccare, contagiare, sedurre dalla vita, più la vita è troppa, è in eccesso, più essa si presenterà come eterogenesi, mai come il medesimo. Più la vita è somigliante, pensiamo alla gemellarità, più essa si espone alla possibilità di uno schiacciamento deformante, come nel caso dei gemelli siamesi. È all’opera una decisione oscura che “sposta le somiglianze nel registro “agitato” dell’informe, che deve dunque essere inteso, letteralmente come una dépense di forme” (p. 228). Più il vivente è se stesso più “tornerà come altro”. Una frase quest’ultima che vale una vita di pensiero, come quella che le ha dedicato Georges Bataille e, in un pedinamento risonante, Georges Didi-Huberman nel suo capolavoro La somiglianza informe o il gaio sapere visuale secondo Georges Bataille, pubblicato quasi trent’anni fa, nel 1995 e ora finalmente tradotto in italiano da Francesco Agnellini per Mimesis. Un testo sorprendente per quel carattere di generosità, voracità ed esuberanza euristica che condivide con lo stile dell’autore di cui si occupa. Dunque due esuberanze, quella di Bataille prima e di Didi-Huberman dopo, che si sommano in un laboratorio inesauribile, senza fondo.
In quale ambientazione ci troviamo? Qual è il paesaggio che favorisce l’emergere di questa somiglianza sovversiva? Quello del bosco e della notte di shakespeariana memoria. Un paesaggio regressivo, misterioso e insidioso, popolato di fate, di figure umane con la testa di asino (l’artigiano Bottom in Il sogno di una notte di mezza estate), di immagini alterate. Quel paesaggio di cui parla Freud nel famoso settimo capitolo dell’Interpretazione dei sogni, quando descrive il carattere figurale dell’attività onirica, in cui la forma astratta e incolore del pensiero lascia il posto alle forme plastiche e concrete delle immagini. È a livello del sensibile, del materico, dell’estetico, potremmo dire, che la vita mostra la sua somiglianza sovversiva. Questo accade con evidenza nel sogno, ma anche nella formazione del sintomo, o in fenomeni che compaiono in uno stato di salute, come nel caso del fantasma.
In tutte queste situazioni, è all’opera un processo regressivo attraverso il quale, dice Freud, la rappresentazione si trasforma nell’immagine sensoriale da cui è sorta. È come se, in questi casi, la struttura dei pensieri venisse disgregata nella sua materia prima. Quando ci abbassiamo al livello della pura materia (il basso materialismo di cui parla Bataille), questa non si presenta come un elemento stabile o come principio esplicativo di una permanenza, come accade nelle soluzioni essenzialiste. Essa rivela piuttosto un movimento canaglia imprevedibile, instabile, eterogenetico. Si tratta, scrive Didi-Huberman con una formula potentissima, di “una materia bassa, non materia base: una materia in cui il sapere precipita, non materia in cui il sapere trova il suo fondamento” (p. 316). Quando ci abbassiamo al livello della pura materia sensoriale, incontriamo non un fondamento, non la stabilità, ma il delirio della materia.
Quel delirio che trasforma l’occhio in un uovo. Quando sentiamo la vita a partire dalla carne, non c’è tregua ai processi di alterazione, nulla ci appaga nella quiete del medesimo. Siamo dentro a un gioco lugubre in cui ci spaventiamo giocando con il peggio, dove la dislocazione delle forme trascina quella del pensiero in una sorta di agitazione proteiforme. Qui le immagini si ammalano e si aprono a una volontà di chance, producendo, quasi nauseabonde, una vertigine incontrollabile.
Come nominiamo questo passaggio da occhio a uovo? Come descriviamo quanto è accaduto in quel transito, in quel “ritorno come altro”? Abbiamo a disposizione tante parole che ci provengono dalla tradizione. Non tutte però, malgrado l’apparenza, risultano pertinenti o capaci di afferrare quel processo che Bataille e Didi-Huberman stanno inseguendo, tenendosi per mano. La prima che ci viene incontro è “metamorfosi”. Parola dalla lunga e suggestiva storia, a cui Bataille, insieme a Leiris e Griaule dedica una voce nel Dizionario critico di “Documents”, la rivista “aggressivamente realistica” (così la definisce Denis Hollier) che esce in due anni decisivi per Bataille (1929-1930). Siamo nel 1929, la voce Metamorfosi compare dopo l’articolo Mattatoio, entrando in risonanza con quest’ultimo.

Tra le mani di Bataille, il concetto di metamorfosi che nella tradizione indica una trasformazione di forma che mantiene intatta una identità sottostante, presenta invece il volto radicale di una generazione materiale di forme antitetiche, in cui la somiglianza è, nello stesso tempo, sovrana e lacerata, aderente e interrotta. Si tratta di un paradosso che sostiene l’intero percorso dei due autori, difficile da sciogliere, ma quanto mai fertile e operativo. Immaginiamo di fissare ossessivamente l’immagine di un uomo. Questa reiterata messa a fuoco produce, ad un certo punto, una deformazione, quella che in psicopatologia chiamiamo derealizzazione o depersonalizzazione, per cui, in modo sintomatico, la figura umana, investita da una morte provvisoria, diviene davvero capace di ululare come un cane.
Il termine “metamorfosi” è, tuttavia, per Bataille troppo concettuale. Per vedere e sentire all’opera questa generazione spontanea dell’informe a partire dalla forma, bisogna abbassarsi al livello della materia pulsionale e sessualizzata. È nella vita in atto che si sente l’eterogenesi. Qui il paradosso guadagna la luminosità dell’esperienza. E, allora, la metamorfosi si presenta come un va e vieni erotico. La pulsazione della pulsione. Proviamo a sentire immersivamente la vita e questa, ad un certo punto, si presenterà come morte. Appoggiamo una maschera al volto, questa si schiaccia sulla pelle fremente del corpo, aderisce all’organico, ma nello stesso tempo – è la contemporaneità che ci interessa – pietrifica, cristallizza, immortala nell’inorganico. La maschera è al contempo ciò che entrando a stretto contatto con la vita ne subisce la seduzione, aderendo alle fattezze organiche, e ciò che fa sentire il respiro della morte. Alla vita è accaduto qualcosa di decisivo (in quanto già da sempre accaduto) e al contempo nebuloso e abissale al punto da divenire indecifrabile con gli strumenti della logica classica: la vita si è gonfiata di morte o, per scippare Nietzsche delle sue parole, è divenuta/è una “specie ben rara della morte”. Lo aveva capito molto bene Derrida.
Balza subito all’occhio, producendo un effetto perturbante, la natura paradossale di questa formulazione. Che la vita si gonfi della morte vuol dire, innanzitutto, che la morte non le si contrappone dualisticamente, ma anche che la morte non è propriamente il medesimo della vita. Per guadagnare almeno il sentore di questa “altra logica”, occorre affidarsi a un pensiero ventriloquo che, mentre dice qualcosa, fa sentire un silenzio, un’alterazione muta di ciò che viene pensando, che mentre da un lato parla, prova piacere e vive, dall’altro tace, si dispiace e muore. La parola che meglio dice questo sobbalzo lacerante della vita è ripercussione. Un colpo sul posto nell’immagine produce un sobbalzo nello spettatore. Ecco il valore percussivo delle forme visibili. Il contraccolpo di cui, ad esempio, parlava Giacometti, o l’urto tra i piani nel montaggio di Ejzenštejn.
Se dunque l’informe non è il totalmente altro dalla forma, ma una sorta di “insubordinazione materiale” che inizia all’interno della forma come un suo battito latente, se non occorre contrapporre sputi e ragni schiacciati a terra alla bella Forma della figura umana, perché è all’interno di quest’ultima che comincia il suo declassamento, la sua deformazione, se, dunque il disparato non è il contrario, ma ciò che mantiene un legame con la forma di partenza, è lecito, secondo Didi-Huberman, parlare di dialettica, come del resto fa Bataille stesso. “Spesso Hegel mi sembra l’evidenza, ma l’evidenza è difficile da sopportare”, scrive Bataille. L’evidenza di un pensiero non dualistico, di un pensiero che fa sentire l’alterazione all’interno della figura di partenza, e non in alternativa ad essa. Eppure si tratta di una dialettica, quella di Bataille, piegata ad un uso sintomale e non sintetico.
Nel sintomo non c’è storia, non c’è progressione, come, del resto nel fantasma. Al contrario dello Hegel commentato da Kojève, secondo il quale l’essere umano afferma la propria umanità solo negandosi come animale, mettendo in primo piano il lavoro del negativo, in Bataille c’è piuttosto regressione a quel gaio sapere infantile (gioco vs lavoro) che mantiene presente, contemporaneamente, tutti i momenti del processo. Il sintomo è un grumo bio-psichico che fa coesistere in un magma lacerato e lacerante tutte le sue componenti: disiecta membra tenute insieme da un diabolico legame. Lo stesso accade al fantasma che, per Freud, è sovraderminato e soprattutto reversibile. “Un bambino viene picchiato” è il fantasma sado-masochista che si presenta come una formula iperdensa nella quale attività e passività si incrociano chiasmaticamente: si può seguire l’azione di chi picchia e contemporaneamente la passione dell’essere picchiato.
Questa compresenza, questa compossibilità, persino di ciò che nella logica classica appariva come una contraddizione, apre alla modernità. Bataille si dimena pericolosamente sulla soglia del mondo contemporaneo, sentendone la potenza ancora impensata e Didi-Huberman ne raccoglie coraggiosamente e creativamente l’eredità.