50 anni di Horcynus Orca
Il 25 febbraio del 1975, dopo un lavoro quasi ventennale, Stefano D’Arrigo riusciva finalmente a pubblicare Horcynus Orca, romanzo che Mondadori aveva a lungo atteso e finanziato, con la certezza che si sarebbe rivelato un capolavoro della letteratura italiana. Il 2025 è dunque l’anno del cinquantenario della pubblicazione dell’opera, cui sono state e saranno ancora dedicate diverse iniziative nel corso dei prossimi mesi. Ma soprattutto il 2025 vede anche una nuova edizione del romanzo, che soddisfa le aspettative degli ancor troppo rari studiosi darrighiani.
La nuova edizione per Rizzoli è impreziosita da alcune chicche per il lettore: un saggio di Giorgio Vasta, l’introduzione dell’immancabile Walter Pedullà, storico amico e studioso di D’Arrigo, di cui in questa sede si vuole anche celebrare il ricordo, e una postfazione di Siriana Sgavicchia. Ma soprattutto succose sono le fotografie e i documenti inediti curati dalla stessa Siriana Sgavicchia e aggiunti in appendice a questa nuova edizione. Si tratta in particolare di materiale documentario finora inedito conservato presso l’Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti del Gabinetto Vieusseux e soprattutto di una interessantissima nota autobiografica, anch’essa finora inedita, inviata da D’Arrigo a Vittorini in occasione della pubblicazione di I giorni della fera per «Il Menabò» nel 1960. La nota firmata da D’Arrigo consente di far un po’ di luce su di una biografia di cui tuttora si sa veramente poco.
Prima di raccontare la complicata e intrigante vicenda editoriale del romanzo, è bene rispolverarne brevemente la trama. Horcynus Orca racconta le vicende di Andrea Cambrìa (nel testo ’Ndrja), reduce della Seconda guerra mondiale che torna a Cariddi, paesino fittizio nella provincia di Messina, a seguito del proclama Badoglio dell’8 settembre del 1943. L’opera è divisa in tre parti, senza alcuna suddivisione in capitoli. Nella prima parte il lettore segue il viaggio di ritorno del protagonista, che nel romanzo inizia dalle coste calabresi, ma che si scopre poi avere avuto origine a Napoli, dove il reduce si trovava al momento della ritirata delle truppe tedesche. Celebre a proposito l’episodio del tedesco ucciso dagli scugnizzi napoletani, che fu inserito da Primo Levi in La ricerca delle Radici.
Nella prima sezione del romanzo, in cui è già forte il richiamo dell’epica, il lettore è trasportato in un mondo completamente stravolto dal conflitto bellico. Il protagonista, tallonato da un piccolo gruppo di soldati in cerca di “passaggio di mare”, diventa un nuovo Mosè che deve ricondurre il proprio popolo verso la sua terra promessa. La figura biblica si intreccia quindi con quella dell’Ulisse omerico e joyciano, e infine con quella del Dante personaggio.
’Ndrja Cambrìa riesce a procurarsi il suo passaggio di mare grazie all’aiuto di Ciccina Circé, straordinario personaggio femminile di una donna calabrese dedita alla pratica del contrabbando. Ciccina Circé diventa quindi la Caronte del reduce siciliano e lo trasporta dall’altra parte dello stretto, dove riscuote con un amplesso il favore a lui accordato. La prima delle tre sezioni del romanzo è un susseguirsi di indizi funesti che parlano di uno “straviamento”, di una degradazione che ha colpito tutta l’isola, simboleggiata dalla figura di uno spiaggiatore, un vecchio pescatore ormai ridottosi al consumo della carne di “fera”, cioè l’immangiabile carne del delfino, eterno nemico dei pescatori.
La seconda parte del romanzo si apre invece con l’arrivo di ’Ndrja al paesino di Cariddi, dove il protagonista osserva con i propri occhi la degradazione del padre, pescatore anch’egli ridotto al consumo della carne di fera. Il reduce viene sottoposto a un lungo processo di agnizione da parte del padre Caitanello, ed è costretto ad ascoltare una lunga serie di racconti, come espiazione per essere andato in guerra e requisito necessario per essere riammesso nella comunità. Il protagonista viene quindi informato dal padre degli avvenimenti accaduti e dello stato di cose a Cariddi, del quale ’Ndrja aveva già avuto contezza: non ci sono barche, i pesci spada sono scomparsi e il mare è pieno zeppo di fere, corpi e residui della guerra.
La terza sezione del romanzo si apre invece con l’apparizione dell’orca e con l’arrivo di truppe americane e inglesi. ‘Ndrja, che viene inviato a Messina dal boss dei pescatori per informarsi sulla presenza di barche, viene invitato da un maltese a partecipare a una regata contro gli inglesi in cambio di mille lire. Il protagonista, tornato a Cariddi, assiste allo “straniamento” dei “pellisquadre” (così vengono chiamati i pescatori), che rimangono sbalorditi dalla presenza dell’animalone nelle acque dello stretto. Ha inizio il cosiddetto monologo dello sperone, quando il protagonista si rende conto che i pescatori non sono interessati ad avere nuovamente una barca per tornare al loro “onesto mestieruzzo”, ma soltanto a richiedere l’arenamento dell’orca, morta dopo lo scodamento ad opera delle fere e ora in balia delle onde. Il monologo dello sperone si chiude quindi con una parola di nuovo conio “orcarca”, cioè l’orca come apparente strumento di salvezza per i pescatori, che in realtà li conduce alla degradazione definitiva. Accettando di partecipare alla regata, il protagonista saluta i suoi compagni che lavorano come anime dannate alla carcassa dell’orca e muore misteriosamente poco dopo, colpito in fronte da una pallottola durante un allenamento per la regata.
Riassunta brevemente la trama, altrettanto lunga e complessa è la vicenda editoriale dell’opera, a cui D’Arrigo comincia a lavorare già nel 1956, quando il romanzo non era ancora il romanzo dell’orca, ma del suo parente più piccolo, la fera, da cui prendeva il nome. D’Arrigo si dedica quindi al romanzo prima ancora del suo esordio poetico, che avviene soltanto nel 1957, con la pubblicazione di Codice Siciliano per Scheiwiller. Anche in questo caso D’Arrigo vi lavorava ormai da tempo. Pur contenendo già la vicenda di Andrea Cambrìa, la prima bozza del romanzo si presenta molto distante dalla sua versione definitiva. Diverso è l’intreccio della storia, così come diversa è la lingua, ancora lontana dall’originalità e dalla potenza espressiva del 1975.
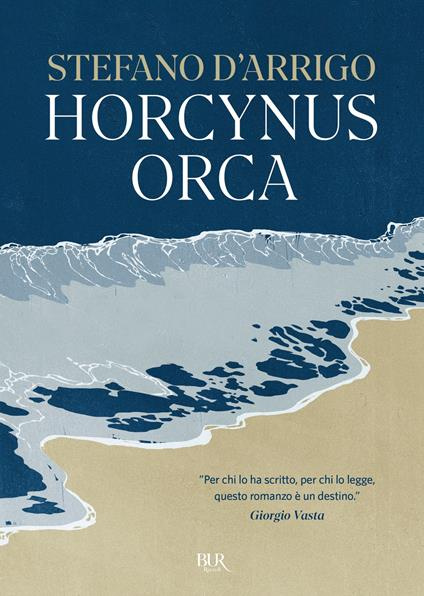
A questa prima stesura manoscritta fanno seguito altre stesure, fino a quando nel 1959 D’Arrigo fa leggere il romanzo all’amico Renato Guttuso, il quale a sua volta ne parla con Elio Vittorini, che si presenta da D’Arrigo “bagnato come un pulcino, alto e allampanato”, per convincerlo a pubblicare i capitoli sul Menabò. D’Arrigo accetta, con il patto che avrebbe potuto prima revisionarli, per poi scoprire che sarebbero stati pubblicati nel numero 3 della rivista «Il Menabò» senza le sue correzioni e per di più con l’aggiunta di un glossario che mandò su tutte le furie l’autore. L’aggiunta del glossario non solo avrebbe ingabbiato la sua opera nella querelle italiano-dialetto (motivo per cui D’Arrigo non contemplò neanche l’idea di pubblicare il romanzo completo sulla rivista), ma avrebbe tagliato le ali a un lettore che ha bisogno di apprendere da solo a piccoli passi la lingua del romanzo, prima di poter lasciarvisi trasportare.
Prima ancora che il libro esca per «Il Menabò», l’autore ha già l’imbarazzo della scelta tra gli editori. Tra Einaudi, Garzanti e Feltrinelli, lo scrittore sceglie però Mondadori. E mai scelta fu più azzeccata, potremmo dire. Arnoldo Mondadori è letteralmente innamorato del romanzo di D’Arrigo ed è convinto che si rivelerà un capolavoro assoluto della letteratura italiana. Tutto ciò si traduce in un sostegno morale ed economico senza precedenti, dal quale traspare anche una grande sensibilità dell’editore nei confronti dello scrittore, nonostante la lunga e fremente attesa.
Alla prima stesura fa seguito, tra il marzo e l’ottobre del 1961, I fatti della fera, che conta circa la metà delle 1257 pagine della versione definitiva di Horcynus Orca. Da questo momento in poi la scrittura del romanzo ricorda il movimento passivo dell’orca che rimane bloccata nelle acque dello stretto e sembra ormai essere in balia delle onde. Anche D’Arrigo non riesce ad uscire dalle pagine del suo romanzo ed è bloccato nelle acque di una lingua dalla quale non sembra trovare una via di uscita. Il suo però è un movimento tutt’altro che passivo, è un immenso lavoro di ricerca, linguistica e non solo, che non sembra mai avere fine.
Tra il 1967 e il 1968 la situazione si fa sempre più delicata: Mondadori ha già venduto i diritti per le traduzioni dell’opera, ma D’Arrigo non gode di buone condizioni di salute e la scrittura del suo romanzo non sembra andare avanti. Tuttavia, è proprio in quel periodo che D’Arrigo concepisce il cosiddetto ‘monologo dello sperone’, vale a dire l’episodio che marca la distanza tra I fatti della fera e la stesura finale di Horcynus Orca. In una lettera a Vittorio Sereni del 5 ottobre del 1969 Niccolò Gallo parla di “pagine tormentate del D’Arrigo”, che definisce però “impressionanti”. Si tratta di pagine decisive per la narrazione del romanzo, che subisce infatti da lì in poi una netta accelerazione, accelerazione che non si accompagna invece all’attività di revisione, che terminerà soltanto il 24 ottobre 1974, quando D’Arrigo licenzia finalmente le bozze.
Nonostante il clima di attesa e le aspettative, anche grazie a una campagna pubblicitaria impressionante dal costo di 25 milioni di lire, l’opera non ottenne il successo sperato. La maggior parte della critica la accolse con grande entusiasmo, anche se non mancarono voci come quella di Cesare Segre, che ebbe parole piuttosto dure per il romanzo, da lui ritenuto un libro attempato, a conferma di una letteratura italiana per lui “inguaribilmente noiosa e inattuale”.
I problemi per la ricezione del libro di D’Arrigo furono legati al carattere d’impresa della scrittura del romanzo. Tra gli altri, Carlo Bo sottolineò i risvolti negativi dell’imponente campagna pubblicitaria, a causa della quale ‘il caso Horcynus Orca’ sembrava esaurito già a un mese dalla sua pubblicazione, e allo stesso tempo l’impatto dei quindici anni di lavoro dell’opera, equivalenti a due stagioni letterarie, che rendevano il libro per alcuni non più attuale.
Parte della critica giudicò negativamente la lunga gestazione dell’opera e in particolare l’aggiunta del ‘monologo dello sperone’, ritenuto l’esempio di un’eccessiva prolissità, criticata aspramente, tra gli altri, da Pietro Citati, che parlò di un D’Arrigo “vittima di un vampiro che succhia le sue doti migliori”. Al di fuori del mondo della critica, tra il grande pubblico fu sicuramente la combinazione tra la mole del libro e una lingua che nelle prime pagine può risultare troppo complessa e creare spavento nel lettore.
A cinquant’anni dall’uscita del romanzo, la situazione, ad essere sinceri, non sembra poi così tanto mutata. Horcynus Orca è certamente un titolo conosciuto in ambito accademico, ma non sempre realmente letto e rimane comunque un’opera che non ha ancora ricevuto l’attenzione critica che meriterebbe. Sembrerebbe quasi che quell’aura di scrittore isolato che avvolge la figura di D’Arrigo e la stessa eccezionalità di Horcynus Orca siano andate a scapito del romanzo. Sarebbe bene allora mitigare questo carattere eccezionale dell’opera, che, pur rimanendo senza alcun dubbio un’esperienza di scrittura profondamente originale, andrebbe considerata nel contesto letterario nazionale e internazionale a lei contemporaneo. Parimenti andrebbero sottolineati i rapporti nel mondo intellettuale che lo stesso D’Arrigo intrattenne, malgrado la sua nomea di isolato.
Questo cinquantesimo anniversario di Horcynus Orca si presenta pertanto come un’occasione di riscoperta di un autore che merita di essere letto e studiato. L’auspicio allora è che a un crescente numero di giovani studiosi che tornano finalmente a D’Arrigo possa affiancarsi anche un crescente numero di lettori di un’opera che, pur presentando sicuramente alcuni punti deboli, si rivela un romanzo estremamente attuale che si presta a una molteplicità di approcci critici, come solo i grandi capolavori della letteratura sanno fare.
In copertina fotografia @gettyimages.
Leggi anche:
Paola Albarella | La Sicilia fra lutto e luce
Stefano Perpetuini | D’Arrigo riscrive Gogol’









