Post mortem. Vargas Llosa e Madame Bovary
Quale modo migliore di ricordare Mario Vargas Llosa, straordinario narratore e saggista altrettanto originale, scomparso domenica 13 aprile a Lima, se non quello di soffermarsi per qualche pagina su un punto della sua vasta cartografia letteraria?
Lascio volentieri ai “necrologisti” il compito di riassumere i suoi quasi settant’anni di vita attiva e contemplativa (venti romanzi, un libro di racconti, dieci opere teatrali, quattordici raccolte saggistiche, due raccolte di cronache e un libro, Il pesce nell’acqua, che è il suo solo lascito che si avvicina a un’autobiografia) durante i quali la letteratura e la politica sono sempre state due facce della stessa medaglia: quella della libertà individuale.
Vargas Llosa, uno dei principali artefici, con García Márquez, Carlos Fuentes e Julio Cortázar, del cosiddetto “boom de la novela” (dico sempre che la storia del romanzo della seconda metà del XX secolo è impensabile senza l’America Latina), sin da giovane, quando giunse a Parigi in cerca di fortuna, prese a modello letterario Flaubert e a modello intellettuale Sartre, l’inventore dell’engagement. Al primo rimase fedele sino alla fine, al secondo non proprio. A un certo punto preferì Popper, Isaiah Berlin e Aron. Come dargli torto? Così come agli inizi degli anni Settanta abbandonò il castrismo e il comunismo, trasformandosi in un “neoliberale” e ricevendo così le critiche di quasi tutti i colleghi di penna del suo continente, soprattutto del suo grande amico García Márquez, a cui, nel 1976, in quel di Città del Messico, per motivi non esattamente politici, fece un occhio nero. In realtà, il suo “neoliberalismo”, frutto dell’idea che la libertà deve darsi in tutti i campi, da quell’ economico a quello politico, da quello sociale a quello individuale, non ha mai avuto nulla a che fare con gli estremismi thatcheriani e reaganiani degli anni Ottanta. Appoggiava l’aborto, l’eutanasia, il matrimonio omosessuale, la legalizzazione delle droghe leggere ed è sempre stato critico di come Israele trattasse la questione palestinese. Di recente, aveva affermato con ironia che la sola definizione di “liberale” in cui si riconosceva era quella che una volta gli fece presente sua nonna: “Qualcuno che non va a messa e che divorzia”!
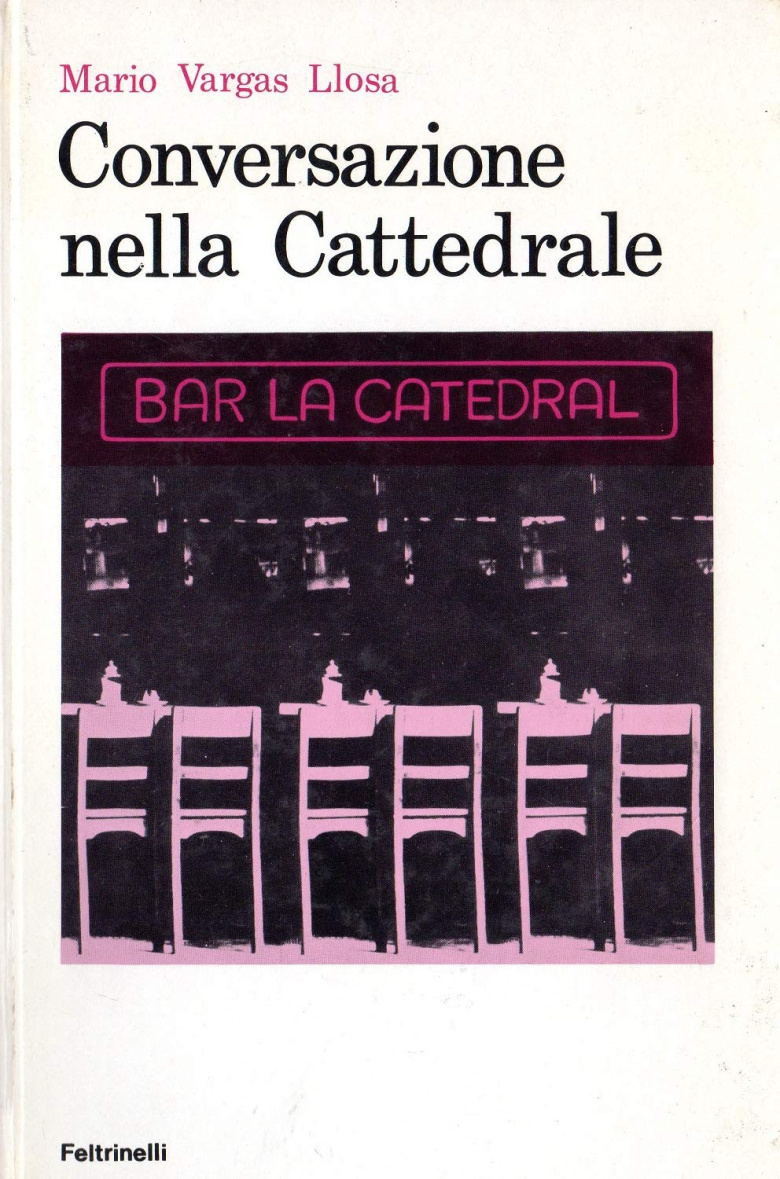
Avendo cominciato ad accumulare sin dalle prime prove letterarie tutti i premi possibili (Princesa de Asturias, Rómulo Gallegos, Planeta, Cervantes, Nobel) ed essendo diventato membro della Real Academia Española e perfino uno degli “immortali” dell’Académie Française (l’unico ad essere accettato senza aver scritto un solo libro in lingua francese), ripeteva spesso che il suo grande obiettivo, almeno finché il suo corpo non sarebbe diventato cenere, era quello di non essere trasformato in statua.
Rileggendo il discorso che pronunciò in occasione del Nobel, ho scovato un passaggio che è una sorta di elogio del vero lettore: “Le menzogne della letteratura diventano verità attraverso noi lettori, trasformati e contaminati dai desideri, e per colpa della finzione, in continuo contrasto con la mediocre realtà”.
Vargas Llosa è stato un grande scrittore perché non hai mai smesso, sin dal suo incontro con Flaubert, di essere un grande lettore. Non ha mai smesso, secondo il precetto borgesiano, di cercare i suoi precursori. Unica chance, una volta diventato cenere, di avere degli eredi.
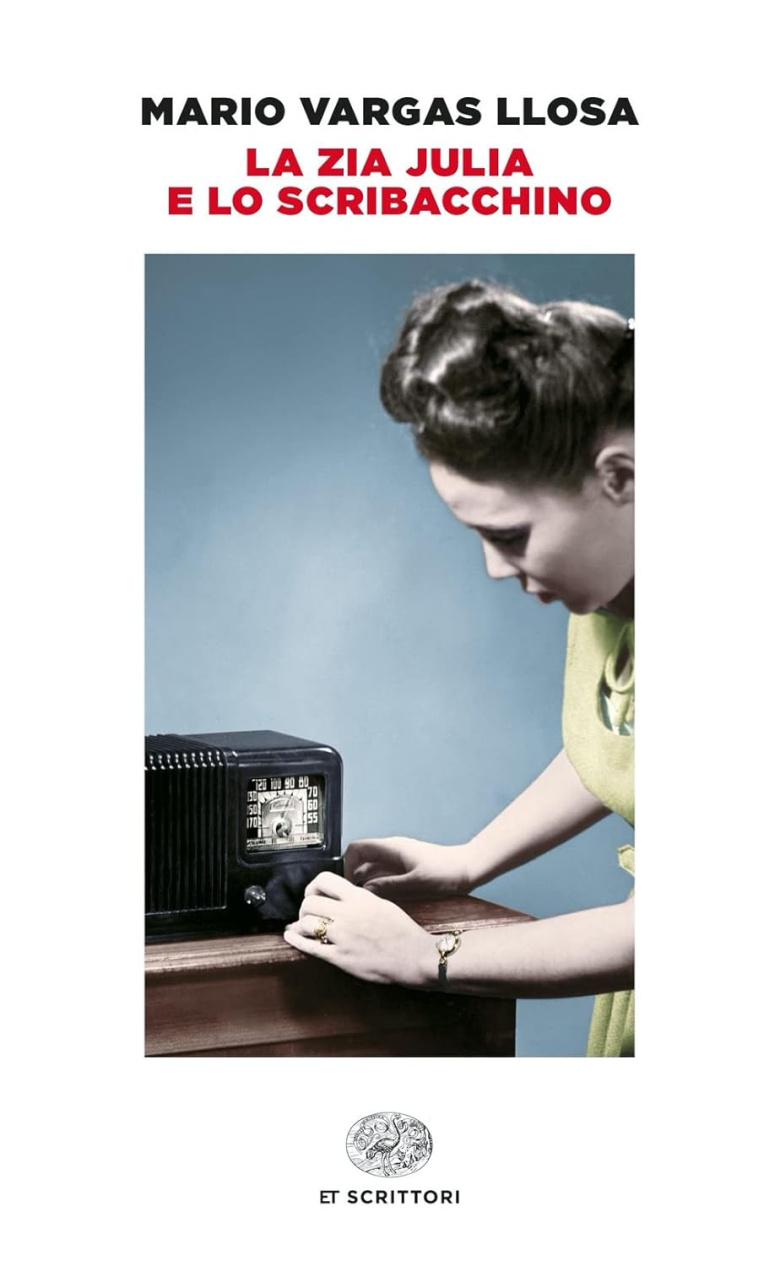
***
Di recente è stato ripubblicato (l’edizione originale è del 1975, mentre la prima traduzione italiana di Angelo Morino è uscita nel 1986) in una nuova traduzione (Giuliana Calabrese) un suo saggio L’orgia perpetua, dedicato a quello che lo stesso autore definisce “il primo romanzo moderno”, Madame Bovary.
La storia d’amore (perché di questo si tratta) di Vargas Llosa con il personaggio flaubertiano inizia nel 1959 (e non è più finita) quando, giunto a Parigi giovanissimo, compra un esemplare del romanzo e ne è subito sedotto, anzi “vampirizzato”. Da quel momento “sa” che tipo di scrittore desidera diventare, “sa” che tipo di romanzi desidera scrivere, “sa” che preferirà la descrizione oggettiva a quella soggettiva, “sa” che sceglierà l’invenzione realistica all’invenzione fantastica, la concretezza all’astrazione, “la pornografia alla fantascienza, i romanzi rosa ai racconti dell’orrore”. Incontro fatale, il suo, incontro definitivo.
Ma, fin da subito, il suo Flaubert non ha niente a che vedere con la duplice vulgata che allora andava per la maggiore, soprattutto in Francia. Quella del Sartre di L’idiota della famiglia, un lavoro “gigantesco” che, impiegando ogni genere di strumento, dalla psicanalisi al marxismo, dalla fenomenologia all’esistenzialismo, non riesce mai a raggiungere il suo scopo: “spiegare le radici e la natura della vocazione di Flaubert”. Cui va aggiunta quella del “Nouveau roman”, per cui Madame Bovary è un’opera in cui non succede nulla, in cui i personaggi sono meno importanti dello stile, in cui la descrizione degli oggetti vince sulla story… Non è così, afferma Vargas Llosa: nel romanzo accadono tante cose quante ne accadono in un romanzo di avventure: matrimoni, adulteri, viaggi, balli, truffe, malattie. Solo che si tratta di avventure miserabili, mediocri, che sprigionano tutte, con diverse gradazioni e intensità, l’eterna bêtise umana (Ricordate? “Tre cose occorrono per essere felici: essere imbecilli, essere egoisti e avere una buona salute; ma se vi manca la prima, tutto è perduto”). Poi: la realtà soggettiva dei personaggi ha lo stesso peso di quella oggettiva. La differenza tra il romanzo di Flaubert e quelli romantici sta proprio qui: “i pensieri e i sentimenti paiono come fatti”, “le cose si umanizzano e gli uomini si reificano”. Per cui il celebre proposito di Flaubert di voler scrivere un “livre sur rien” va inteso, secondo Vargas Llosa, da una parte come la volontà di dare al romanzo, attraverso il suo stile, la dignità che fino ad allora aveva solo la poesia; dall’altra, quella di difendere l’autonomia del romanzo, la quale è data solo dalla forma in cui si realizza.

Sistemata la forma, si passa ai temi. Che cosa ama Vargas Llosa? Il fatto che in Madame Bovary, come in altri romanzi che gli sono rimasti impressi, vi siano combinati “con perizia, ribellione, violenza, melodramma e sesso”.
Chi è Emma? Una ribelle che, sebbene non abbia i tratti dell’eroe del XIX secolo in lotta per i popoli e per l’umanità, trasgredisce i codici della sua società: è adultera, mente, ruba, è sommersa dai debiti e alla fine si suicida. Emma trasgredisce spinta dalla fantasia, dai libri che legge, dai sogni. Ma, in fondo, ciò che vuole è qualcosa di molto materiale: vuole il piacere del corpo, vuole godere perché il marito non la può soddisfare, e vuole circondarsi di eleganza, di raffinatezza, di bellezza, di denaro, cose che a Yonville, il paesino in cui vive, non può ottenere. Per Vargas Llosa, la radice di ogni azione di Emma viene da questa convinzione: “non mi rassegno alla mia sorte, la dubbia compensazione dell’aldilà non mi interessa, voglio che la mia vita si realizzi piena e completa qui e ora”. Certo, c’è del “romanticismo” in tutto ciò – e il romanzo potrebbe essere letto come una macchina costruita per distruggere ogni “verità romantica” – ma la Emma di Vargas Llosa, per quanto sdolcinata, frivola e un po’ grossolana, ha qualcosa della suffragetta ante litteram. Rappresenta “un lato umano brutalmente negato da quasi tutte le religioni, filosofie e ideologie e da esse presentato come motivo di vergogna per la specie”. La storia di Emma, in altri termini, è una cieca e pervicace, perfino disperata ribellione contro una società che reprime “il diritto al piacere”, diritto che dovrebbe essere universalmente concesso a tutti. Da qui la violenza, che, attraverso lo sguardo clinico, da anatomista, del narratore – è stato Flaubert, figlio e fratello di medici, a inaugurarlo nella storia del romanzo – si manifesta in molti modi. Non solo nella fisicità del dolore e del sangue (la cancrena e l’amputazione della gamba di Hyppolite, l’avvelenamento di Emma), ma anche nelle forme spirituali dell’egoismo, della viltà (Rodolphe, Léon) e nelle forme sociali dello sfruttamento (l’anziana Leroux). Per non parlare di quella forma più subdola di violenza che è la stupidità, fatta di trabocchetti morali, pregiudizi, invidie, imbrogli a cui nessuno sfugge. Qui la bêtise flaubertiana, a mio modo di vedere, subisce una torsione. L’amore per il melodramma di Vargas Llosa, il fatto che sia “più vicino al reale del dramma”, dato che in esso il lato “dozzinale, patetico, parodico” dell’esistenza si mescola a quello più nobile e tragico, dà alla bêtise un’interpretazione che forse Flaubert non avrebbe del tutto negato, ma neppure del tutto accettato. La incorona, per così dire, come quel territorio in cui i modelli estetici, linguistici, morali, sociali ed erotici di una società, stabiliti dalle cosiddette “élites”, subiscono un abbassamento comico, una volgarizzazione, un trattamento emotivo tanto degradante quanto creativo, “un incarognimento” liberatore. In virtù dell’ignoranza e dell’ingenuità che lo alimentano, il melodramma è il regno del Kitsch (huachafería nella versione peruviana), il quale si rivela come una delle espressioni umane più universali. Insomma, la bêtise di Flaubert si trasforma in Kitsch, ma in un Kitsch considerato non come qualcosa di demoniaco (Broch) né come quell’ideale estetico per il quale l’individuo ammette “un accordo categorico con l’essere” (Kundera), eliminando così dal suo campo visivo tutto ciò che nell’esistenza umana è inaccettabile e, allo stesso tempo, abbellendo costantemente tutto ciò che non accetta, foss’anche la merda.
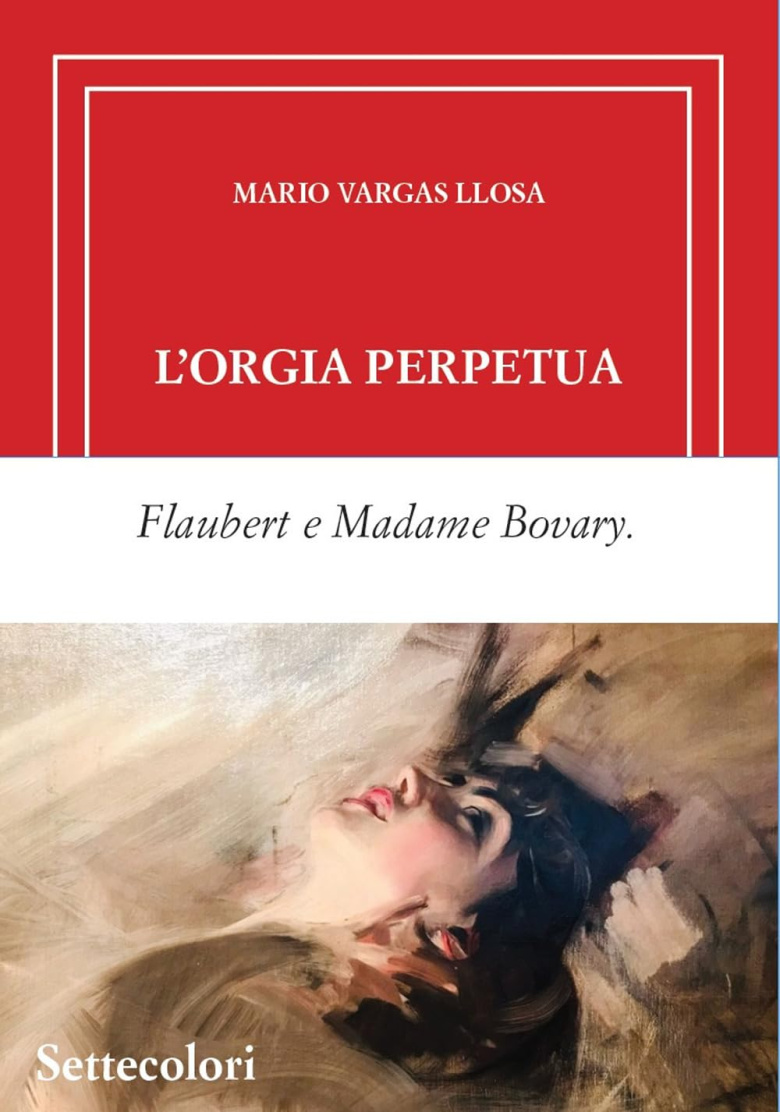
Vargas Llosa, lo afferma più volte, non ama i romanzi dove non c’è il sesso.
Beh, Flaubert, lettore del Marchese de Sade e implacabile castigatore di ogni anima bella, sarebbe stato d’accordo. A conferma di ciò lo scrittore peruviano cita un brano di una lettera a Louise Colet dove Flaubert se la prende con Lamartine e il suo romanzo Graziella: “Prima di tutto, per parlare chiaro, la scopa o non la scopa? Non sono esseri umani, ma manichini. Come sono belle queste storie d’amore in cui la cosa principale è talmente circondata dal mistero che non si sa cosa pensare, dato che l’unione sessuale è relegata sistematicamente nell’ombra, come il bere, il mangiare, il pisciare […] È più facile in effetti disegnare un angelo che una donna: le ali nascondono la gobba” (n.b. traduco in italiano. Nel saggio tutte le citazioni dalle lettere sono lasciate nell’originale francese). Forse Flaubert, se fosse vissuto nel XX secolo, avrebbe fatto concorrenza a Henry Miller? Mah, non lo so. Non di certo a D.H. Lawrence. E, per ragioni opposte, neppure a Nabokov. Forse il suo gesto brutale contro ogni ornamento dell’essere, il suo scetticismo devastatore, il suo ateismo privo di ogni spiritualità, la sua irriverenza materialista nei confronti di ogni morale (“la fisica vince sulla morale. Non c’è delusione che faccia soffrire come un dente cariato”) lo avvicinano a Kundera. In ogni caso, quel che è certo è che Flaubert, per aggirare la censura (cosa che, come sappiamo, non gli riuscì del tutto), figlia del “sinistro puritanesimo” del Secondo Impero, di sesso in Madame Bovary non ne fa vedere granché. Eppure, afferma Vargas Llosa “il sesso è alla base di tutto ciò che accade e, assieme al denaro, la chiave dei conflitti, e la vita sessuale ed economica sono tanto intimamente intrecciate, che l’una non può essere compresa senza l’altra”. Ciò di cui parla Vargas Llosa, naturalmente, non è sesso, ma “sesso in agguato”: eros, o, sensualità. Questa sì impregna tantissimi episodi del romanzo: Justin che contempla la lingerie di Emma; Léon che adora i suoi guanti; Charles che, dopo la morte della moglie, desidera tutti gli oggetti che Emma avrebbe voluto avere; Emma che si scioglie i capelli di fronte a Léon con un savoir faire da consumata prostituta; il primo incontro tra i due amanti nella cattedrale di Rouen:
“Léon camminava lungo i muri, con gravità. La vita non gli era mai parsa così bella. Emma stava per arrivare, affascinante, inquieta, intenta a spiare dietro di sé gli sguardi che la seguivano, con il suo vestito a volanti, l’occhialino d’oro, gli stivaletti sottili, piena dell’eleganza che lui non aveva mai goduto e dell’ineffabile seduzione della virtù che soccombe. Ecco: la chiesa, pur così vasta, le si chiudeva intorno come un boudoir.”
E cosa dire della scena forse più indimenticabile di tutto il romanzo: la scena della carrozza? La descrizione dei movimenti della carrozza rappresenta la descrizione del rapporto sessuale tra Emma e Léon. La stanchezza del cocchiere rappresenta la stanchezza degli amanti. Più il narratore prolunga la sua descrizione, nominando uno dopo l’altro i quartieri di Rouen che la carrozza attraversa, più sappiamo che Emma e Léon stanno andando lontano. La “mano nuda” che, alla fine della scena, “di sotto le tendine di tela gialla” si intravvede nel gesto di gettare un pugno di pezzi carta è il gong che il lettore sente risuonare silenziosamente e che decreta la fine del coito. Un coito invisibile in un’epoca in cui censura, autocensura, leggi, morale, religione, pudore erano limiti invalicabili. Non vediamo nulla e immaginiamo tutto.
Nel XX secolo il romanzo scopre, da Kafka a D. H. Lawrence, da I. B. Singer a Henry Miller, da Nabokov a Philip Roth, da Vargas Llosa a Houellebecq, tutti i territori della sessualità. A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso tutte le tappe, dal primo incontro all’amplesso, vengono bruciate. La sessualità, nel giro di pochi decenni, si libera a una velocità vertiginosa dell’eros e dell’amore e costringe l’uomo a confrontarsi con la sua nudità: lo costringe a guardare il proprio corpo come carne, funzione biologica, o istinto.
Oggi vediamo tutto e non immaginiamo nulla e tale situazione ci sembra inevitabile, acquisita. Oggi, nell’epoca dell’umanitarismo e dei diritti, tutto è permesso. Leggi, famiglia, costumi non si oppongono al desiderio. E il desiderio, non trovando ostacoli, non solo perde la sua forza di trasgressione, ma diventa nemico di sé stesso: non trova più piacere. E che ce ne facciamo di un desiderio che non conosce più il piacere? Siamo alla banalità del sesso e nessuno ne fa una tragedia, un dramma, o, al limite, un melodramma. Nel giro di un paio di generazioni siamo passati da un asfissiante puritanesimo a un’asfissiante volontà di liberarci di tutti i vincoli che tengono insieme una civiltà. Siamo passati dalla guerra al puritanesimo alla pace pornografica. Il nostro mondo ha talmente rovesciato i valori del mondo in cui viveva Flaubert, che oggi Madame Bovary sarebbe una sex worker in cerca di marito.
In tutto questo, uno potrebbe chiedersi: che ne è dell’amore in Occidente? Di quella concezione dell’amore che ha impregnato la nostra storia della poesia e la nostra storia del romanzo, che da Jaufré Rudel ai Surrealisti ha determinato il nostro modo di stare al mondo? Che ne è della sua forza trasgressiva in grado di abbattere ogni barriera morale e sociale in un mondo in cui non si vogliono più limiti? Che ne è di quell’attrazione involontaria verso un essere umano unico che la nostra libertà trasforma in un’unione volontaria, in un mondo che desidera liberarsi di ogni contrassegno di umanità, di ogni immaginazione, che non scorge più la frontiera tra anima e corpo? Che ne è dell’amore in Occidente, nato dalla libertà della donna, se la donna non è libera, o lo è a tal punto da scambiare il modello di libertà maschile con il suo?
L’amore della specie umana occidentale nel XXI secolo è, nel migliore dei casi, l’idillio di due esseri che, dopo aver obbedito alle leggi naturali della sessualità, fissano muti, con altrettanta naturalezza, lo schermo dei rispettivi cellulari dove scorrono le immagini registrate dei loro atti. Ciò che amano è la ripetizione dell’identico.
Octavio Paz, nel suo saggio La duplice fiamma, scriveva che l’erotismo, a differenza della sessualità che comprende tutto il regno animale, è solo umano. L’eros è sessualità socializzata e trasfigurata dall’immaginazione, dalla metafora, dalla poesia. Mi domando: può esistere una società umana in cui la sessualità diventa la sola forma di poesia? Può esistere una poesia della sessualità? Una poesia non erotica, non amorosa?









