
La buona instabilità dei vecchi
Tra le condizioni indispensabili per vivere c’è la stabilità. Noi abbiamo bisogno di stabilità, di poter contare sulle certezze che la nostra continua esperienza esistenziale ci mette a disposizione, sulle quali possiamo appoggiarci per stare in piedi. Finché qualcosa di stabile ci garantisce il suo sostegno noi riusciamo a guardare il mondo da un punto fermo, appunto, da una sorta di faro che stabilisca il nostro orientamento sul mare del futuro. Freud usava il termine “costanza”. Stabilità non significa staticità: si può vivere stabilmente indecisi, irrequieti, insoddisfatti, ma ciò che ci serve è la costanza di noi stessi. Deve essere stabile la dimensione in cui ci riconosciamo.
Adolescenza e vecchiaia sono i momenti più critici della vita dal momento che sono la messa in discussione della nostra stabilità. Con l’essenziale differenza che la prima ci proietta nella stabilità adulta, mentre la seconda diviene la certificazione della fine stessa della stabilità. A quel punto l’instabilità diventa la nuova “costanza”.
Questa introduzione, certo rude, mi pare indispensabile per aprire una riflessione sull’invecchiare contemporaneo, su quel nuovo comando della plancia che a noi oggi tocca innescare. Perché dobbiamo fare i conti con l’instabilità epocale che è diventata un dato strutturale del mondo, una cosa, che quando si presenta nella Storia, sovverte tutti gli ordini (sociali, economici, etici…). La nuova vecchiaia è l’instabilità dell’individuo dentro l’instabilità del mondo.
Scegliamo un approccio induttivo, partiamo da un caso particolare per provare a leggere il generale. Ho letto con curiosità il libro del coreano Rhee Kun Hoo, La gioiosa arte di invecchiare (Longanesi 2024, pp.240). Pensavo fosse un saggio sulla vecchiaia vista a cavallo tra due culture, quella occidentale e quella orientale. Come dire, un passo avanti nella direzione di una condivisione che due grandi tradizioni possono fare di uno stesso tema. Il tema è certamente assai suggestivo, vedere come reagiscono le diverse antropologie davanti alla dura sostanza della moderna vecchiaia. Pensavo a un saggio, ma in realtà è una accattivante narrazione che racconta La via coreana per una vita lunga e felice, come dice il sottotitolo. E proprio qui sta l’elemento orientale: dire il mondo in forma concreta, priva (ma non ignara) dei tecnicismi teorici del sapere. Prima viene la realtà fattuale con le sue masse corporee che non sono un prodotto del pensiero e delle sue circonvoluzioni, poi segue il riflettere “pragmatico”.
Rhee Kun Hoo è un illustre psicoanalista e psichiatra della Corea del Sud, con una lunghissima carriera di terapeuta e docente universitario che, unita a una vita privata densissima di eventi anche gravi (galera compresa) fin dalla sua infanzia, ha costruito la sua figura di uomo particolarmente “carico di vita”, propria e altrui. Alla bella età di 87 anni “e sette patologie”, come ricorda spesso nel libro, decide di dire la vecchiaia attraverso l’analisi delle fasi della sua vita. Avrebbe potuto diventare un’opera monumentale se avesse utilizzato gli accessori scientifici, il bagaglio imponente della psicoanalisi e della medicina clinica, ma ha scelto di “parlarne” con il tono cordiale che un vecchio signore di grande esperienza userebbe rivolgendosi a un caro amico o magari a un giovane curioso di capire l’altra umanità che lo ha preceduto.
Fate pace con l’ospite inevitabile, Siate grati dei compagni di vita, La gioia di non sapere, Quant’è piccolo il mondo, Siamo tutti sulla stessa barca, Vivete con semplicità, Perseveranza, Mai sottovalutare il potere della felicità quotidiana, La vita è una storia da leggere fino all’ultima pagina. Bastino i titoli dei paragrafi della quinta e ultima parte del libro per sentire l’odore generale della storia di Rhee Kun Hoo, a prescindere dal suo curriculum e dalle sue conoscenze: “io faccio così”, questo messaggio rende estremamente nutriente il racconto di vita, di un’esperienza alta-e-comune, al pari (ma senza elementi di finzione) di un romanzo di formazione. Tra gli inserti di vita, come dicevo densissima di eventi anche crudi (per esempio il tracollo economico della famiglia che costringe tutti i membri alla povertà o l’esperienza della prigione per aver partecipato alla lotta di liberazione dalla dominazione giapponese), il “professor Kun Hoo” dispensa gli utili riferimenti scientifici che aiutano a sistemare le situazioni di vita in un quadro teorico, ma senza indulgere in fredde disquisizioni o analisi critiche. Lavora con la sua sapienza più che con le sue conoscenze.
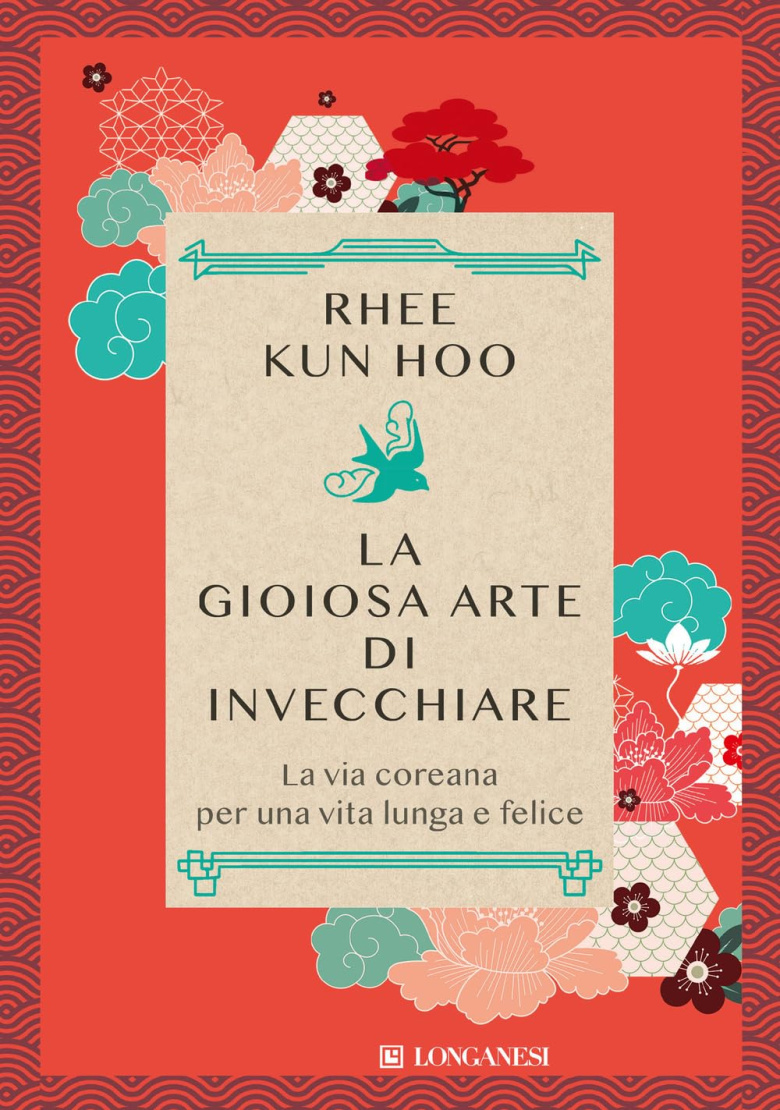
Naturalmente c’è l’Oriente, la sua passione per l’Himalaya, i gruppi terapeutici disseminati in anni di attività in Nepal, il Buddhismo pragmatico dei momenti di meditazione. Nulla, tuttavia, che possa suscitare una visione da “orientalisti”, del tipico sguardo da occidentali “dominatori” su quella lontana cultura (tema chiarito definitivamente nel 1978 da Edward Said in Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, Feltrinelli). L’autore è e rimane un moderno studioso globalizzato che non si può rinchiudere entro alcun confine culturale.
La “comparazione” tra società occidentali e orientali rimane un tema ineludibile, ma per quanto riguarda la vecchiaia non si può non constatare una vera consentaneità tra Estremo Oriente e Italia, e più segnatamente tra Giappone e Italia. Mi diverte sempre ogni anno vedere come la “classifica” ponga in cima ora l’Italia ora il Giappone, e ogni volta c’è come un soffio competitivo che mi fa gioire quando noi italiani arriviamo secondi: che bello, oggi siamo meno vecchi dei giapponesi! Rispetto al resto del mondo rimaniamo senza dubbio realtà “imbattute” relativamente a dimensioni e qualità del fenomeno dell’invecchiamento. Ce n’è di lavoro da fare per la moderna antropologia, e i nipponici, mi pare, con la loro mistione Oriente/Occidente, mettono sicuramente più acutamente alla prova l’umanità anziana, come chiaramente dimostra il diffondersi di comportamenti particolarmente rivelatori: la ricerca di lavoro anche degli ottantenni, la volontà di superamento della solitudine tramite condotte illegali (si ruba per andare in galera dove non si sta più soli) o l’aumento del fine-vita volontario (nel 2013 il ministro delle Finanze giapponese Taro Aso invitò gli anziani persino a “sbrigarsi a morire”).
La Corea del Sud non è il Giappone (lo sanno bene i coreani…), ma è un paese dove ugualmente la compenetrazione delle “visioni del mondo” (come si diceva una volta) orientale e occidentale agisce con forza creando nuove forme di equilibrio antropologico. La gioiosa arte di invecchiare credo ne sia una prova convincente. Sostiene Rhee Kun Hoo (con lo psichiatra britannico Anthony Storr) “che la vita è una moneta con due facce composte da desideri opposti. Una ci spinge a creare legami con le persone, l’altra a tornare al nostro vero Io nella solitudine. Tale dicotomia esiste non solo nelle relazioni sociali, ma anche in quelle professionali e sentimentali. Cresciamo tramite le nostre responsabilità e i nostri doveri e impariamo a trovare gioia nei sacrifici e nell’aiutare gli altri, ma nel profondo lottiamo anche con l’irresistibile desiderio di vivere per noi stessi. La vita si trasforma in un paesaggio desolato quando non riusciamo a mantenere l’equilibrio tra queste due tensioni contrastanti. Tutti noi abbiamo bisogno di tale senso di equilibrio: assolvere i nostri doveri senza perdere noi stessi” (p.116). È la binarietà dell’esistenza e della vecchiaia.
Prosegue l’autore: “Per fortuna, io ho due mondi. In qualche modo sento di potermi rilassare in Nepal, dove riesco a svuotare la mente dagli affari mondani per poi tornare in Corea del Sud e condurre una vita normale senza crollare. Vivere con il paraocchi non può portare altro che al crollo. […] Forse non è necessario spingersi fino in Nepal, ma lasciate che vi dica una cosa: è meglio trovare un rifugio sicuro al più presto. Quando si ha estremo bisogno di una tregua, se e quando le maree della solitudine e del vuoto iniziano a lambirci i piedi, potrebbe essere una sfida quasi impossibile scovarne uno dal nulla” (pp.116-117). Qui sta forse il punto cruciale, in questa binarietà ben scolpita in testa: avere un posto dove stare, ma averne anche un altro dove potersi rifugiare.
Esserci, questo è il dato necessario: in una realtà complessiva modificata, rinnovata, ricodificata. A prescindere dalle logiche di durata dell’esistenza del singolo. Pensare alla conclusione, a quanto ci resta da vivere, è solo un aspetto, inesorabile certo, ma che tuttavia non necessariamente indebolisce ciò che di umano comunque circola e irrora la vita di tutti. Sia detto con prudenza: l’instabilità fa male, ma quando è in qualche modo governata (come quella di Rhee) può trasformarsi in forza di reazione, in energia ulteriore per un individuo non più né creato né creatore, ma semplicemente creante.
Si tratta di mettere bene a fuoco il fatto che la nuova vecchiaia può diventare una delle moderne risorse dell’umanità. Quando, come oggi, il fenomeno diventa massa critica non è più possibile pensarlo come risorsa residua (il nonno che semplicemente aiuta figli e nipoti ad andare avanti), come avanzo di lavorazione, ma al contrario lo si deve percepire come terreno di nuova coltura, di elaborazione inedita che tutti può e deve coinvolgere. I vecchi non possono più “permettersi” di fare solo da testimoni di un vissuto perduto poiché costituiscono una massa umana custode di ricchezza del tutto spendibile in termini di collaborazione e incentivo (il nonno, ripeto, è un esistere non un finire). Superata la visione accessoria, l’azione culturale può diventare propulsiva in una nuova economia delle forze dinamiche sociali.
Se l’instabilità si stabilizza, lasciatemi il gioco di parole, i nuovi vecchi possono diventare un solido sostegno a cui appoggiare una vita collettiva migliore. Nella crescente precarietà dell’equilibrio del mondo, una nuova instabilità buona potrebbe farci uscire dalla visione limitante e perdente della longevità come unico fine.
Leggi anche:
Tutti ciechi davanti alla fine di Maurizio Ciampa
La vita segreta dei vecchi di Rossella Menna
Il popolo degli anziani di Alfredo Gigliobianco









