La fine degli amori e altri addii
Non è facile parlare di questo libro, non perché sia complicato il suo testo o il tema che affronta, non è facile semplicemente perché tocca un lato della nostra struttura umana molto spigoloso. È una questione emotiva. Leggere le sue centotrentaquattro pagine vuole dire guardarsi a uno specchio particolarmente spietato e (ri-)fare i conti, in poche ore, con la propria vita, quella vera, quella più profonda e intima. E quello che se ne ricava è una lezione fondamentale: non c’è rimedio ai malanni della nostra esistenza tortuosa fatta di rotture. Il libro è Rupture(s) nell’originale francese, della filosofa Claire Marin, che in italiano esce con una titolazione piuttosto edulcorante: La fine degli amori e altri addii che trasformano la nostra vita (Einaudi 2023). È una riflessione rivolta a capire quanto pesi la massa di lacerazioni che deriva dai vissuti di rottura, appunto, che segnano la vita di ciascuno.
“La rottura, scelta o subita – dice Marin –, ci infligge una torsione psichica e fisica insopportabile, dobbiamo reggere la deformazione della nostra identità, della nostra esistenza. In questa deformazione diventiamo esseri mostruosi. Nostro malgrado” (p.8). Dopo non c’è rinascita o ripartenza, l’Io non diviene più autenticamente sé stesso, bensì c’è una metamorfosi che altro non è se non “una consolazione, una ricostruzione a posteriori necessaria per sopportare il dramma, per dare senso all’assurdità della morte, della malattia, del trauma” (p.11). Questa, in sintesi, è la nostra dinamica. E ogni vita – scrive l’autrice ricordando Gilles Deleuze – appare come “una frase quasi folle, con i suoi cambiamenti di direzione, le sue biforcazioni, le sue rotture e i suoi salti, le sue distensioni, le sue gemmazioni, le sue parentesi” (p.13).
Si comincia con il distacco primario dall’utero materno, un marchio nostalgico che secondo Sigmund Freud ci portiamo dentro per tutta la vita, e poi è tutto un divenire di balzi in avanti/indietro. Dai sentimenti, al lavoro, alla più grande delle “rotture”, cioè il lutto. Ci sono tuttavia orizzonti diversi da cui guardare il processo, comunque sempre lacerante, della rottura. “Diventare sé stessi”, per esempio, a cui è dedicato uno dei capitoli più interessanti del libro. A volte, dice Marin, emanciparsi dal Sé che ci hanno cucito addosso è un percorso doloroso e costoso, ma liberatorio: cacciare il “falso Sé” (Donald Winnicott) è un atto di rottura rigenerante che, pur con un fardello di vissuti indelebile e difficile da sopportare, rimane un atto di conquista, l’arrivo in una nuova terra dove rimettersi alla prova.
Sempre a proposito della nostra natura plurima (“Forse non siamo fatti per un solo io”, è l’esergo di Henri Michaux al capitolo su “Il piacere della dispersione”), l’autrice osserva che pur ricevendo culturalmente l’idea di essere un individuo unitario, un soggetto unificato, un solo Io, in realtà “ci disperdiamo in continuazione e sopportiamo la nostra esistenza proprio perché siamo capaci di essere mentalmente da un’altra parte, perché possiamo giocare con il reale rivestendolo di un velo immaginario; perché, per rendercela sopportabile, sovrapponiamo incessantemente alla realtà proiezioni, fantasticherie” (p.60-61). C’è una sorta di Io funzionale che è quello, diciamo, di riferimento per la vita di tutti i giorni, e, insieme, c’è un ventaglio di Io possibili. Un tema evidentemente cruciale, visto che sull’irrealtà dell’Io hanno ragionato Pascal, Montaigne, Hume, Nietzsche, Bergson, Michaux. “È la circostanza o la situazione che mi fa diventare un altro” (p.61), diceva Henri Bergson che pensava a un soggetto-caleidoscopio e aggiungeva “È faticoso essere una persona”. Per questo, conclude Marin, c’è persino un “piacere della dispersione”, e sarebbe la nostra stessa composizione interiore, fatta di più identità, età, sensibilità, vissuti, che “ci libererebbe dal peso di essere solo noi stessi e ci permetterebbe una dispersione gioiosa e stimolante” (p.68).
Gli sviluppi di riflessione sono davvero infiniti. La fine degli amori ricorda Distacchi di Judith Viorst, un libro pieno di Letteratura, apparso nell’ormai lontano 1986 negli Stati Uniti e che ebbe una straordinaria diffusione proprio per la sua capacità di toccare, con strumenti molto diversi da quelli di Claire Marin, la realtà altamente variegata delle dinamiche di distacco-rottura. In quest’opera si trova anche una lungimirante attenzione (che la studiosa francese non ha) al mondo della nuova vecchiaia. Non per caso il libro della Viorst è tutt’oggi ripubblicato e tradotto (ultima edizione italiana del 2019 per Sperling & Kupfer).
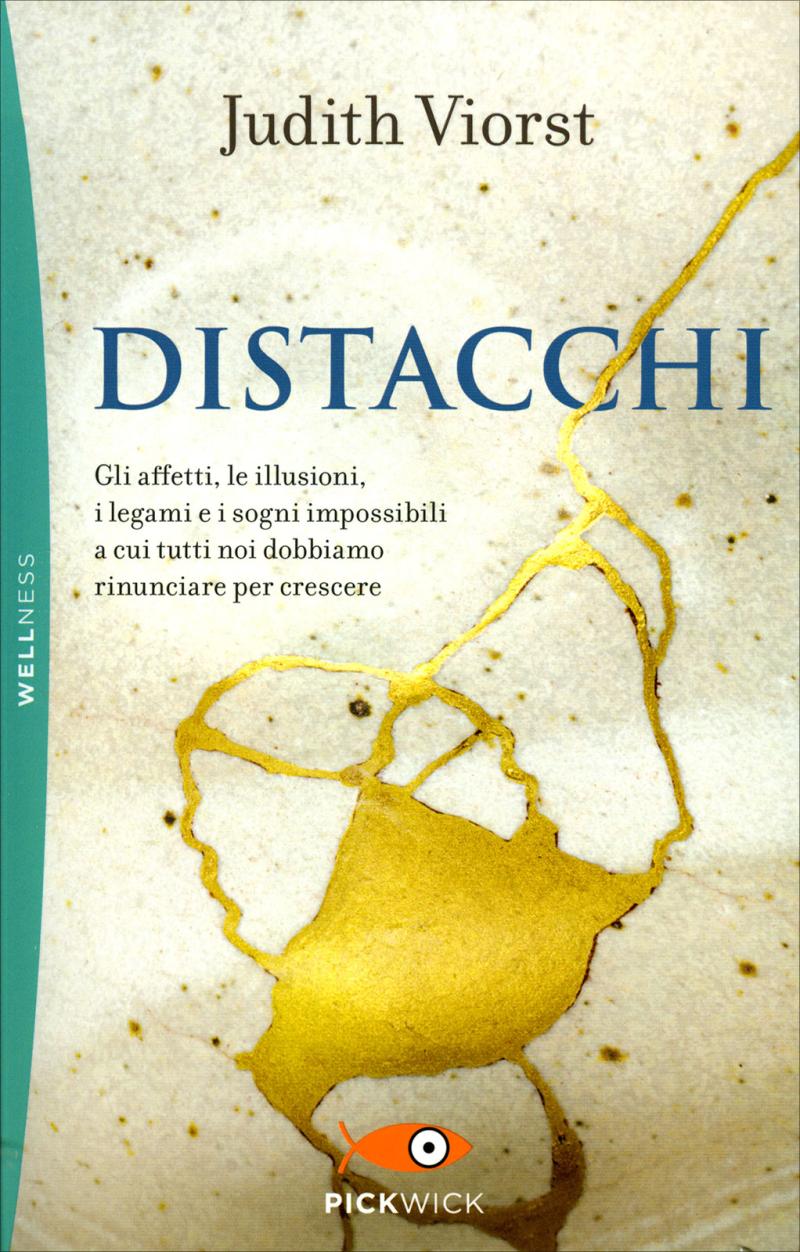
C’è dunque un’altra dimensione su cui proiettare l’evento di rottura, quella collettiva. Su questo Marin è molto netta: bisogna prendere atto, scrive, che “la rottura ha assunto una forma diversa, è più presente e potrebbe essere la forma nuova o a venire della nostra esistenza in generale. […] Sul piano ecologico e di conseguenza economico e politico dobbiamo ripensare urgentemente il nostro modo di vivere, di comunicare, di spostarci, come anche le nostre abitudini di accaparramento delle ricchezze […]. Riconoscere la rottura sarebbe allora una prova di maturità di fronte alla necessità di un cambiamento vitale, sul piano dell’esistenza individuale come sul piano dell’esistenza collettiva: dimostrerebbe la presa di coscienza delle nostre responsabilità”. Bisogna – prosegue – “smettere di credere in una sostanziale permanenza del mondo, in una ricreazione infinita della natura. Accettare che la configurazione non è più quella della ciclicità, ma che ci troviamo ad affrontare un momento di rottura ecologica. […] Occorre affrontare le nostre maggiori paure e ragionare su una pedagogia della rottura” (p.12).
La società contemporanea è nuova per molti aspetti, è una società in cui “cambiare paradigma” è divenuto l’imperativo individuale per affrontare la quotidianità nella quale, dal lavoro ai sentimenti, devi “realizzare te stesso”. “Rompere” può coniugarsi a una strana idea di libertà per cui i rapporti si fanno e si disfano inseguendo una diffusa e mai vista specie di follia, gli sradicamenti possono essere violenti, perché devi adattarti, essere flessibile, nomade, senza legami. Ma in questa nostra società mutante, dice Marin, se le rotture “sono visibili, identificabili, le crepe dell’esistenza non sono nuove” (p.13).
La rottura tuttavia non è presentata come “l’occasione di una vita nuova” (“resisterò per ostinazione o convinzione alla tentazione dell’ottimismo”, sottolinea l’autrice). Al contrario si deve prendere lucidamente atto che “A volte la rottura è solo un pasticcio, una mancanza di coraggio, una viltà. […] E spesso il fallimento è fallimento puro e semplice, misero, deludente, un insuccesso totale. La maggior parte dei fallimenti non ci insegna niente. […] Alla vigilia di una nuova avventura non sono più agguerrito grazie alle disfatte precedenti, rischio anzi di perdermi di nuovo per le stesse vie traverse. È possibile che in fondo non abbia imparato niente” (p.15).
Dunque di non rimediabili rotture siamo fatti? O anche d’altro? Massimo Recalcati ha recentemente (anche lui!) riflettuto sul lutto, la rottura maggiore, e sul sentimento che generalmente ne segue, la nostalgia. Lo psicoanalista fa ricorso allo Zarathustra di Nietzsche e alla figura del funambolo, che simboleggia l’uomo che si espone “sul grande abisso di una vita libera”. Quando “l’imprevedibile, l’ingovernabile” compare, sotto le spoglie di un pagliaccio, il funambolo precipita e muore. Sarà Zarathustra che da solo lo porterà sulle sue spalle e gli darà degna sepoltura incastonandone il corpo nel cavo di un albero. Scrive Recalcati: “Egli porta con sé l’acrobata caduto per dargli una giusta sepoltura ed ereditarne il messaggio: l’uomo è obbligato a superare sé stesso, a vivere nella contingenza assoluta dell’esistenza” (La luce delle stelle morte. Saggio su lutto e nostalgia, Feltrinelli 2022, p.123).
Un’altra risposta alle stesse domande. Claire Marin cita l’esperienza della filosofa Marion Muller-Colard che mentre stava vivendo l’angosciosa situazione della malattia del figlio appena nato, si chiedeva: “Dove trovare il coraggio di essere nonostante la Minaccia?” Così risponde l’autrice Marin chiudendo La fine degli amori: “Nella gioia. Assumersi il rischio di vivere significa scommettere sulle gioie possibili. E avere la forza di ricordarsi, anche nella notte tragica, della scintilla di gioia che si celava in essa. […] Forse è semplicemente nel ‘sorriso dei bambini che ci fanno esplodere il petto’ che ritroviamo la forza di affrontare l’incertezza della vita e il coraggio di essere” (p.116).
Ecco, la resilienza. Lo dico con semplicità: questo è un libro che prova a dire la realtà effettiva degli uomini. Se è vero che siamo un ammasso di inesattezze, se è tutta una “approssimazione, imperfezione, imprecisione, improprietà, inaccuratezza, scorrettezza”, come dice il dizionario dei sinonimi (Treccani), se la vita non è che un inesauribile tentativo di fare fronte a queste insufficienze che spesso sono dettate dal contrasto con la memoria dei momenti felici, di quelle sospensioni in cui le cose stavano in pace e armonia, in cui la melodia del fiume scorreva placida nel suo letto, se è così allora la nostra forza non potrà che avere la modalità della resilienza, la valorizzazione di quello che la psicologa Anna Oliverio Ferraris sintetizza splendidamente come “un tratto della personalità composito, in cui convergono fattori di varia natura – cognitivi, emotivi, familiari, sociali, educativi, esperienziali, maturativi – che con la loro azione congiunta mobilitano le risorse dei singoli, dei gruppi e della comunità” (La forza d’animo, Rizzoli, 2003, p.7).









