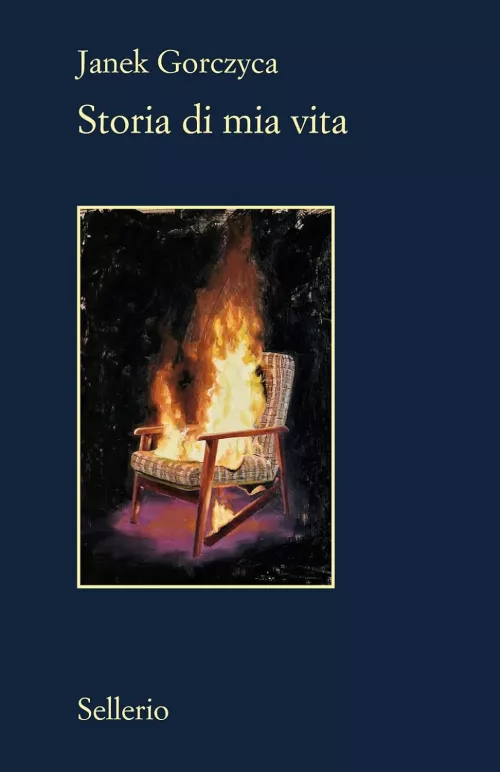Autobiografia di un clochard
Verso la fine degli anni Ottanta mi capitava spesso di passare da Campo de’ Fiori a Roma, e di vedere seduto sul gradino esterno della vineria (verso la statua di Giordano Bruno, per intenderci) un uomo, tutte le volte sempre lui, evidentemente molto ubriaco. Una volta lo guardai bene e riconobbi Gregory Corso. Fu una folgorazione: una delle vette della poesia americana lì, e io da solo davanti a lui. Provai una timidissima conversazione, ma le sue condizioni erano davvero disperate e tutto si concluse con una stretta di mano, un “grazie di tutto, Gregory!” da parte mia e un malinconico saluto. Lo rividi ancora, diciamo che lo tenevo d’occhio, ma a un certo punto scomparve (morì nel Minnesota nel 2001 e ora riposa al Cimitero degli Inglesi di Testaccio a Roma). In testa avevo la sua poesia, lo leggevo dagli anni Settanta, insieme a tutti gli altri Beat, e adesso avevo davanti la “macchia umana” (P. Roth) che l’aveva concepita, un piccolo fagotto ubriaco. Che dire: Gregory Corso non era un clochard, ma aveva vissuto in una sua no man’s land che gli aveva permesso – detto in breve – di scandagliare la nostra civiltà e farcela vedere nel suo volto più contorto (lo si rilegga oggi pensando agli USA alle prese con la più insidiosa delle campagne elettorali della Storia).
Qualche tempo fa mi è capitato di riflettere sulla figura del clochard (L’ala del clochard, 27 febbraio 2019) e osservavo (perdonate se mi ripeto) che quando l’individuo è desocializzato “si trasforma in una sorta di laboratorio nel quale si riproducono, su scala ridotta, le dinamiche di crisi soggettive e oggettive, è un uomo singolo che si pone in conflitto con l’intero sistema relazionale in cui è o è stato inserito. In questo senso il clochard riunisce i significati di crisi e di critica, come anticamente avveniva: egli è un punto di rottura, di crisi della società e nello stesso tempo, con il suo esserci, esprime su di essa un giudizio, una critica. Crisi e critica hanno un’origine comune (la radice greca krino) e il clochard sembra simboleggiarle appieno”. Così come Corso alzò il suo muro verso il mondo per penetrarlo e farcelo vedere, anche il clochard alza la sua barriera e, soffrendo veramente, denuncia il tutto. E, come Corso, a volte anche il clochard ne scrive.
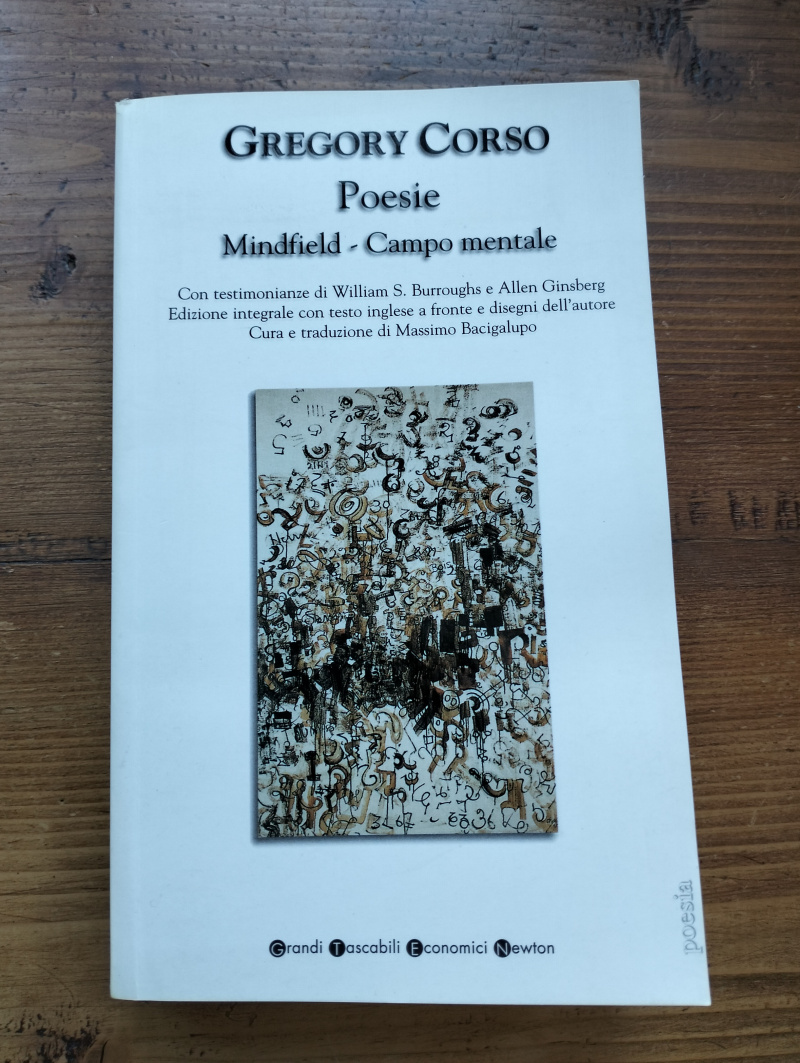
Credo che questa sia la chiave migliore che ci permette ora di leggere anche questa Storia di mia vita di Janek Gorczyca, appena pubblicato da Sellerio. È un libro la cui stessa esistenza è una preziosa rarità che testimonia molto efficacemente l’aspetto di cui dicevo rispetto all’azione duplice di crisi e di critica che un protagonista in prima persona ha avuto la forza (grazie anche all’incoraggiamento dello scrittore Christian Raimo) di realizzare.
Il polacco Janek Gorczyca (1962) vive a Roma “senza fissa dimora”, come si dice con un’espressione edulcorante, da oltre trent’anni. Nel presente che viviamo quotidianamente, una realtà in generale socialmente anche molto pesante, la vita di Janek è un deflagrare perpetuo, tra incontri pericolosi, rivalità incessanti alla ricerca di un lavoro, di un angolo riparato, ora in strada, ora in un edificio abbandonato, dove stare in pace con la sua Marta e il cane Mufi. Alcolismo endemico, gravi crolli depressivi, attimi di luce e poi ancora buio fitto. Come in Polonia all’epoca della rivolta al regime comunista o nei reparti speciali in Afghanistan, senza mai accettare di essere dominato dal potere. Al punto di scegliere, poco dopo la caduta del Muro, di andarsene per sempre, costi quel che costi.
La lingua con cui scrive è prima di tutto un dato “fisico”, una incarnazione del risultato prodotto nei lunghi anni di contatto con l’umanità altra che l’Italia gli ha offerto. La dimestichezza di Janek con le lingue lo ha certo facilitato, ma il risultato formale è notevole ed è tutto suo. La prosa è incalzante, nitida, le sbavature grammaticali o lessicali non sono mai un ostacolo, ma addirittura un arricchimento espressivo. Un esempio:
“Una mattina mi sveglio ma mio cagnolino Mufi non riesce a stare in piedi, lo porto da veterinario che conosco, diagnosi è tremenda, pochi giorni di vita, il cuore suo diventato di doppia grandezza, come quello di un cavallo. […] Vivo un momento molto triste, da una parte lavoro ce l’ho, ma viviamo per strada. Penso di nuovo di farla finita con la mia vita che già tentato due volte prima, una volta con benzina, altra con farmaci, ma sono sopravvissuto. […] Dopo faccio questo che devo fare, dottore mi chiede di uscire ma io rimango, così dopo la iniezione letale è morto fra le mie braccia. Marta aspetta fuori. Domando dottore, e adesso che sarà con suo corpo, lui risponde che sarà bruciato con altri cani, io non sono d’accordo, lo riprendo per seppellirlo, è dura ma mi sarà concesso un momento che non dimentico mai. Scavo la fossa in mezzo a alberi nel prato, lo metto dentro una coperta e così sta lì. Fino a ora solo Marta sa dove è” (p.138).

Sbagliato considerarlo un testo squisitamente letterario? È solo un lavoro documentario? L’ibridazione è la vera cifra di Storia di mia vita, è un uomo che si fa scrittore, che trasforma il patrimonio ricchissimo di esperienza della sua vita e lo disegna scegliendo l’espressività letteraria. Avrebbe potuto dipingere, o suonare, o danzare, o recitare. Se ne potrebbe discutere a lungo col rischio di fare di un’intensa esistenza oggettiva una insipida chiacchiera.
Ciò che domina nel libro di Gorczyca è la crisi e la critica, la fragilità estrema di un individuo che, nonostante inenarrabili fatiche e sofferenze, quasi non regge alla morte del suo cagnolino. E sono decine di migliaia di individui sparsi per le nostre città, clochard barboni senza tetto, chiamali come vuoi. Gente che testimonia materialmente la vita al suo confine, al di là delle “razionalità possibili” (le politiche sociali, l’economia bastarda, la solidarietà svanita…).
La realtà di un’umanità marginale, in realtà, è antica, non è un prodotto contemporaneo (si legga Charles Dickens per tutti), perché evidentemente c’è un lato oscuro di tipo psichico che genera la personalità off, e i comportamenti che ne derivano divengono oggettivamente “strutture di difficoltà”. Ma ciò che stride nel nostro mondo (lo dico in poche parole) è la contraddizione tra una potenzialità positiva pressoché infinita e la sua totale assenza nei confronti di questi individui. Una realtà oggi pienamente coerente con l’individuo come paradigma della società neoliberista. Di nuovo un homo homini lupus ma in un contesto globale in balia di populismi e potentati capaci di tutto.
Janek Gorczyca con Storia di mia vita, non fa che ricordarci i rischi di vivere perennemente sulla soglia, un luogo in cui l’unico imperativo è sopravvivere, ad ogni costo, perché, come dice il Suttree di Cormac McCarthy chiudendo il suo racconto di vita: “Da qualche parte nella foresta livida lungo il fiume è in agguato la cacciatrice, e tra i pennacchi di grano e nella moltitudine turrita delle città. Opera in ogni dove e i suoi cani non si stancano mai. Li ho visti in sogno, sbavanti e feroci cogli occhi pazzi di una fame vorace d’anime di questo mondo. Fuggili.”