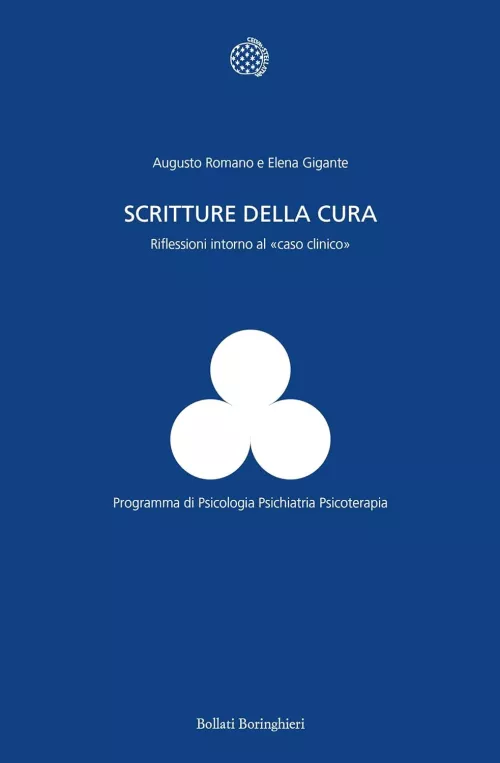Scritture psicoanalitiche, scritture letterarie
“Freud era un confratello. Anche se per caso avesse sbagliato tutto, era un confratello di alto livello. È dei nostri! Non tutti gli analisti sono dei nostri. Lui certamente sì” affermava il critico letterario Gianfranco Contini interrogato da Ludovica Ripa di Meana in Diligenza e voluttà. Lo studioso leggeva Freud “come scrittore, più che come portatore di un’eventuale verità”. Per l’intera esistenza il fondatore della psicoanalisi oscillerà tra il desiderio di riuscire a trattare la vita come un’opera d’arte e di affermare, nello stesso tempo, la scientificità delle sue scoperte. Freud scrittore di casi, che ogni volta cerca di adattare la strategia narrativa alla teoria, non si libererà di un’ambiguità irriducibile – “mi colpisce ancora come qualcosa di strano il fatto che le storie cliniche che scrivo si leggano come novelle” lamenta in Studi sull’isteria. Vocazione letteraria e vocazione medica continueranno a darsi battaglia, mentre ancora oggi la scrittura psicoanalitica si nutre dell’incontro con la letteratura.
L’intreccio tra le “scritture intorno alla cura – diari, referti, resoconti, narrazioni di storie cliniche redatte dai terapeuti e scritture favorite dalla cura – racconti, poesie, saggi prodotti dell’immaginazione e del pensiero dei pazienti” è la trama di un libro appassionante e complesso di Augusto Romano e Elena Gigante, Scrittura della cura. Riflessioni intorno al “caso clinico (Bollati Boringhieri, 2024). La difficile riproducibilità dell’incontro ritrova tutte le questioni poste da Freud: la sua impressione che le storie cliniche possano risultare ostiche nel passaggio dall’orale allo scritto, la sua sensazione che ci sia sempre qualcosa da aggiungere e da approfondire, il suo sforzo di riuscire a rendere la loro sovradeterminazione. La ricerca di un’estetica etica. La necessità, ogni volta e di nuovo, che il testo del caso clinico sia “assolutamente contemporaneo” pur nello scorrere del tempo cronologico che diventa tempo vissuto con i suoi fuori tempo del mondo interno e del mondo esterno (cfr. il saggio introduttivo Mario Lavagetto in S. Freud, Racconti analitici, Einaudi, 2011).
Il tentativo di rendere verosimile sulla pagina l’inafferrabile della vita può rappresentare uno stimolo per il confronto e la formazione – al termine del percorso la maggior parte delle scuole psicoanalitiche chiedono all’allievo la scrittura di un caso –, ma chiama anche a una riflessione sulla soggettività del terapeuta. Chi scrive, affermano i due autori, deve confrontarsi con parole chiave come “verità, paradosso, ineffabilità/intraducibilità, segreto, temporalità, forma, metodo, piacere, utilità”.
La particolarità di Scritture della cura è l’accostare a capitoli che ripercorrono le vicissitudini del romanzo analitico una seconda parte dove saranno Samuel Beckett e Didier Anzieu, Ernst Bernhard, Bobi Bazlen e Giorgio Manganelli a essere ricordati come casi clinici.
Un giovane medico, ancora in formazione come psicoanalista, prende in terapia un giovane scrittore afflitto, dopo la morte del padre, da una serie di disturbi somatici e psichici. Siamo nel 1934, la relazione tra Bion e Beckett durò meno di due anni, l’analisi non sembrò produrre risultati, ma il loro incontro si rivelerà nel tempo emblematico per entrambi. Aspettando Godot è stato infatti interpretato, anche, come il camuffamento della situazione analitica, la trilogia Memoria del futuro, che Bion definì “una narrazione fantastica della psicoanalisi”, letta a voce alta sembra una pièce del teatro dell’assurdo.
Nel 1993 lo psicoanalista Didier Anzieu pubblica un libro intitolato Beckett che si presenta come un resoconto clinico. Ma “un resoconto clinico di quale terapia?” si chiede Augusto Romano: lo stesso Anzieu dice di aver letto e riletto i libri del drammaturgo in cui si ritrova in un “sistema di pensiero negativo generalizzato”, mentre rivela un coinvolgimento che sfocia nell’identificazione quando definisce Beckett “come un fratello nella sofferenza, come un mio fratello abbandonato, in attesa di qualcuno che forse potrei essere io”. Il progetto contenuto nei loro libri, scrive Anzieu, “il progetto più costante, più insistente” è ‘il progetto di non morire’”.
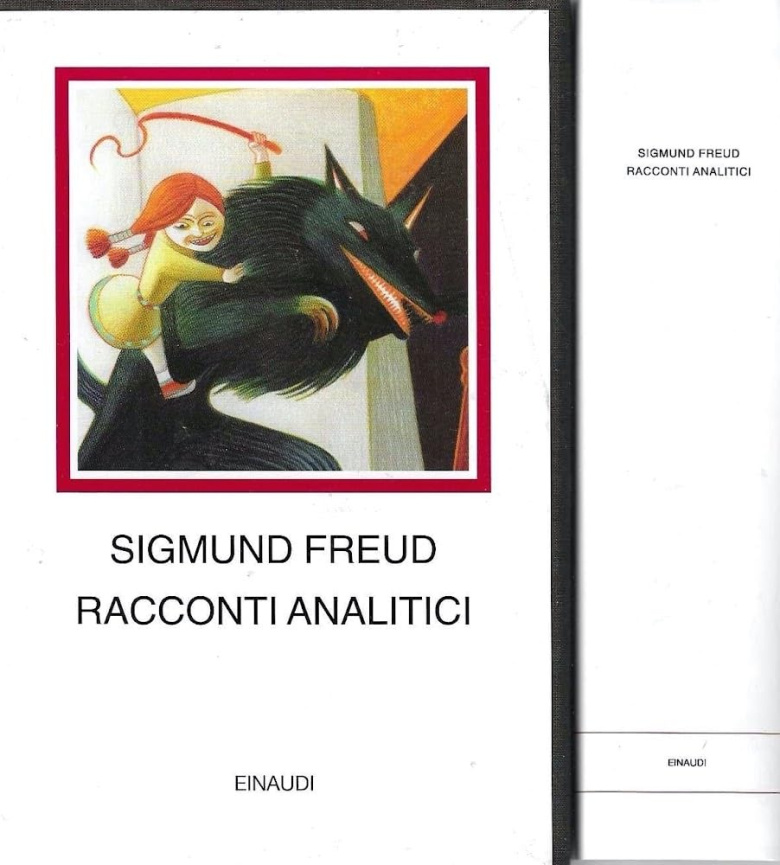
Anzieu e Beckett e in parte anche Bion, trasportato a nove anni dall’India a Londra e lasciato in un collegio, hanno avuto delle madri “terribili”. La madre di Beckett, rigida, svalutante e anaffettiva, la madre di Anzieu, internata in manicomio, è nota nella storia della psichiatria come il caso Aimée. Nei confronti di Beckett Anzieu esprime un sentimento di gemellarità, però anche il testo Il gemello immaginario (1950), nel quale Bion sottolinea l’importanza che assumono per il funzionamento mentale le percezioni sensoriali e l’intensità emozionale generata dal corpo, sembra attingere alle impressioni delle ore passate con Beckett.
Ma ecco un altro colpo di scena! Nell’autunno del 1935 Jung era stato invitato alla Clinica Tavistock di Londra, Bion partecipa e invita Beckett ad accompagnarlo alla terza delle cinque conferenze. Bion porrà diverse domande a Jung, che in quell’occasione aveva parlato della grande utilità di riuscire a trasformare le emozioni in immagini – il “metodo”, come oggi testimonia il Libro Rosso, con il quale ha salvato sé stesso. Le considerazioni di Jung influenzeranno il processo creativo di entrambi (cfr. Jung: un mistero alla Tavistock in Mauro Manica, Maria Grazia Oldoini, Fearful Symmetry. Spaventose simmetrie. Psicoanalisi e stati primitivi/creativi della mente, Celid, 2018).
La cura eccede sempre le forme della narrazione, la guarigione può essere inseguita trasformando il dolore, creando nuove visioni. Così Anzieu conclude: “Non finire, prima del tempo, di vivere, di pensare, di immaginare, di creare. Aiutare gli altri ad avere una vita compiuta. (…) Sposare il maschile e il femminile nella mente, l’immobilità e il movimento nel corpo. Tollerare l’angoscia e la gioia, l’odio e il riso. Mantenere l’amore nell’intervallo tra l’abbandono all’altro e l’abbandono dell’altro. (…) negare, tagliare, staccarsi, trasgredire per progredire. Avvolgere, spiegare, dispiegare, svolgere, avvolgersi, incastrarsi, per esistere, per coesistere. Per dare indefinitamente alla nostra umana finitezza una forma mai definitiva”.
L’altro “caso” di cui si occupa Augusto Romano in Scrittura della cura è quello di Bobi Bazlen (1902-1965). Per avvicinarsi alla sua vicenda umana evoca la figura mitologica del puer aeternus. Chi lo ha conosciuto, e i tanti che ne hanno scritto, sottolineano la sua eccentricità e imprendibilità, il suo essere misterioso e paradossale, originale e mercuriale. “Nella sua forma estrema, il puer appare come l’eternamente giovane e l’eternamente esule; privo di contenimento, incapace di farsi da padre, ai suoi occhi il mondo è sempre sul punto di risolversi nell’ultraterreno”.
L’analisi con Ernst Bernhard durata dal 1944 al 1950 – “L’unico arnese concettuale necessario per ogni psicoterapia: palude e sacrificio” dirà Bazlen –, ha guidato e ispirato il suo percorso interiore. In fuga da Trieste, in fuga dall’amore “terrificante” della madre, per Augusto Romano Bazlen appartiene a una “nuova generazione di viandanti, meno attraente, meno seducente di quelli romantici”. Il romanzo incompiuto Il capitano di lungo corso, iniziato durante l’analisi, testimonianza di una mitobiografia, “nel quadro delle opere che affrontano la crisi del soggetto nella tarda modernità, ci sembra – come i romanzi della Finis Austriae che Bazlen così bene conosceva – rispecchiare quella crisi piuttosto che tentarne un superamento”.
Bernhard e Bazlen sono affratellati da un senso di non appartenenza, si avvertono lontani dal senso comune della collettività – rifugiato in Italia in fuga dal nazismo Bernhard “esce in questa vita da tutte le comunità”. Quattro giorni prima di morire sogna di “entrare in una specie di teatro, dove vengono distribuite diverse parti. A lui viene assegnata la parte che deve rappresentare, di non rappresentare cioè alcuna parte”.
Ernst Bernhard, che si diceva incapace di scrivere, è stato però un formidabile stimolatore di scrittura per chi arrivava nel suo studio assillato da dilemmi e angosce legate alla creatività. E qui incontriamo l’ultimo “caso” nel capitolo che Elena Gigante dedica a Giorgio Manganelli. “Sull’orlo della disperazione, senza speranza di vivere, né di morire, aveva conosciuto Ernst Bernhard, il quale l’aveva aiutato ad attraversare le ombre dell’inconscio. Per qualche anno, aveva vissuto con loro (…). L’analisi aveva risvegliato, in lui, lo scrittore nascosto; la letteratura l’aveva salvato dalla disperazione” racconta a Pietro Citati quando gli porta il libro Hilarotragoedia (in Giorgio Manganelli, Il vescovo e il ciarlatano. Inconscio e letteratura: l’incontro con Ernst Bernhard, a cura di Emanuele Trevi e con una conversazione di Giorgio Manganelli con Caterina Cardona, Sellerio, 2024).
Lo scrittore riesce a trovare la “sua” malattia, a sostituirla a quella sbagliata, le immagini interiori diventano un orientamento, permettono l’incontro dell’individuale e del cosmico in una tessitura dove ritrovare e incontrare una moltiplicazione di vite.
Perché “chi dice la verità ha una sola vita, chi mente ha tutte le vite che vuole”.