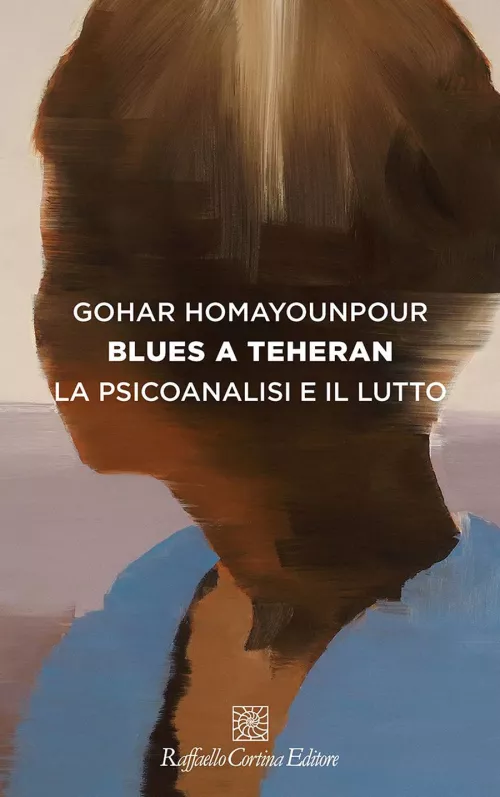Shahrazād canta il blues
Frammenti incompiuti, aneddoti brevi, riflessioni teoriche, letteratura e poesia. Le improvvisazioni procedono per associazioni libere, la clinica poetica della psicoanalista Gohar Homayounpour piroetta al ritmo del blues. “Il blues è un genere legato alla depressione, al turbamento, alla sventura, al tradimento e alle sue ferite, al dolore e al rimpianto. Però guai a dimenticare che il blues è anche musica da ballo, un ballo scatenato che inneggia al piacere, al trasporto, all’umorismo e alla vita”.
In Blues a Teheran. La psicoanalisi e il lutto, (Raffaello Cortina, 2024), il “doppio sguardo” di iraniana cittadina di molti mondi e la sua formazione poliglotta permettono all’autrice la spontaneità di un discorso aperto, di una riflessione teorica originale. Nelle interviste non vuole parlare dell’attualità, non vuole essere ridotta a espressione critica della situazione politica di un regime repressivo, crudele e spietato soprattutto nei confronti della popolazione femminile, proprio perché le donne sono da anni l’avanguardia delle proteste contro il regime islamico. Si fa guidare dalla bella espressione di Adam Phillips di “tirannia dello scopo”: l’illusione di sapere che cosa si vuole davvero va interrogata per sfuggire alla tirannia del consumismo, ma anche allo schematismo ideologico che vorrebbe restringere l’immagine della donna iraniana a vittima, oppure a una caricatura dell’erotismo orientalista.
Non solo il dolore è tale dappertutto, ma anche la tragedia di Edipo è, per Gorah Homayounpour, un copione che può funzionare a tutte le latitudini. La rilettura culturale del mito la porta alla figura di Shahrazād, l’archetipo della donna persiana, a tipi femminili del tutto scomparsi nelle rappresentazioni mainstream in Iran, che non parlano di amore, di donne che amano le donne, di donne che stanno sia con uomini che sia con donne, di donne che hanno l’amante ma non vogliono sposarsi.
“Presentare le donne iraniane come vittime significa adottare un’ottica riduzionista che ignora moltissime donne lavoratrici, donne che negli ultimi decenni sono state il volto della resistenza politica, donne che si sono prese cura delle loro famiglie in situazioni di migrazione, donne che hanno rifiutato di piegarsi alle leggi opprimenti che le cingono d’assedio, giovani donne perlopiù laureate. Quella visione riduzionista impedisce anche di vedere le donne castranti (e quindi uomini ‘evirati’) che popolano certe famiglie iraniane”.
A partire da queste considerazioni Gohar Homayounpour sviluppa l’idea di una variante specifica del complesso d’Edipo. La sua lunga esperienza clinica la porta a concludere che, per molte ragazze iraniane, il grande oggetto d’amore rimane la madre. Generazioni di donne iraniane hanno vissuto un rapporto fusionale con la madre, che a sua volta era in simbiosi con la propria: la genealogia femminile è un collante fin troppo tenace. Per reazione, per difendersi da questo abbraccio materno che vuole le figlie tutte per sé, si va alla guerra tra donne, verso un territorio di morte attraversato da invidia, odio, aggressività. In questo spazio claustrofobico e chiuso non è facile far entrare un terzo, una funzione paterna/maschile. Anche perché questi uomini, accuditi dalle madri, snobbati dalle mogli e dai figli, si rifugiano in uno stato inerziale, oppure sfogano in modo violento una frustrazione infinita.
Goran Homayounpour chiama “complesso di Shahrazād” questa ribellione alla legge del padre in una società retta dal diritto patriarcale. Ritornare all’archetipo di Shahrazād, andare alla sua ricerca, significa far risorgere le sue figlie, ritornare a narrare anche tutto ciò che fa ancora paura nelle Mille e una notte.

Nata a Parigi da genitori iraniani – suo padre ha tradotto in farsi i testi di Kundera e nel libro sono riprodotte le cartoline che si sono scambiati –, scopre per la prima volta Teheran da ragazzina. Poi ha vissuto in Canada e negli Stati Uniti, Boston è la città della sua formazione psicoanalitica, ma fa una scelta controcorrente e si trasferisce a Teheran. La sua esperienza di poliglotta nomade nutre un punto di vista critico su cosa capita quando un flusso si inverte. In Iran – che nel 1979 ha accolto tre milioni di afghani in fuga dalla guerra sovietica –, dopo le sanzioni imposte dal 2018 dagli Stati Uniti la situazione economica è così peggiorata che ora migliaia di afghani cercano di rientrare nel loro paese. L’autrice propone una prospettiva diversa da quella stereotipata del senso comune populista, secondo la quale gli arrivi sono sempre troppi, e la chiama “Migrazione a rovescio”. Quando accade agli esseri umani è “un indizio incontrovertibile: nulla prova in maniera più lampante che un paese o una città non sono più quelli di una volta. Se una persona mi lascia, analogamente, non posso non provare un sentimento di angoscia, perché vuol dire che anch’io mi sono esaurita, che non sono più quella di prima. Per questo l’abbandono disorienta”. Quando arrivano gli altri diciamo che ci tolgono possibilità, ma quando se ne vanno? È la prova che noi siamo esauriti, che non abbiamo più risorse, mentre finché vogliono venire da noi significa che siamo vivi e vegeti. Vitali.
Docente di psicologia e psicoanalista, membro dell’International Psychoanalytical Association, e in Italia della SPI, Gohar Homayounpour ha fondato nel 2007 il Freudian Group di Teheran. Un’associazione non riconosciuta né autorizzata dal governo, impossibilitata a rilasciare diplomi e certificati, tuttavia in affanno per le numerosissime richieste di adesione.
Proprio in un contesto dove pare impossibile eludere nella stanza d’analisi il discorso sociopolitico, “l’aspetto più grandioso della mia condizione di psicoanalista a Teheran è che posso fare psicoanalisi nella sua forma originaria, sovversiva, rivoluzionaria” – come possedere un terzo occhio, un terzo orecchio. Perché “la lingua dell’inconscio è la lingua del margine” che permette di intuire significati in un garbuglio di frasi smozzicate che emergono in una situazione di paura.
Nel suo testo precedente, Una psicoanalista a Teheran (Raffaello Cortina, 2013), anche questo censurato, raccontava che in Iran le era più facile identificarsi con ogni cosa e ogni persona, con una fatica emotiva molto maggiore in tutte le situazioni e così anche con i pazienti. “Mi sono ritrovata incapace di rifiutare una scatola di dolci che mi aveva portato un’anziana paziente. Inoltre, qui mi sento molto più a disagio nel parlare della mia parcella o quando invito i pazienti a prendere posto sul lettino o devo dire loro che il tempo della seduta è giunto a termine”.
Vista da Teheran, la psicoanalisi le appare passata da un eccesso di frustrazione – una sorta di “prova” somministrata a ogni paziente – a un eccesso di cura. Il terapeuta, come certe “madri coccodrillo”, è oggi troppo preoccupato di lasciar cadere l’altro, come se questo fosse un neonato inerme, convinto di dover curare più con la sua presenza che con il suo pensiero. Una clinica dell’accudimento: i terapeuti stessi non riescono a credere nella necessità di una postura più paterna, meno claustrofilica, più indirizzata all’apertura all’esterno.
“Eppure (ma forse qui è in gioco una critica più generale della psicoanalisi contemporanea) ho l’impressione che tendiamo a dimenticare il contributo inestimabile dell’‘assenza’ allo sviluppo di una mente sana; a dimenticare che l’ansia da separazione riguarda spesso l’eccessiva vicinanza all’oggetto, dal quale temiamo di venire inghiottiti, il desiderio di allontanarci dall’oggetto, accompagnato dal terrore della sua potenziale vendicatività nel momento in cui quel desiderio venisse a manifestarsi”.
La psicoanalisi si è fatta melanconica in una realtà condivisa con l’oggetto materno, dove il pensiero, la realtà del tempo e dello spazio risentono di una mancanza di interesse per il contesto collettivo.
All’inizio del libro Gohar Homayounpour riparte da Lutto e melanconia di Freud, anche nel ricordo di un lutto personale: lo strazio delle lacrime sul pavimento di un bagno quando viene raggiunta dalla notizia che il padre era morto mentre nuotava nel lago di Ginevra.
Ecco ancora il blu persiano che tiene lontano il malocchio, il blues che non erotizza ma trasforma la tristezza.