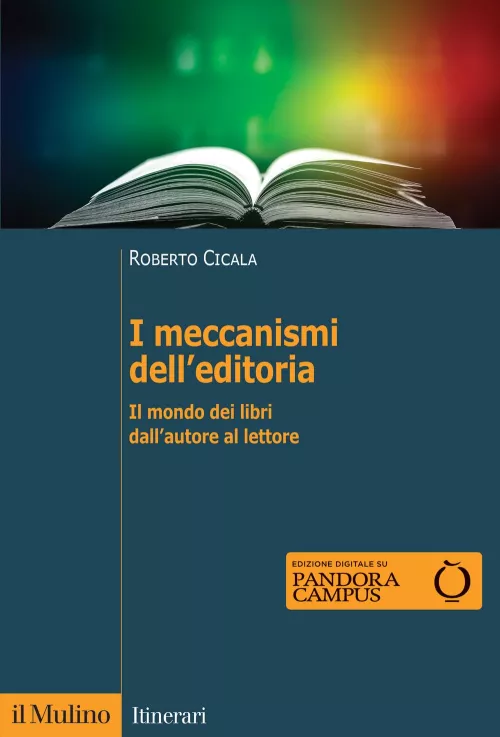Viaggio nell’Italia degli editori
I libri che Roberto Cicala dedica all’editoria hanno un pregio che ogni libro dovrebbe avere: sono estremamente leggibili. Quasi a interpretare come scrittore i suggerimenti che lui stesso darebbe come editore, combinano perfettamente i suoi tre mestieri: il didatta, l’autore e l’editore. I due libri di cui parlo, Andare per i luoghi dell’editoria, Il Mulino, pp.194, € 14) e I meccanismi dell’editoria (di cui esce adesso la seconda edizione, Il Mulino pp. 292, € 24) sono stati ospitati da un altro editore, com’è consuetudine tra gli autori che lavorano nell’editoria. Roberto Cicala è infatti prima di tutto l’editore di Interlinea, che da più di trent’anni propone libri di ottima qualità. Nel catalogo della sua casa editrice ci sono spesso riproposte, ma ci sono anche proposte intelligenti di testi altrimenti difficilmente reperibili di autori come Alessandro Manzoni o Alda Merini, c’è tanto Matteo Boiardo, qualche autore Interlinea contemporaneo piuttosto noto come Gianluca Favetto.
Andare per i luoghi dell’editoria è un viaggio attraverso l’Italia degli editori e mostra una mappa della vita culturale dell’Italia che è importante comprendere per capire anche come è fatto il nostro paese. L’aspetto industriale della produzione di libri è infatti una buona mappatura della nostra vita culturale, ed è piuttosto imprevedibile, persino più idiosincratico degli autori. Si vede bene proprio dalla vita editoriale quella che Sidney Tarrow aveva definito la mancata centralizzazione dell’Italia, che a differenza di Francia e Inghilterra, non si è legata in modo univoco alle proprie capitali ma ha visto piuttosto la propria vitalità svilupparsi nei tanti territori diversi che dialogano e confliggono tra loro, spesso saltando del tutto la capitale. A volte le case editrici sono nate per genuini dissensi culturali e politici, come è il caso di Feltrinelli che, soprattutto con il Dottor Zivago rifiutato dalla Einaudi allora molto egemonizzata da un PCI fortemente filosovietico, aveva lasciato uno spazio molto ampio a sinistra che l’editore milanese seppe intuire e riempire. La vicenda, raccontata anche più dettagliatamente da Carlo Feltrinelli in Senior Service (Feltrinelli, 1999 pp. 592), è all’origine anche di tanta storia italiana che dal dissenso di Feltrinelli vedrà nascere e finanziarsi molta sinistra extraparlamentare italiana e alla fine, com’è noto, anche parte della lotta armata. Altro dissenso culturale dall’Einaudi nasce con il caso di Adelphi, questa volta a proposito dell’edizione di Nietzsche curata da Giorgio Colli. Altre volte le case editrici nascono da un brillante imprenditore, altre da casi fortunati, altre ancora da tradizioni locali. Cicala racconta alcuni tra i protagonisti del dopoguerra ancora attivi seguendo un itinerario attraverso tutta la penisola dando ragione di un sapere che viene prodotto ovunque in Italia dove se ci sono luoghi che hanno maggior peso, se lo hanno, sono piuttosto Milano o Torino, certo non Roma. Alberto Arbasino ricordava come anche nella storia letteraria, fatta eccezione per le Cronache del Villani, la storia della nostra letteratura aveva una mappa che saltava Roma, dalla Toscana di Dante, Petrarca e Boccaccio (a loro volta autori itineranti, sono letteralmente esuli) alle corti secentesche della pianura padana, ai risorgimentali dell’ottocento. Certo il Cinema ha attratto molti autori a Roma, ma in fondo anche nella letteratura del dopoguerra hanno più rilievo tante periferie (dalla Trieste di Magris a Piemonte e Liguria di Pavese, Fenoglio, Calvino e Montale) fino alla Sicilia di Sciascia. Morante, Moravia e l’ultimo Pasolini hanno portato in primo piano la vita editoriale a Roma, ma anche per loro si tratta di una stagione che non ha creato un centro come invece è certamente accaduto per l’industria cinematografica.
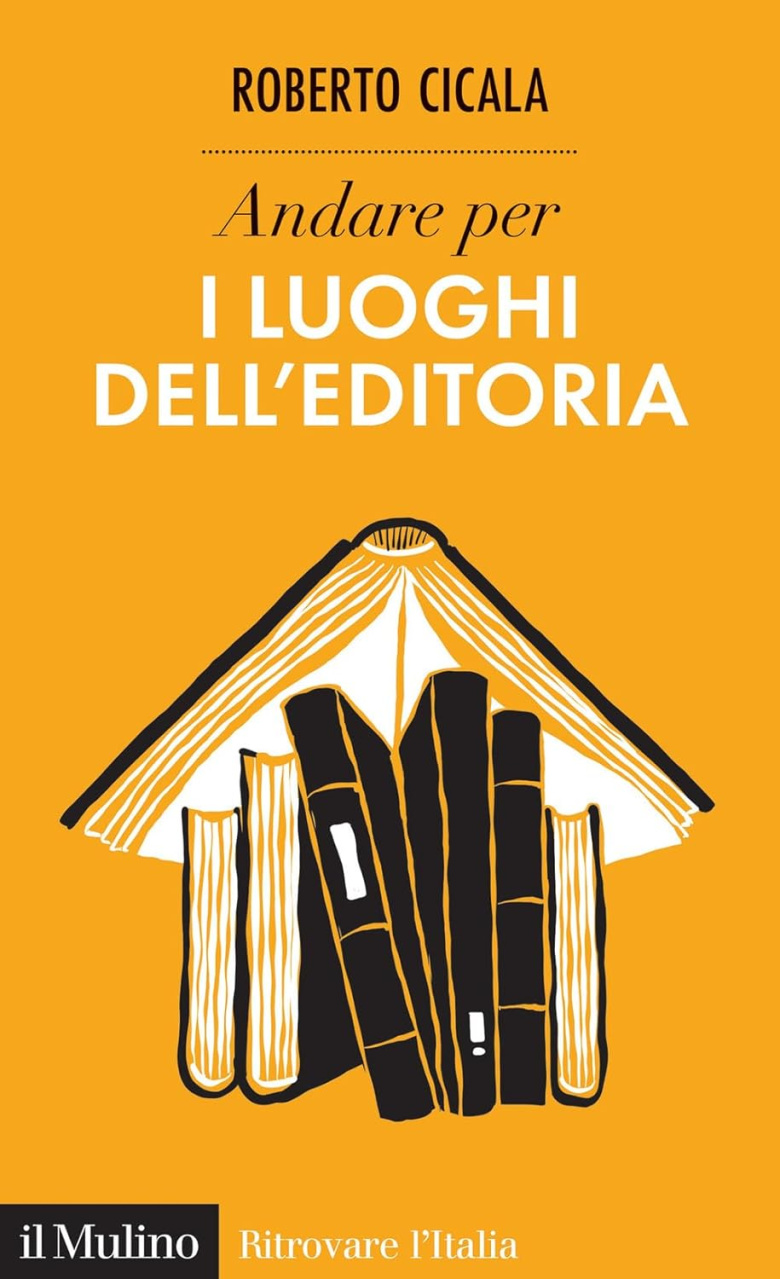
A Venezia Cicala ha anche l’occasione di una escursione erudita nella vicenda editoriale di Aldo Manunzio (inventore dei primi tascabili!) e nel suo rapporto con Erasmo, pagine che naturalmente meriterebbero approfondimenti che però porterebbero il viaggio attraverso gli editori di Cicala in un’altra direzione. Così agli occasionali excursus storici vengono preferiti i chilometri, gli accenni alle storie di importanti protagonisti in Sicilia, nelle Marche, a Firenze, insomma un po’ in tutta Italia. Dal suo viaggio viene fuori un aspetto piuttosto simpatico del far libri, qualcosa di artigianale cui resta legata la cultura italiana, che individua spesso un nuovo spazio per fare una proposta nel tessuto così poco omogeneo della nostra vita comune, e che quindi nasce naturalmente dai margini dei discorsi egemonici.
I meccanismi dell’editoria è invece un volume più tecnico e manualistico, per quanto la frequente inserzione di aneddoti in pagine che sono esempi di quello che si è spiegato, ne rendono comunque agile la lettura. Così al discorso sul mestiere dello scrittore si affianca un excursus sugli incipit di Cesare Pavese, e da lì si riesce anche a dire qualcosa sulla pratica dello scrivere. Quando si parla della figura relativamente recente dell’agente letterario, un rapido ritratto biografico di Eric Linder concretizza il ruolo di molti attori intorno alla produzione dei libri, e così via, per ogni dettaglio dei meccanismi dell’editoria, questi esempi di umani che ricoprono quel ruolo, rendono la lettura più affabile e scorrevole. La materia è familiare agli addetti ai lavori ma ha il pregio di offrire a chi i libri li legge e basta una buona idea di come vengono fatti.
Nonostante i costanti lamenti di tutti gli editori da quando esiste la carta stampata, l’industria editoriale è tutt’ora la più grande, più grande sia del cinema che della musica. E persino i fallimenti e i pericoli che corre da sempre, come nel caso della nascita degli Oscar Mondadori che rilevano un settore in difficoltà della vecchia Einaudi (prima ovviamente di comprarsela tutta in epoca berlusconiana) sono occasione di sviluppi industriali. Il ritratto che viene fuori di questo mondo molto ampio e complicato, mostra quante persone sono coinvolte nella produzione di ogni libro. Cicala è molto rispettoso della libertà degli autori e di come le loro difficoltà sono spesso importanti per far nascere libri originali, che vale la pena pubblicare. A me pare più consapevole lui di quanto non siano spesso gli autori, che vorrebbero in un editore lo stampatore, salvo poi naturalmente preferire un editore allo stamparsi in proprio che naturalmente è sempre possibile.
Per chi abita in un mondo dove ci sono molti libri (e va ricordato che un italiano su due non compra neppure un libro all’anno), la lettura di Cicala è davvero istruttiva. Credo che derivi dall’insegnamento che Cicala fa alla Cattolica di Milano e all’università di Pavia, dove dirige un Master in Editoria, e da questo mestiere deriva anche la chiarezza espositiva. Sapere quanti sono quelli che lavorano nel mondo che produce le nostre idee non può che aumentare il rispetto per i tanti che contribuiscono a darci i libri che leggiamo e le idee di cui parliamo.