Le sculture cinematografiche di Steve McQueen
Il film Grenfell (2019) di Steve McQueen è un memoriale in piano sequenza. L’artista e filmmaker britannico ha ripreso da un elicottero la Grenfell Tower, un grattacielo di 24 piani ubicato nel quartiere di North Kensington a Londra, devastato da un incendio nella notte del 14 giugno 2017. Lo ha fatto nel mese di dicembre dello stesso anno, prima che un rivestimento protettivo potesse nascondere la prova di un crimine (ufficialmente per evitare di provocare ulteriori traumi psicologici alla comunità). Il film, dedicato alle 72 vittime e ai sopravvissuti, è una testimonianza delle scellerate scelte economiche e politiche che hanno causato il disastro e al tempo stesso un gesto amorevole di pietà. Dopo un periodo in cui la visione era stata riservata alle famiglie in lutto e ai sopravvissuti, Grenfell è stato presentato nel 2023 alla Serpentine South di Londra.

L’emozione suscitata dal film era visibile nell’espressione degli spettatori al termine delle proiezioni, che hanno avuto luogo dal 7 aprile al 10 maggio. In seguito una copia del film è stata donata alla Tate e un’altra al Museum of London. Per due anni l’opera non è stata esposta, ma ora è tornata ad essere nuovamente visibile in sei città del Regno Unito: Glasgow (Tramway, 8-23 marzo 2025), Cardiff (Chapter, 10 maggio – 15 giugno 2025), Belfast (The MAC, 17 luglio – 21 settembre 2025), Plymouth (The Box, 2026, in date da destinarsi), Liverpool (Tate Liverpool 2026-27, in date da destinarsi), Birmingham (Midland Arts Centre, 2027, in date da destinarsi).
(National tour of Grenfell by Steve McQueen)
McQueen ha chiesto espressamente ai media di non divulgare immagini della torre, soprattutto quelle della notte del disastro, per rispettare la sensibilità dei familiari delle vittime e dei sopravvissuti, con i quali ha dialogato in momenti diversi degli ultimi sette anni. Le immagini messe a disposizione per la stampa sono tre: un frame del film in cui si vede da lontano il quartiere di North Kensington, la stessa inquadratura in proiezione nella sala e un ritratto dell’artista.
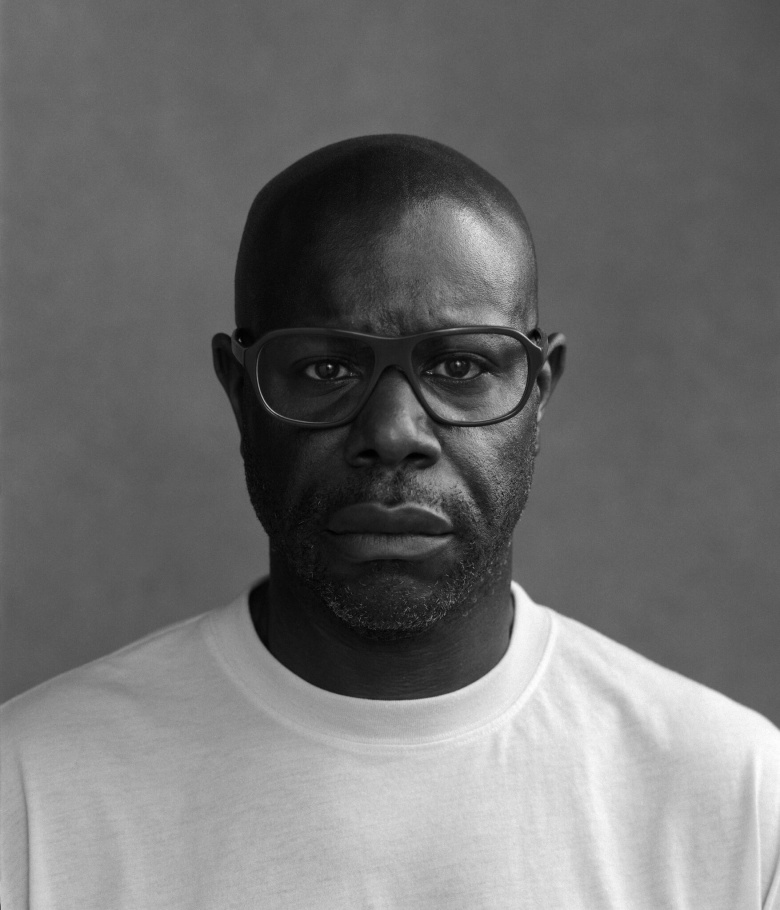
La visione dell’opera è un rituale commemorativo. Nel saggio pubblicato per l’occasione, lo storico e sociologo britannico Paul Gilroy lo definisce un «monumento alla perdita».
Il film, girato interamente in piano sequenza, è una veduta panoramica di Londra che sposta lentamente il punto di vista dai sobborghi al quartiere di North Kensington dove si erge l’edificio, un titanico monumento all’efferatezza di un capitalismo rapace. L’improvvisa interruzione dell’audio nell’istante in cui inizia la rotazione della camera intorno alla torre accentua il senso colossale di devastazione. La rotazione guida lo sguardo in una lettura a tutto tondo dell’edificio, come è stato per la Statua della Libertà nel film Static, girato dallo stesso McQueen nel 2009.
Il moto rotatorio è anche quello che caratterizza il modo in cui guardiamo una scultura a tutto tondo.
La ricerca di McQueen spazia tra scultura, fotografia e cinema. La proiezione dei suoi film e dei suoi video negli spazi espositivi assume una forma installativa, che scavalca quella cinematografica. Nelle gallerie d’arte e nei musei le sue opere occupano lo spazio, ma è nel tempo, nel susseguirsi di immagini e suoni che manifestano pienamente la loro forza espressiva. A questo riguardo si può notare una relazione con il susseguirsi delle vedute che appaiono una dopo l’altra allo spettatore orbitante attorno a una scultura a tutto tondo. Così appare anche la torre combusta, con la differenza che ad orbitare non siamo noi ma la camera che la riprende. Grenfell è una scultura cinematografica che ha un rapporto con l’esperienza dello spazio attraverso il volgere del tempo.

Alla sua famosa distinzione tra arti del tempo e arti dello spazio Gotthold Ephraim Lessing apporta una correzione: «Tuttavia tutti i corpi non esistono solamente nello spazio, ma anche nel tempo […]», specificando che il loro momentaneo apparire è l’effetto di un’azione antecedente e al tempo stesso cagione di una susseguente (Laocoonte o sia dei limiti della pittura e della poesia [1766], Aesthetica, Palermo 1991, p. 71).
Agostino d’Ippona ha dedicato un passo folgorante del De Musica a questo volgere nel tempo: «non si possono discriminare e perfino percepire neanche le figure visibili, rotonde o quadre o di altro volume o figura, se non si osservano attentamente con la vista. Mentre infatti si guarda da una parte, se sfugge ciò che è stato osservato in un’altra, viene reso vano il guardare di chi li esamina perché anche esso si verifica in un periodo di tempo» (VI.8.21). Il passo è simmetrico al famoso «Nell’ascoltare la sillaba più breve, se non ci soccorre la memoria in modo che nell’attimo, in cui se ne ode non più l’inizio ma la fine, rimanga nell’anima la modificazione prodotta quando si è udito il suo inizio, non si può dire di aver udito qualche cosa» (VI.8.21). La simmetria dei due passi salta subito all’occhio. Mentre quello riferito all’ascolto poetico e musicale è stato oggetto di numerosi studi, il «periodo di tempo» in cui lo sguardo esamina le «figure visibili» non ha avuto la stessa fortuna critica. In Confessioni (XI.28.38) troviamo un passo complementare, che chiarisce come la percezione di una configurazione visiva o acustica abbia bisogno del protrarsi dell’azione sia nella memoria di ciò che si è visto o ascoltato, sia nell’aspettativa di ciò che si vedrà o ascolterà.
Non possiamo infatti percepire l’intera configurazione di una scultura a tutto tondo se nell’istante in cui osserviamo una veduta non richiamiamo alla mente il ricordo di quella vista poco prima nell’aspettativa della successiva. La rotazione dello sguardo intorno alla torre converte il film in una scultura monumentale a tutto tondo, cosa peraltro suggerita dalla stessa struttura monolitica dell’edificio che sovrasta il quartiere come una stele colossale in rovina.
Al pari delle steli funebri conficcate nella terra, Grenfell è un segno posto a memoria di ciò che in quel luogo è accaduto, è cioè tomba e memoriale, anche se non affonda la sua base sottoterra dove scricchiolano le ossa dei morti. La scultura segna il luogo, ma in un’epoca in cui i luoghi sacri non esistono più (il sacro è qui inteso nel senso antropologico e sociologico proposto da Emile Durkheim) la scultura giunge a incorporare e custodire in sé il luogo stesso in forma di opera portatile (Paola Mola, Scultura e Antiscultura alle Origini del Novecento, Accademia Belle Arti Macerata, 1994). Sposando l’esperienza del sacro alla critica sociale, Grenfell incorpora il luogo e lo porta in tour nel Regno Unito per rafforzare la coscienza collettiva.
Allo stesso scopo è stata creata la Grenfell Foundation, una piattaforma attraverso la quale la comunità dei sopravvissuti e delle famiglie in lutto mantiene viva la memoria, chiede giustizia e si confronta per decidere il futuro del sito.
Grenfell è «monumento alla perdita», ma anche una veduta dotata di un punto di vista dall’alto, che si sposta dai sobborghi della città al quartiere dove si erge la torre. La Veduta dall’alto è un genere che si è radicato nella nostra cultura visuale, come suggerisce una testimonianza dello stesso artista salito sulla torre nei primi anni ’90 in visita ad amici: «mi ricordo il panorama dalla finestra e di aver pensato di non essere mai stato così in alto prima di allora. Il punto di vista era stupefacente». Invertendo il punto di vista dall’alto della torre abitata dai suoi amici, alla camera che riprende dall’alto la torre devastata dall’incendio, McQueen converte lo stupore in compassione richiamando la τειχοσκοπία teichoskopìa, la veduta dall’alto delle mura di Troia descritta da Omero nell’Iliade. Dalle mura Elena assiste al duello tra Paride e Menelao e dalle stesse mura Ecuba e Priamo assistono alla morte del loro figlio Ettore, il cui cadavere è straziato da Achille: «Gemeva da far pietà il padre caro, e il popolo intorno era in preda al singhiozzo e ai lamenti per la città» (XXII, 405). Il dolore di Priamo, di Ecuba e del «popolo intorno» riverbera su quello di McQueen mentre orbita intorno alla torre.
Secondo Gilroy la rotazione della camera comunica con forza l’esperienza traumatica provocata dal tragico evento: «Il movimento vertiginoso dell'orbitare quel punto fisso produce nausea man mano che gli spettatori vengono trascinati nella spirale. Ci muoviamo ancora più vicino e la geometria animata dell'edificio spezzato confonde la percezione» (Never again Grenfell, p. 11). La «geometria animata» trascina lo spettatore in un gorgo, ma al tempo stesso lo allontana. In Grenfell non c’è solo pathos, c’è anche distacco.
Gli spettatori potranno notare che nelle riprese ravvicinate McQueen mantiene l’asse ottico della camera perpendicolare alla verticale della torre, anche se il movimento dell’elicottero rende fluttuante questa perpendicolarità. Di conseguenza le verticali tendono ad essere più o meno parallele anziché convergere e divergere tra loro in modo prospettico. Nella fotografia di architettura questo effetto, che modifica la distorsione prospettica, si ottiene con il decentramento verticale, una funzione del banco ottico. Questa correzione restituisce all'immagine fotografica dell'edificio una parziale ortogonalità, che è tipica del prospetto architettonico. Se la prospettiva privilegia l’osservatore che guarda da un determinato punto di vista, la proiezione ortografica privilegia l’oggetto visto da un punto di vista posto all’infinito. McQueen si cala nel luogo del disastro adottando un punto di vista accidentale o a volo d’uccello, che è necessariamente prospettico e quindi soggettivo, ma cerca al tempo stesso di oggettivare ciò che sta guardando assumendo così una posizione critica e analitica. La ricerca di una frontalità dell’oggetto architettonico testimonia lo sforzo di oggettivazione, senza per questo perdere il punto di vista del soggetto, quello prospettico, che è sempre carico di istanze affettive.
Grenfell è una tomba e un memoriale che tocca il cuore attraverso l'automatismo di sguardi stratificati nella nostra cultura visuale. L’artista ha eretto un formidabile monumento alla tragedia del 14 giugno intrecciando linguaggi diversi. Il film è una veduta che si trasforma in scultura all’ammutolirsi dei suoni. È anche un ascolto musicale attraverso il silenzio (per chi abbia in mente i passi di Agostino e li metta a raffronto). Grenfell è soprattutto un luogo portatile e al tempo stesso una denuncia sociale di forte impatto emotivo, un’opera d’arte formidabile e complessa.
In copertina, Steve McQueen, Grenfell, 2019 (still). Courtesy dell’artista.









