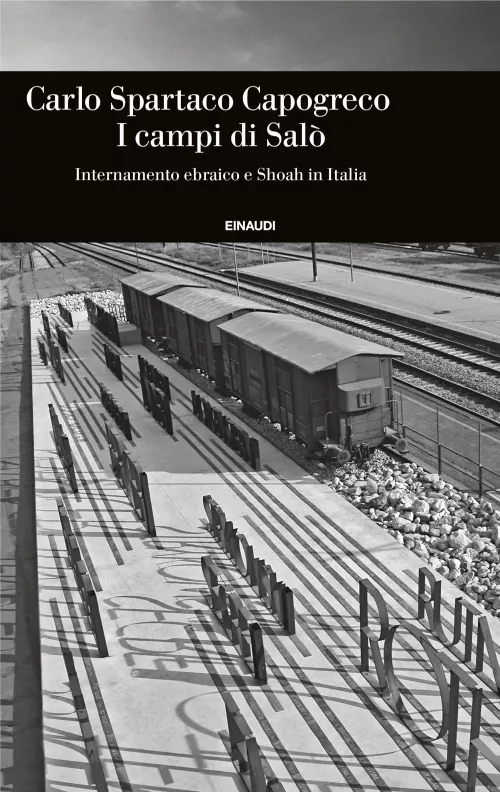Prigionieri di Salò
Nel panorama di studi sul fascismo, il razzismo e l’antisemitismo, l’opera di Carlo Spartaco Capogreco occupa un capitolo a sé. Intanto per il suo singolare, anomalo percorso di studio. Medico pediatra, ha lavorato a lungo in Toscana, a un certo punto della vita ha gettato il camice alle ortiche e si è costruito una nuova vita ritornando alle radici della sua terra, la Calabria. Qui oggi insegna storia contemporanea all’Università di Cosenza. Si deve a questa brusca virata esistenziale il suo libro, quello su Ferramonti di Tarsia (1987), che fu per tutti, in anni in cui si parlava assai poco di queste cose, una piccola-grande scoperta: l’esistenza del più grande campo d’internamento istituito da Mussolini. Capogreco appartiene a quella piccola compagnia di storici «scalzi», che lavorano su temi scomodi, nuotando contro corrente. Si deve a lui un secondo libro coraggioso dedicato al partigiano calabrese Dante Castellucci (Facio), protagonista di un caso di mala giustizi partigiana, condannato a morte con imputazioni ridicole e fucilato forse proprio per conseguenza delle sue origini meridionali. Nel 2004 con Einaudi ha pubblicato I campi del Duce. L’internamento civile nell’Italia fascista (tr. inglese 2019), da considerare la parte I di un’opera di cui il recente volume, sempre per i tipi Einaudi, I campi di Salò. Internamento ebraico e Shoah in Italia, rappresenta la conclusione. Si conclude una ricerca dunque durata più di un ventennio, al riparo dai palcoscenici, in lunghi soggiorni presso archivi maggiori e minimi dispersi in tutta Italia.
Battitore libero, nemico delle sintesi affrettate, instancabile ricercatore di archivio, Capogreco è degno allievo del mai abbastanza compianto storico berlinese Klaus Voigt, che per primo ha messo in luce il problema degli ebrei stranieri nell’Italia fascista, a sua volta scopritore di un’altra piccola-grande storia dimenticata, quella di Villa Emma a Nonantola. Capogreco ha esplorato i faldoni di ogni angolo d’Italia, lo fa da anni, con instancabile energia. Si può dire che questo che presentiamo sia il frutto maturo di un’intera esistenza.
Come sarà recepito il suo lavoro da una storiografia che invece negli ultimi tre decenni e forse più ha preferito la scorciatoia della sintesi o fabbricato tesi talora geometriche, ma poco corrispondenti al vero, è difficile dire. Gli storici «scalzi» in Italia non godono spesso di buona stampa. Tanto più è difficile immaginare il destino di una ricerca come questa in un momento in cui la Shoah, per via del 7 ottobre, rischia di far riprecipitare i nostri discorsi all’epoca lontana in cui Capogreco in via solitaria riscopriva la realtà sconosciuta di Ferramonti, in mezzo a una generale indifferenza.
Il libro mette a fuoco una vicenda fra le più intricate della storia d’Italia e il suo merito precipuo consiste proprio nel non proporci una spiegazione unilaterale. Questo secondo volume, come già il primo, non rientra in schemi pregiudiziali e potrà dispiacere sia a chi vuole attenuare la responsabilità persecutoria del regime, sia a chi vuole appiattire le decisioni di Salò su quelle dell’alleato nazista senza fare distinzioni.

La prima parte del volume è pensata come «un veloce ripasso» delle vicende accadute in Italia fra il 1938 e il 1943: questi capitoli dialogano a viso aperto con tutte le tendenze della più recente storiografia, in modo forse un po’ troppo scolastico, non mai acrimonioso, si restituisce a ciascuno il suo, senza parteggiare per questa tesi o quell’altra, finanche nel caso estremo di riconoscere giusti meriti anche a chi ha gettato le prime basi della ricerca contemporanea, Renzo De Felice. Ne emerge un quadro a chiaroscuri, equilibrato e pacato nei toni. A lettura ultimata si conferma l’idea di una generale impreparazione da parte delle autorità, almeno nel primo periodo, ciò che renderà più agevole la sottomissione all’egemonia tedesca. Forse la parola giusta da adoperare è «sottovalutazione». Come prima del 1938, la burocrazia, le questure e le prefetture sottovalutarono la situazione originata dall’estesa presenza di ebrei stranieri nella penisola, che risaliva ai primi anni Trenta. Così, dopo l’8 settembre 1943, le stesse prefetture, gli stessi organismi locali si trovarono ad affrontare da soli una questione più grande di quanto non immaginassero. Né da Salò si dava l’impressione che la politica di sterminio avviata da Hitler, già nota a Mussolini, fosse una priorità. Che Mussolini non gradisse che nel territorio della «sua» repubblica fossero rastrellati cittadini ebrei italiani pare chiaro leggendo il libro, ma altrettanto chiaro è che nulla si intendesse fare per opporsi. Né proteste, né consenso esplicito, questa la conclusione di Capogreco, che giustamente rileva la contraddizione di una escalation resa in origine tale da «una semplice disposizione amministrativa»: l’ordinanza di polizia numero 5 di Buffarini Guidi del 1° dicembre 1943, secondo la quale tutti gli ebrei dovevano essere chiusi in campi di concentramento e i loro beni sequestrati.
Di queste strutture, che Capogreco definisce «interinali», ovvero campi provinciali (solo Fossoli fu denominato «campo speciale»), il libro offre una minuziosissima mappa, provincia per provincia, in forma di singole voci enciclopediche: ciascuna ha la sua bibliografica, l’indicazione delle fonti archivistiche consultate. Un volume da consultare, prima che da leggere.
In apertura una carta disegnata dallo stesso autore consente di toccare con mano la capillarità di una strategia per attuare la quale Salò non avvertì l’esigenza di promulgare una apposita legge, ma si affidò a una decisione presa in un’assemblea chiassosa svoltasi a Verona, priva di potere decisionale (non fosse altro che per l’assenza dello stesso Mussolini, osserva Capogreco). Se ne ricava l’impressione che tutto fosse lasciato all’arbitrio o alla buona volontà delle autorità locali (fintanto che fu possibile, cioè fino a quando la sottomissione all’alleato tedesco non fu più procrastinabile). Una strategia che ha i caratteri del cinismo, prima che della brutalità fisica. Istituire ex novo richiedeva energie e quattrini che non si intendeva spendere. La confisca dei beni degli ebrei, viceversa, sollevava cupi appetiti e mise a nudo il lato oscuro della vicenda: la brama di denaro, la corruzione, la tragedia delle delazioni, vera nota distintiva della Shoah in Italia.
Per quanto concerne invece la gestione dei campi provinciali la mappa rivela una varietà di atteggiamenti, da cui si evince, come si diceva, la non comprensione del problema. Si pensava lo si potesse affrontare come se la situazione fosse la stessa del periodo 1938-1940. Stesse normative, stesse circolari di prima come se il paese non fosse ormai preda della volontà sterminatrice delle SS. I campi, ci spiega l’autore sorsero in zone distanti dai grandi centri urbani, talvolta ospitarono una decina di persone o poco più. Tali erano i campi di Asti, Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), Vercelli, Aosta, Calvari di Chiavari (Genova), Vallecrosia (Imperia), Bergeggi (Savona), Mantova, Sondrio, Venezia, Verona, Tonezza del Cimone (Vicenza), Vò (Padova), Monticelli (Parma), Reggio Emilia, Ferrara, Forlì, Bagni di Lucca, Marina di Massa (Apuania), Roccatederighi (Grosseto), Senigallia (Ancona) e Perugia.
Nelle principali città furono le carceri a ospitare le persone arrestate. Si utilizzarono strutture preesistenti in trenta delle prefetture sottoposte al controllo della RSI: caserme, ex campi sorti per internati civili. In certi casi – quando furono utilizzate ville, scuole, caserme dismesse, colonie marine o montane – non mancarono episodi di facili evasioni. In altri casi l’approccio era decisamente «blando» (preoccupazione per gli anziani, per le donne, ricerca di soluzioni per l’approvvigionamento del cibo, dei medicinali, del tabacco: una circolare era sempre disponibile per ciascuna di queste evenienze). In altri luoghi il sistema repressivo fu duro. Colpisce la quantità di campi in zone marginali, luoghi minori o minimi, che solo grazie all’acribia dell’autore è ora possibile localizzare sul territorio.
L’esplorazione compiuta da Capogreco viene utile anche agli studiosi di Primo Levi, per le notizie che ci vengono fornite su Aosta, a proposito della caserma in disuso intitolata a Giuseppe Mottino (membro della Milizia confinaria caduto a Adua). Qui dove erano reclusi 35 ebrei, non furono portati gli ebrei di Amay, arrestati per delazione (Vanda Maestro, Luciana Nissim, Aldo Piacenza, lo stesso Levi), per i quali fu disposto l’interrogatorio nella caserma Battisti (come sanno i lettori del Sistema periodico). Nella sua ricerca Capogreco ha scoperto che al momento dell’arresto di Levi, la Mottino era inutilizzabile a causa di un furto da parte di ignoti. Questa difformità nelle date, e nei luoghi dell’interrogatorio, permette all’autore di fissare con certezza il giorno in cui Primo, Luciana e Vanda partirono da Aosta e giunsero a Fossoli: il 20 gennaio 1944. Con loro erano nel convoglio sei ebrei jugoslavi arrestati a Caluso e quattro ebrei italiani arrestati a Vico Canavese e Quincinetto.