C’è bellezza nello star qui
“Oltre la curva della strada” scrive Alberto Caeiro (quindi Fernando Pessoa) nella poesia “Oltre” (Para além), “forse c’è un pozzo, e forse un castello, / forse solo la continuazione della strada. / Non so né domando. / Finché vado nella strada prima della curva / guardo solo la strada prima della curva […] / A nulla servirebbe star a guardare l’altro lato / e quello che non vedo. / Ci interessano soltanto i luoghi ove ci troviamo. / C’è abbastanza bellezza nello star qui […]”. È questa bellezza dello star qui, che per un essere umano moderno vuol dire stare nella città, che troviamo nelle pagine di Camminare e fermarsi, dell’artista e architetto Francesco Careri (Mimesis 2025). Una bellezza, tuttavia, che può stare qui, sul posto, perché questo stesso posto è attraversato come se fosse un luogo sconosciuto ed estraneo. Ecco allora la forza di quella congiunzione che tiene insieme il movimento più semplice che ci sia, il camminare, e quindi lo spostamento e l’irrequietezza, con il fermarsi, ossia con lo stare la sosta e, in fondo, la contemplazione. L’altrove è qui, è questo il pensiero, in realtà il gesto specifico, di Careri, che non lo cerca – come fa invece chi ha poca immaginazione, e pensa di trovarlo nel Sahara o in qualche sperduta isola del pacifico – piuttosto vede e pratica il qui come un altrove. Si tratta del gesto elementare, forse l’unico gesto ‘ecologico’ nel tempo dell’antropocene, che trasforma il consueto nell’inquietante, e l’estraneo in familiare. Un gesto che trasforma la città in un accampamento nomade, ma anche, ed è l’aspetto meno scontato, ogni accampamento nomade una sorta di città stabile. Si tratta, in sostanza, di rendere mobile ciò che è rigido, e irrigidire, in qualche mondo, ciò che sembra essere solo momentaneo e volatile.
Il luogo esemplare di questa operazione – che è allo stesso tempo estetica, cioè corporea, e politica, perché la trasforma in modo radicale – è la città, perché gli umani, come ci ricorda Aristotele, sono animali cittadini. Di questa celebre definizione aristotelica viene sempre messo in rilievo il fatto che l’umano sarebbe naturalmente politico, cioè appunto cittadino, dimenticando la prima parte, che l’umano è un animale. In questo senso il gesto di Careri – e del collettivo di artisti e architetti Stalker attivo a Roma dal 1995, con cui la sua vicenda artistica è strettamente intrecciata – è un modo per ri-animalizzare l’umano, che invece non fa che dimenticare il suo essere un vivente come tutti gli altri viventi, un vivente la cui Umwelt è la città. Vivere la città come una gazzella vive la savana, uno storno il cielo, una sardina il mare. In questo modo la città torna ad essere uno spazio incantato e pieno di sorprese, un campo virtuale di azioni e scoperte, conflitti e temporanee pacificazioni. Per questo il gesto di Careri è un gesto, prima di tutto, politico, perché ne mostra l’aspetto vitale, e quindi incontrollabile, che il pensarla invece solo come uno spazio funzionale – così come la pensano gli urbanisti, gli architetti, e chi non riesce a non vederla che dal punto di vista delle forze dell’ordine – la impoverisce fino a sterilizzarla. Camminare e fermarsi diventano così i due momenti – anche se in realtà sono le due fasi di uno stesso gesto elementare – che permettono di abitare nuovamente la città, che smette così di essere un luogo soltanto amministrativo, che di nuovo si popola di presenze estranee umane, a partire dai migranti che non smettono di arrivare, e inumane, gli animali che sempre di più ne affollano gli spazi così come piante e alberi cosiddetti ‘alieni’ (una definizione che non è propriamente biologica, bensì poliziesca). Si tratta allora di un libro che “tenta di superare lo statico dualismo tra nomade e sedentario, fornendo un ritmo dinamico al camminare e al fermarsi […] allo spazio dell’andare e a quello dello stare. Si guarda al fermarsi non come una resa all’insediarsi sedentario né come accettazione delle sue regole e delle sue frontiere, ma come azione di responsabilità, di presa in cura e di progetto trasformativo verso i territori attraversati e con le genti che li abitano. Si narra di pause nel camminare nomade tra spazi sedentari e nel camminare sedentario tra spazi nomadi” (p. 7).
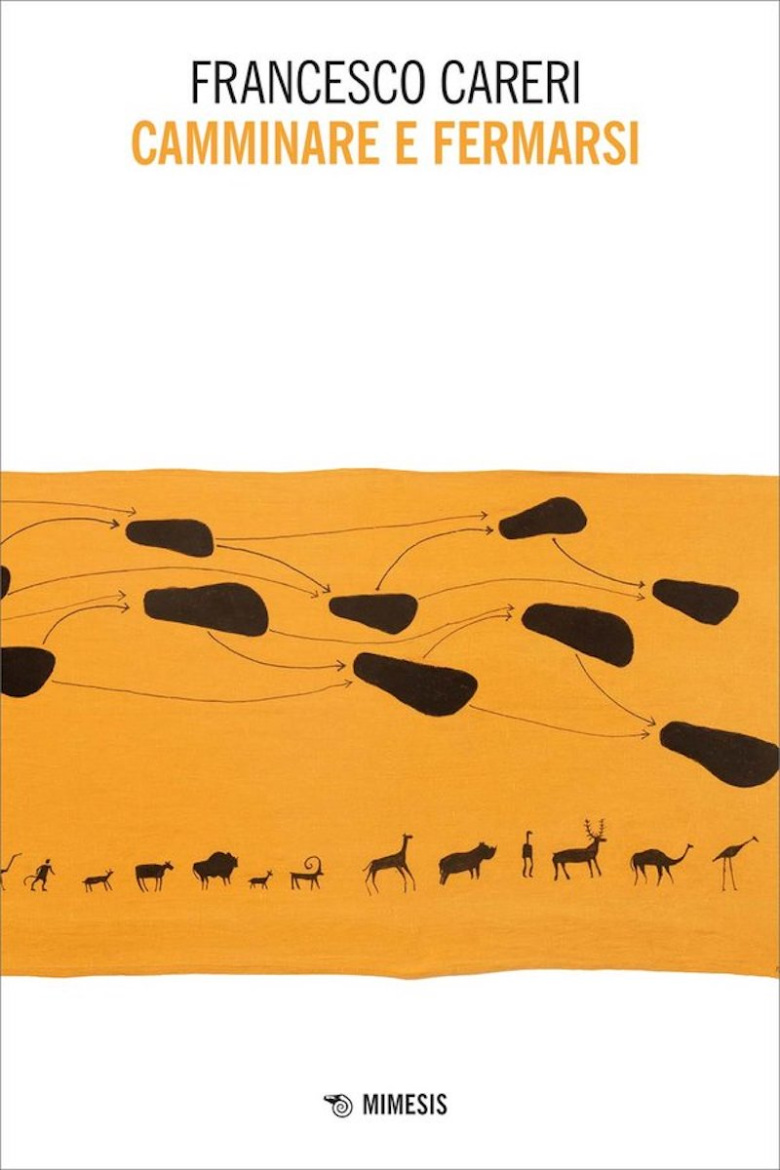
C’è quindi un “camminare nomade” che è però inseparabile da un “camminare sedentario”. Si cammina, cioè non si sta fermi, il corpo si sposta, tuttavia questo stesso camminare coincide con il nostro modo di abitare il mondo, vagando per i suoi spazi con la leggerezza del viandante. Intesa in questo modo la città non si può più definire, come peraltro non riusciamo proprio a non fare, come un luogo destinato esclusivamente agli umani, soprattutto la città diventa una specie di esperimento permanente, ché ogni volta che la camminiamo in realtà ci rendiamo disponibili all’incontro e alla sorpresa. Il ‘metodo’ di Careri, infatti, non consiste in altro, in fondo, che in questa radicale apertura alla sperimentazione itinerante: “nelle lezioni itineranti” – scrive nel capitolo “Arti civiche”, che dà il titolo al corso che tiene all’Università Roma3, “si cammina in modo strabico, verso una meta e verso ciò che distoglie dalla meta: è un perdersi consapevole sulla base dei concetti situazionisti di dérive e di psychogéographie. Disponendosi agli incidenti di percorso, ai dirottamenti, alla possibilità di inciampare e di sbagliare strada deliberatamente. Giocare con il caso e l’imprevisto è infatti l’unico modo per prendere la città di sorpresa, in modo indiretto, laterale, ludico, non funzionale, di ritrovarsi in territori inesplorati dove nascono nuovi interrogativi. L’esplorazione non ha tanto bisogno di luoghi da raggiungere, quanto di tempo da perdere, tempo non funzionale, tempo di ricreazione ludico-costruttiva” (p. 83). Il camminare di Careri non è quello, puramente geometrico e automatico, da un punto A ad un punto B, al contrario, è esporsi alla contingenza del mondo, perché, come ci ricordava Alberto Caeiro, “c’è abbastanza bellezza nello star qui”; una bellezza che può essere bella proprio perché non ci aspettavamo di incontrarla, mentre invece ce l’aspettavamo là e invece era già qui (in realtà la bellezza è sempre stata qui, dovevamo cominciare a vedere casa nostra come la vede un nomade per riuscire a coglierla). Una bellezza che ci sorprende; in effetti la bellezza, come le belve, ci prende sempre alle spalle, o non è bellezza. Una bellezza che non è bella se per noi la bellezza è quella dei musei o delle esposizioni d’arte, è piuttosto la bellezza di quei luoghi che il collettivo Stalker chiama “spazi attuali”, ossia “quegli spazi abbandonati” che costituiscono “un territorio fertile, un’amnesia urbana dove sognare un nuovo rapporto tra arte, natura e metropoli. Ci attiravano in quanto zone di ibridazione tra urbano e selvatico, erano interstizi rimasti vuoti tra i quartieri, terrains vagues in attesa di essere compresi, sperimentare nuove forme di creatività” (p. 14). L’espressione “territorio attuale” è particolarmente riuscita, perché ci ricorda che questi luoghi non sono luoghi potenziali, ossia spazi che devono essere riempiti ad esempio da un progetto urbanistico, come se si trattasse di luoghi incompleti, da ‘recuperare’ alle attività umane: al contrario, ogni “territorio attuale” è appunto attuale, ossia contiene già in sé tutto ciò di cui ha bisogno, cioè è già vivo. Quello che uno spazio attuale ci chiede non è di pensarlo come nient’altro che una superficie in attesa di un uso (‘qui sorgerà un palazzo, là ci sarà una strada, e accanto un parco’), al contrario, ci chiede di partecipare – ecco il camminare e il sostare – della sua vita, ci chiede di vivere con esso, o meglio ancora, di lasciarci vivere da quel luogo. Il mondo non è in attesa dell’intervento dell’Homo faber; c’è vita, nel mondo, una vita che possiamo onorare semplicemente camminandola.

Ma questo vuol dire che il camminare, ossia il farsi nomadi nella città, trasforma chi cammina in uno straniero, e lo straniero porta sempre scompiglio. Allo stesso tempo il nomade non fa che incontrare, nel suo erratico camminare, altri stranieri che non si aspettavano di incontrarlo, e forse non avevano proprio nessuna intenzione di incontrare. Può essere pericoloso camminare, perché lo straniero è tanto più malvisto quanto più il suo arrivo è atteso, perché porta sempre con sé la sorpresa, e che cos’è la vita se non una continua sorpresa; e così “l’arrivo dell’ospite è l’inizio di una festa” (181). Non bisogna dimenticare, tuttavia, il doppio senso della festa, perché c’è quella appunto festosa, ma c’è anche quella del fare una festa a qualcuno. Torna l’ambivalenza del movimento vitale, che intanto è produttivo in quanto è potenzialmente pericoloso: in effetti la vita è pericolosa semplicemente perché è viva, come scopriamo nel capitolo “Stazioni nomadi”, ad esempio, dove Careri ci porta nella stazione abbandonata di Farneto (a 500 metri dall’ingresso Nord dello Stadio Olimpico), un territorio attuale “in cui l’umano percepisce il suo intorno per mezzo del pericolo, del panico, in quello stato di apprensione che permette al viaggio di essere il luogo dell’esperienza nomade, l’attraversamento dell’inconosciuto” (p. 63). È questo il senso di questo camminare che è un fermarsi e questo fermarsi che non smette di essere, nello stesso tempo, un camminare, attraversare “l’inconosciuto”. Un attraversamento che non vuole propriamente conoscerlo, al contrario, vuole sperimentare questa non conoscenza, vuole abitare questa estraneità. Ecco allora, infine, che “è l’abbandono, termine solitamente usato con la sola accezione negativa, che ha prodotto, e continua incessantemente a produrre, universi sfuggiti al progetto e che costituiscono oggi gli spazi più interessanti della città. È in questi spazi che natura e artificio si fondono nel tentativo di ricreare spontaneamente una ibrida wilderness fatta di foglie e di ruggine, di campi infestati dai rovi e skyline metropolitani” (p. 63). Riuscire a cogliere una bellezza di “foglie e ruggine”, appunto perché non dobbiamo mai dimenticare che “c’è abbastanza bellezza nello star qui”.









