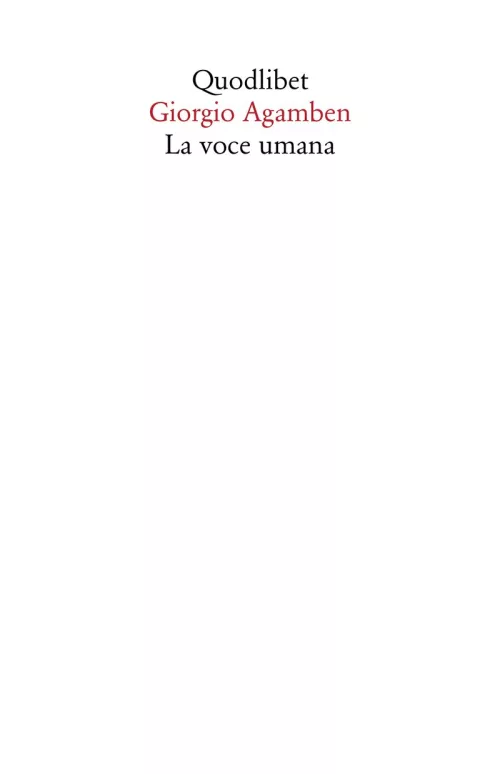Agamben, incarnare la voce
Ce l’abbiamo sempre in bocca, per questo non ce ne accorgiamo. Se non quando inavvertitamente (forse) la mordiamo, e allora ci rendiamo conto della sua presenza costante, così la ‘lingua’ si manifesta. Non è un caso che per Freud l’inconscio si mostri attraverso il lapsus, quando cioè la lingua dice per conto suo, e dalle labbra esce una parola che non era nelle nostre intenzioni coscienti pronunciare. In questo caso è la lingua che parla (ça parle, “esso parla” diceva Lacan). La lingua parla, comunque. Il fatto da rimarcare, e il lapsus non smette di ricordarcelo, è che la lingua è abitata da una potenza espressiva e di pensiero, una potenza tanto più potente quanto meno, ovviamente, ci accorgiamo della sua potenza. Perché appunto la lingua parla, e pensa, per conto proprio. Sempre Freud diceva che la psicoanalisi, in fondo, non consiste in altro che nel permettersi di fare questa scoperta, che la lingua parla, e che quindi in noi ‘abita’ una forza che ci sfugge completamente.
È questo il problema posto dal linguaggio, questa macchina impersonale che ‘genera’ discorsi e ragionamenti e che affolla i nostri pensieri, una macchina che ci ostiniamo a credere non sia altro che uno strumento a ‘nostra’ disposizione, un mezzo per esprimere le ‘nostre’ idee, come ripetono ottusamente i manuali di comunicazione. Una macchina, il linguaggio, che non scorgiamo, proprio come non ci accorgiamo della lingua che ingombra la nostra bocca. In effetti la filosofia comincia, può cominciare, solo quando mettiamo a tema questa presenza che affolla le menti e le azioni. Perché, una volta fatta la scoperta straniante del lapsus, chi ci assicura che sia un caso eccezionale? Come facciamo ad essere certi che, a parte appunto l’emergere improvviso del lapsus, nel resto del tempo siamo proprio ‘noi’ che decidiamo di dire quello che ‘vogliamo’ dire? Chi è, propriamente, che parla quando la lingua parla? Ma se è la lingua che parla pensa decide, quand’è che, al contrario, sono ‘io’ invece a parlare e pensare? Ci si accorge allora che la questione del linguaggio non è marginale, riservata agli specialisti (gli psicoanalisti e i linguisti), al contrario, è la questione principale, perché nel linguaggio, nella lingua che (si) parla, ne va di quella che chiamiamo, molto presuntuosamente, la libertà. Come scrive Spinoza nell’Ethica, “sbagliano gli uomini nel credere di essere liberi, e quest’opinione si fonda unicamente sul fatto che sono consapevoli delle proprie azioni, e ignari delle cause da cui sono determinati” (proposizione XXXV, seconda parte, “La mente”). Se il pensiero che precede la decisione è a sua volta già pensato e deciso altrove (ça parle), in che senso posso dirmi effettivamente libero?
Torniamo così a quella lingua, che è allo stesso tempo un pezzo di carne è un astratto dispositivo del pensiero. È nella lingua, allora, e nella voce che si può articolare solo grazie a quella stessa lingua, che si stabilisce il misterioso incontro fra il corpo e il pensiero, fra la materia animale e lo spirito disembodied del ragionamento e del linguaggio. È di questo rapporto, mai del tutto risolto (e come potrebbe, perché com’è possibile far stare insieme in modo non conflittuale il massimo della soggettività incarnata di un muscolo con il massimo della intersoggettività impersonale di una lingua?), che si occupa La voce umana (Quodlibet, 2023), di Giorgio Agamben. Un libro in cui confluiscono tanto le sue recenti ricerche sulla poesia cosiddetta dialettale (attraverso la collana Ardilut di poesia bilingue, che cura per Quodlibet), quanto il suo lavoro filosofico più antico, quello inaugurato già in Stanze e Il linguaggio e la morte. La posta in gioco è quella formulata con disarmante chiarezza da Spinoza: se il vivente umano è ‘libero’ di agire – posso scegliere questa o quell’altra azione – ma è all’oscuro dei motivi per cui sceglie un’azione anziché un’altra, allora il tema diventa: com’è possibile, per il vivente che solo attraverso la lingua può accedere alla lingua (e quindi al pensiero), potersi dire libero? Più in particolare, si tratta di immaginare un modo attraverso cui la lingua, cioè il corpo individuale, possa in qualche modo ‘liberarsi’ dalla potenza normalizzatrice della lingua, la lingua sistematizzata e uniformata dalle grammatiche. Per questo il tema del libro è quello della voce, una voce che comunque è una voce che non può non passate anche per il linguaggio, ma allo stesso tempo è una voce affatto personale e unica.
La voce umana che cerca Agamben è la voce ‘liberata’ da tutti quei dispositivi di potere che sono inseparabili dal linguaggio. Si pensi alla questione così dibattuta, e spesso un po’ fumosa, della biopolitica, cioè i tanti e pervasivi dispositivi di potere – statali, economici, burocratici, polizieschi – che controllano il corpo. Il primo, e fondamentale, di questi dispositivi è il linguaggio, che per poter funzionare deve inglobare al suo interno il corpo umano per assoggettarlo alla astratta norma grammaticale (quando si parla di grammatica subito si parla anche di politica). Il mezzo attraverso cui la lingua ‘animale’ del piccolo umano viene assorbita e trasformata dal linguaggio è la scrittura (Agamben si rifà alle ultime lezioni al Collège de France di Émile Benveniste dedicate al rapporto fra lingua e scrittura), che non si limita affatto a semplicemente trasformare i suoni in lettere, piuttosto a trasformare l’espressione ‘naturale’ in un flusso organizzato e controllato – reso medio e ‘comunicativo’, ossia innocuo – di pensieri e discorsi: “ciò significa […] che il problema della voce – in quanto in esso è in questione la definizione della natura umana – è un problema essenzialmente politico, in cui ne va ogni volta della decisione di ciò che è umano e di ciò che non lo è. La nascita della biopolitica – l’assunzione della vita umana come compito politico – coincide col tentativo della moderna scienza del linguaggio di fissare e definire l’articolazione tra voce e linguaggio” (p. 60). Sono tre, allora, in termini della questione: il corpo ‘naturale’, il linguaggio in quanto dispositivo biopolitico, il possibile corpo capace di conservare una voce affatto personale (una voce poetica). Da notare che questa voce, com’è appunto il caso di quella poetica, non è affatto spontanea e naturale. La voce poetica è un artificio, ognuno deve lavorare per la propria voce, ossia deve liberarla dagli imperativi del public speaking e della comunicazione efficace:
“Poiché l’operatore di questa inclusione esclusiva è il gràmma, possiamo dire che la grammatica, cioè la riflessione sulle lettere in quanto componenti minime della voce, è la disciplina fondamentale dell’Occidente e per questo essa si insegna ai bambini, cioè a coloro che devono accedere alla lingua e possono farlo veramente solo se prima imparano a ‘leggere’, cioè a riconoscere le lettere che sono state iscritte nella voce.

Se questa operazione di esclusione inclusiva della voce ha una funzione fondatrice, ciò è perché la posta che in essa è in gioco non è soltanto quella di assicurare la connessione significante fra parole, concetti e cose; si tratta, prima ancora, situando il linguaggio nella voce, di costituire la relazione fra il vivente e la lingua, fra la natura e la cultura. L’articolazione della voce attraverso le lettere definisce il varco in cui si attua questo passaggio, in cui l’edificio convenzionale del linguaggio, che si trasmette esosomaticamente e storicamente, trova il suo nesso originale con la voce naturale. La grammatica sta a fondamento della cultura occidentale non soltanto perché garantisce la coerenza significante della lingua, ma anche e innanzitutto perché custodisce la soglia fra la natura e la cultura, quel trascorrere o quell’articolarsi della phōnē` nel lògos, in cui ha luogo l’antropogenesi, il diventar umano del vivente uomo. Nella grammatica è, cioè, in questione la natura umana. Ed è la soglia che essa articola e custodisce che si tratta ora di interrogare” (pp. 45-46).
L’antropogenesi, cioè il fondamentale processo biopolitico attraverso cui il corpo in un primate della specie Homo sapiens viene trasformato in un vivente umano, non consiste in altro che nella istallazione della grammatica, e quindi della lingua come dispositivo impersonale, direttamente nella carne vivente di quel piccolo mammifero, nella ‘sua’ lingua: “il linguaggio umano si costituisce attraverso un’operazione sulla voce, che la ‘articola’ (àrthrōn – da ararìskō – è la giuntura, l’articolazione delle parti di un corpo che lo rende atto a svolgere la sua funzione), iscrivendo in essa i gràmmata come suoi elementi. Questa ‘articolazione’, che rende intellegibile e significante la voce, è, in realtà, la scrittura alfabetica” (p. 43).
Tutto si gioca, allora, nell’articolazione fra lingua come carne e la lingua come dispositivo grammaticale e biopolitico. Per questo Agamben può parlare di una operazione di “inclusione esclusiva”, perché nella stessa operazione in cui il corpo viene incluso nell’apparato del linguaggio viene esclusa la viva carne vivente del piccolo umano preso nel processo della antropogenesi. Allo stesso tempo è evidente che l’unica possibilità di ‘liberazione’ per questo corpo ‘catturato’ dal dispositivo del linguaggio non può passare che per la lingua, ossia per la sua inconfondibile voce. Una voce, tuttavia, che come quella del poeta (ma anche quella del filosofo), è da inventare a partire da quello stesso dispositivo che, per innestarsi nel corpo, ha dovuto escluderla, appunto perché “la voce è esclusa e rimossa dal linguaggio” (p. 45). Il risultato del processo dell’antropogenesi è quindi una scissione, dal momento che solo rinunciando alla carne singolare del corpo si può accedere alla dimensione intersoggettiva ma impersonale della lingua: “di qui le fratture insanabili che percorrono in vario modo la natura e la cultura umana, divise in un polo irrazionale ed estatico e in uno razionale e conoscitivo, in coscienza e incoscienza, fede e ragione, ispirazione e riflessione. Di queste scissioni l’uomo deve venire a capo e può farlo solo trovando una voce e una materia […] in cui le opposizioni si risolvono e fluiscono” (p. 57). Ecco il compito, trovare “una voce” che sia la voce della lingua e quindi del corpo, e non solo il portaparola del linguaggio. Incarnare la propria voce, appunto:
“Il nostro tentativo di conoscere che cosa facciamo quando parliamo, di comprendere il linguaggio come la forma del diventare umano dell’uomo implica infatti che si revochi decisamente in questione la concezione corrente del linguaggio come un semplice strumento, un mezzo che l’uomo di volta in volta utilizza per i suoi fini di dominio sul mondo e sugli altri uomini. E filosofia e poesia sono i modi in cui l’uomo, commemorando e rivivendo ogni volta la stessa antropogenesi, cerca di venire a capo della scissione del suo linguaggio e della sua natura. Poesia e filosofia non sono due sostanze contrapposte: sono soltanto le due tensioni polari che animano e percorrono la voce umana. Per questo, finché durerà la scissione, vi saranno sempre poeti e filosofi e, insieme, essi dovranno perdere ogni volta la loro identità, scomparendo e annullandosi l’uno nell’altro, chiamandosi e revocandosi a vicenda” (pp. 64-65).