Primo Levi e l’amico tedesco
Un Levi insolitamente gioioso traspare da queste lettere al suo traduttore tedesco (Primo Levi, Il carteggio con Heinz Riedt, a c. di Martina Mengoni, Einaudi, 2024). Gioioso, più propriamente si dovrebbe dire, goldoniano.
Soldato della Wehrmacht, passato poi alla Resistenza GL in Italia, attivo in Veneto, innamorato della nostra cultura, Heinz Riedt si presentava agli occhi di Levi come la persona ideale cui affidare la traduzione delle sue pagine, ma anche figura perfetta cui confidare pensieri, riflessioni su tutto: dalla letteratura alla vita quotidiana, dall’educazione dei figli alle noie del lavoro quotidiano, fino alle riflessioni sulla politica italiana e internazionale, su Israele.
Questa densa documentazione epistolare rientra in un più vasto progetto di edizione dei carteggi leviani: un cantiere inaugurato da poco, disponibile on line sul portale LeviNeT (Primo Levi’s Correspondance with German Readers), promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Ferrara e curato da una valente studiosa.
Riedt viveva del suo lavoro editoriale, traduttore «cottimista» si autodefinisce: arriva a Se questo è un uomo passando per latitudini a Levi ignote come Ruzante, Gadda e, appunto, Goldoni. Quando la discussione sulla traduzione di questo o quell’altro passo oscuro si fa intricata, quando si arriva a un punto di stallo e sembra impossibile trovare una soluzione soddisfacente, Levi ricorre al suo senso dell’umorismo cercando di confortare quello che ormai sta diventando un amico: «Hai tutta la mia comprensione per il lavoro ingrato che stai facendo: mi consolo pensando che, p. es. con Gadda, hai visto di peggio» (p. 304).
Il carteggio va diviso in due parti. Nella prima, più sostanziosa, si affronta la traduzione di Se questo è un uomo. Nella seconda si parla della più tarda traduzione di Storie naturali. Per intensità e qualità delle notazioni non c’è paragone. Qui fa testo, per chi si occupa di Levi, la voce dal sen sfuggita che scioglie per sempre i nostri dubbi: «In fondo, queste Storie naturali sono pur sempre un libro “della mano sinistra”, e ci tengo un po’ meno che agli altri due» (p. 256). Levi avrebbe voluto Riedt a tradurre La tregua, ma non gli fu possibile vincere le resistenze di agenti letterari e funzionari della casa editrice. Tanto stimava il suo traduttore e amico da farsi coraggio e indossare la divisa del «piantagrane» per andare a perorare la causa in via Biancamano (p. 250).
La nota inclinazione di Levi a commentare se stesso trova modo di distendersi, di indugiare su punti di non semplice interpretazione. Il termitaio era affollato, plurilingue, babelico, irto di trabocchetti, espressioni gergali, scherzi della memoria. Richiedeva un commento esplicativo fatto di lunghe pagine, che lette oggi una dopo l’altra assumono la forma di un’autonoma edizione autocommentata. Questo esercizio procurava a Levi una gioia immensa, il mestiere che preferiva. Si divertiva, non vedeva l’ora di mettersi all’opera per rispondere punto per punto alle obiezioni di Riedt, con la felicità che procurano, appunto, le ciacole baseggesche dei Rusteghi. «Vegnimo a dire el merito», esordisce in una delle prime missive: «Lei è un goldonista, vero?» (p.21, 28 novembre 1959). Riedt sta al gioco: «Figurarse», replica prima di affrontare la spinosa questione della traduzione dei versi di Shema in epigrafe al libro (p. 26).
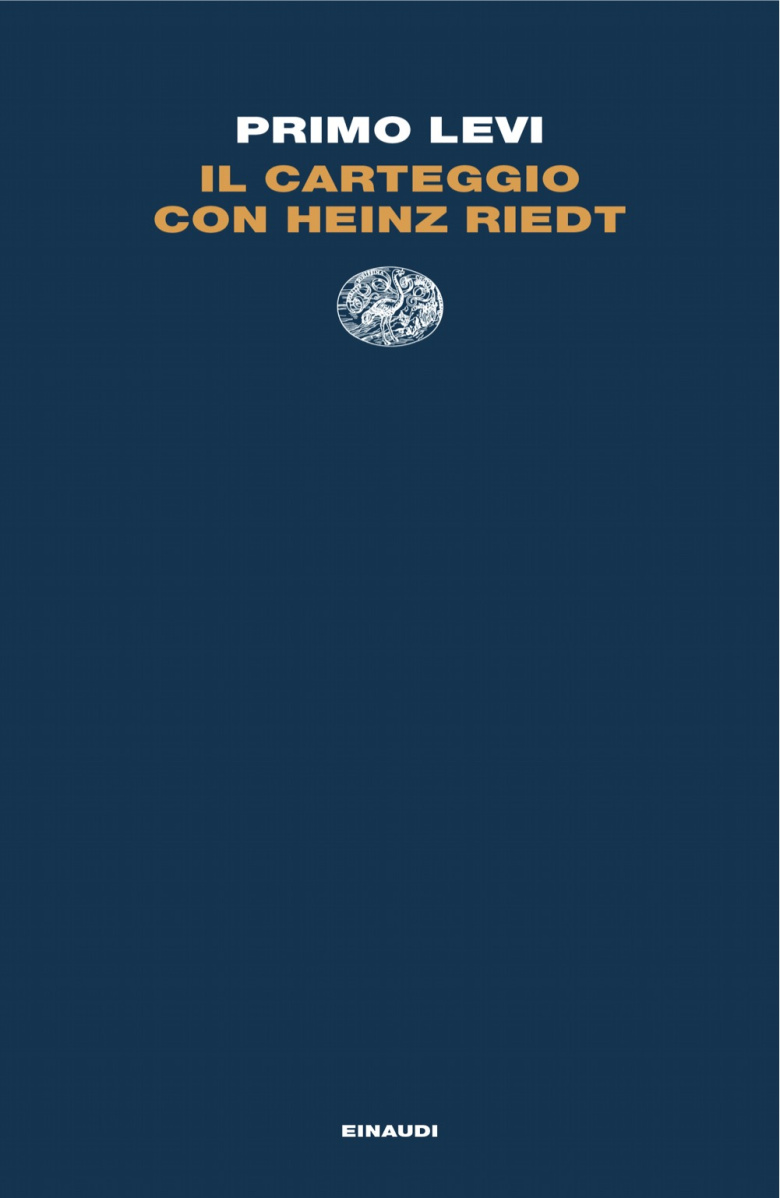
Molte di queste glosse, la maggioranza, riguardano questioni puntuali, minute, documentano la precisione quasi maniacale dell’autore, quella che Cases definiva un giorno la sua virtù di orafo. Qualche cosa di assai interessante emerge sul piano della intertestualità. A Riedt, Levi spesso ripete quanto poi dirà nelle note a commento dell’edizione scolastica di Se questo è un uomo, ma non solo. Qui c’è molto di più, talvolta Levi fa chiarezza con se stesso, anche se non manca, qua e là, il consueto vezzo di nascondere le fonti. Per esempio, quando, proprio a margine di Shema, non riconosce il doppio calco, dai Salmi e dalla Commedia, per gli ultimi versetti della poesia, limitandosi a dire, con vaghezza: «Non mi stupirei se si trattasse di un mio plagio inconscio da qualche profeta: la memoria fa talora di questi scherzi» (p. 18). Altre volte invece con candore ammette i suoi furti letterari e dunque ci aiuta a capire meglio il suo straordinario virtuosismo intertestuale. Eravamo fermi al furto da Baudelaire per l’«infame carogna» di Sómogyi, che morendo ripete sempre «Jawohl» ed ecco che a pagina 64 apprendiamo come, dietro quella memorabile sequenza, ci sia il ricordo del signor Fiala di un romanzo di Franz Werfel, La morte del piccolo borghese, stampato in Italia nel 1937 e dunque da annettere al ricco dossier di letture del Levi giovane, accanto alla casa dei morti di Dostoewskj (libro che viene tradotto in tedesco dalla moglie di Riedt: altra affinità elettiva) e del ciclo biblico di Thomas Mann.
Un vero peccato che questa edizione del carteggio Riedt sia sprovvista di indice dei nomi. In appendice troviamo il (meno essenziale) glossario delle espressioni tedesche oggetto di discussione tra i due (pp. 388 ss.): l’indice dei nomi avrebbe consentito di apprezzare meglio la ricchezza di quanto è detto in queste lettere densissime di riferimenti e allusioni talvolta fulminee.
Il caso Sómogyi ci permette di entrare nel merito di un tema annoso ancora di recente tornato oggetto di discussione. Il problema della relazione tra dato storico, ricostruzione testimoniale e opera letteraria. Il dilemma accompagna Levi fin dall’esordio: l’incertezza anagrafica di questo o quell’altro personaggio sono causa di passi in avanti e passi indietro, ripensamenti continui. Il caso Sómogyi, lo abbiamo visto, fa inclinare la bilancia dalla parte della letteratura. Baudelaire va a braccetto con Werfel, Dante con i Salmi. Elias Lindzin e Kraus Páli creavano invece problema. A Riedt (p. 33) Levi chiede di mutare il loro nome, «per evitare noie a persone ancora vive». Il problema esiste, lo sapevamo già per il Cesare della Tregua e per Pikolo che ricorda Carbonio invece del canto di Ulisse e la questione non esonera personaggi positivi come Sandro Delmastro o Lorenzo. Queste oscillazioni vanno spiegate una per una e toccano un problema reale: l’oscillante legame di Levi con le sue fonti letterarie non si libera mai del richiamo alla realtà, salvo poi fare marcia indietro. A Riedt, sempre nella medesima lettera, dice apertamente: «Lascerei invece intatto il nome (vero) del Dr. Pannwitz: non chiederei di meglio che mi citasse per calunnia». La questione non può essere approfondita qui, in sede di recensione, lo si dovrà fare con più agio. Rimane in ogni caso incontestabile la giustificazione preventiva che in una di queste lettere, Levi pronuncia contro chi oggi è maliziosamente tentato di giudicare, con moralistica supponenza, il suo «io giudicante», facendo leva su oscillazioni e incertezze per minarne la credibilità. «Può anche essere», si legge in una lettera del 28 novembre 1959, «che questo mio giudizio sia falso e fondato su pochi casi di mia diretta conoscenza. A quel tempo non ero un giudice molto obiettivo» (p. 22).
Il libro offre infine indicazioni utili sui gusti letterari di Levi, anche sulle sue sordità rispetto a opere lontane dalle sue consuetudini (per esempio sorprende vederlo giudicare «poco felice» un libro invece importante come Paura della libertà di Carlo Levi, p. 153); notevole l’ammirazione per Sciascia, per il suo stile asciutto e tagliente, l’elogio per Il giorno della civetta, così non meraviglia il giudizio entusiasta di I piccoli maestri di Meneghello (p. 183), di cui già si aveva notizia dall’esile ma importante carteggio tra i due da poco venuto alla luce. Di Fenoglio l’apprezzatissima Questione privata (molto meno Un giorno di fuoco) diventa un pretesto per regalare a Levi l’opportunità di sdebitarsi con Riedt, nel caso decidesse di tradurre lui il libro. Levi si offre come consulente linguistico per i molti piemontesismi (p. 144). Su Calvino i giudizi sono oscillanti: in Riedt (pp. 149-50), e in parte anche in Levi, ciò a conforto di chi crede, con buone ragioni, che il rapporto tra Levi e l’autore dei Nidi di ragno fosse meno stretto di quanto solitamente si dica.
Levi è poi prodigo di notizie sul suo viaggio in Israele nel 1968, i suoi dubbi su una società che andava trasformandosi sull’onda dell’euforia causata dalla vittoria della guerra. Un paese meno europeo di quanto pensasse, un giudizio in linea con quello formulato pochi anni prima da Pasolini: «Tutto nuovo e già vecchio insieme, tirato su alla svelta, alla spartana, senza concessioni al lusso e all’occhio; ma due cose sono ammirevoli senza riserve, il modo con cui coltivano la terra e allevano i bambini». Il muro del pianto «mi ha fatto ridere, Gerusalemme è indecifrabile, un viluppo inestricabile di epoche, architetture, civiltà e razze, dal luogo del sacrifico di Isacco alla sede dell’Onu» (p. 356).
Leggi anche:
Mario Porro | Primo Levi magico e darwinista
Giuseppe Mendicino | I sentieri degli scrittori. Le montagnes valdôtaines di Primo Levi
Marco Belpoliti | Primo Levi e l'amica tedesca
Mario barenghi | Primo Levi imprevedibile









