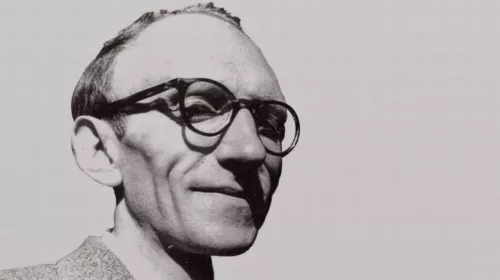Dionys Mascolo / Maurice Blanchot: Per l'amicizia
Alla fine di settembre, torno a Cosenza, nell’Università dove insegno, dopo un anno e mezzo di quasi totale assenza a causa della pandemia. Ogni cosa è spettralmente identica a come l’ho lasciata. Le abitudini quasi rituali si ripristinano senza esitazione: ricevimento, esami, cena coi colleghi, i trasferimenti da un cubo all'altro sul lungo ponte che li unisce, cordialità con la foresteria che mi ospita. Eppure, come un tarlo che ha lavorato silenziosamente e in profondità lasciando inalterata la superficie, qualcosa ha scavato una fenditura non suturabile, tanto più sconcertante quanto più in superficie tutto appare familiare, consueto, prossimo.
Si dirà: è quello che accade nei momenti di crisi, nelle faglie traumatiche della storia. È vero solo in parte. I traumi della storia non producono l’inedito, il mai visto e sentito prima, ma rivelano l’inedito, il discontinuo nel già da sempre esistente. Freud ci ha insegnato tanto a questo proposito. Partecipare agli eventi della storia con una qualche dose di compromissione e impegno, soprattutto quando si tratta di momenti che producono una “crisi della presenza” come diceva De Martino, non significa stabilire alleanze, legami fraterni, allacciare amicizie romanticamente empatiche, sperimentare l'antica philia tra persone che si trovano sulla stessa barca. Ben diversamente, si tratta di sentire la distanza assoluta che tuttavia ci lega all’amico, di avvertire la faglia che tuttavia mette in relazione gli eventi l’uno con l’altro.
Se si partecipa alla vita, questa ci contagia con la sua creatività e imprevedibilità. Ogni evento è una nascita assoluta. La crisi che, per definizione, si presenta come un taglio, una rottura rispetto al passato, ha la capacità di far sentire il taglio, la rottura già da sempre presente tra gli eventi e i protagonisti della storia. Ecco il paradosso: qualcosa si attesta come nuovo, al punto da essere traumatico, ma agisce come un evidenziatore, rivelando lo stacco, la frattura dei pensieri, delle azioni, degli eventi, dei rapporti di amicizia consueti. Come quando un sapore amaro, eccezionalmente amaro, acutizza la sensibilità del palato per la sfumatura acre del gusto anche negli alimenti più commestibili e ordinari. Lo stesso vale per il dolce, tanto più che qui non è in gioco una distinzione di valore, dato che la distanza, la frattura sono tutto meno che elementi negativi.
Siamo portati così a riflettere su cosa sia la storia. Abbiamo di questi tempi la bocca piena di una parola divenuta quasi indigesta: narrazione. Tutto è degno di essere narrato, di essere colto nel suo legame prossimo con ciò che è venuto prima e con quel che ne è seguito; persino l’atto più esplosivo e discontinuo, come quello di un suicidio o di un omicidio, non resiste malauguratamente alla pretesa fallimentare della narrazione. Saper raccontare storie, tessere fili tra gli eventi pare essere la suprema virtù dell’essere umano. Eppure quello della storia non è l’unico legame che possiamo cogliere tra gli eventi: ve n’è uno compatibile con l'interruzione, con la discontinuità, con la distanza assoluta. Questa relazione senza-rapporto cattura il pensiero di un autore veggente e straordinariamente attuale come Maurice Blanchot.
È da poco in libreria la prima traduzione italiana di un breve testo di Blanchot, Per l’amicizia (a cura di Francesco Fogliotti e con la postfazione di Bruno Moroncini, Cronopio 2021) pubblicato originariamente nel 1993, come Pré-texte al saggio di Dionys Mascolo À la recherche d’un communisme de pensée. Quello dell’amicizia è un tema caro all’autore come lo è stato per Derrida (si pensi alla raccolta di saggi intitolata L’amitié pubblicata da Blanchot nel 1971). Nel caso di questo breve saggio frammentario ma incisivo, il ricordo e l’omaggio si rivolgono proprio alla figura di Dionys Mascolo, militante politico e saggista francese, intellettuale avvolto nella penombra, eppure così importante nella vicenda privata e pubblica di Blanchot.
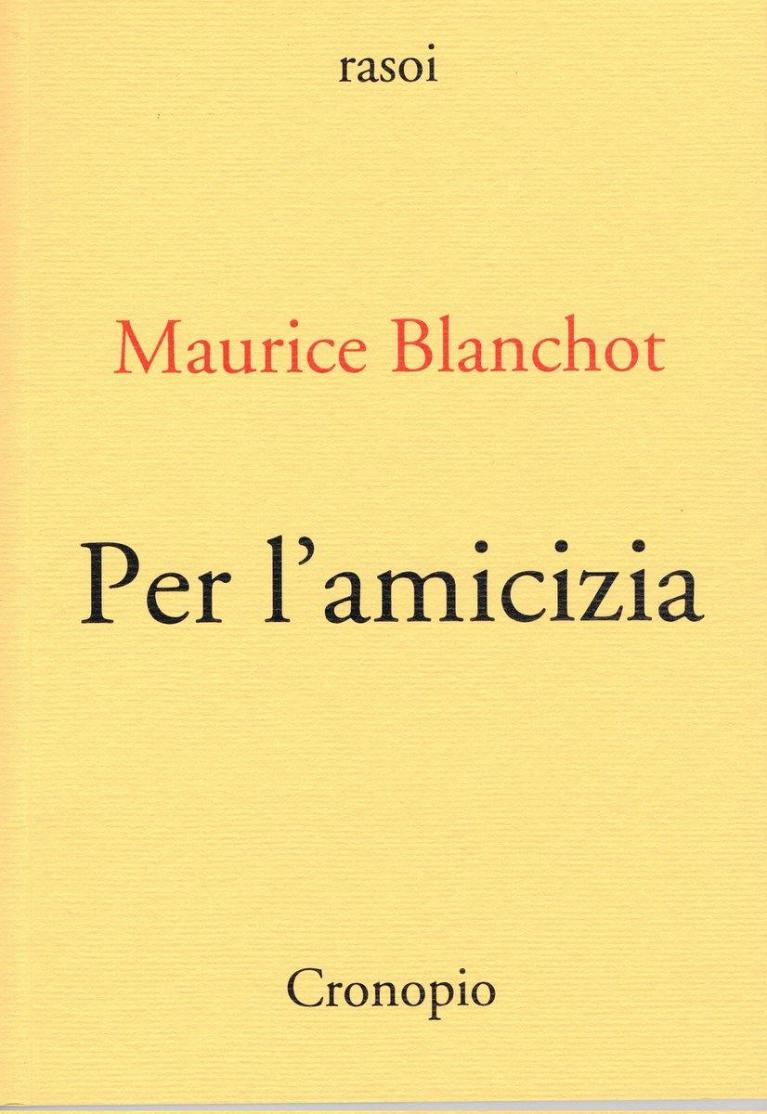
Mascolo è un amico, non un compagno o un camerata, nonostante molte siano state le avventure politiche che li hanno visti insieme: dal 1947 quando, grazie alla sua intercessione da Gallimard, vede le stampe la prima raccolta di saggi di Blanchot, Faux Pas, alla stesura del Manifesto 121 sulla difesa del diritto di insubordinazione nella guerra di Algeria, e alla partecipazione al maggio '68. Dunque una vicenda politica condivisa e contrastata che, tuttavia, non ha prodotto un sodalizio cameratesco ispirato alla promiscuità del “tu”, alla assoluta continuità e vicinanza in nome di un ideale condiviso. Blanchot e Mascolo si davano piuttosto del “lei”, stringevano il loro legame valorizzando interruzioni, discontinuità. Amici in quanto rispettosi della loro assoluta alterità, non compagni risucchiati dal potere magnetico di un’idea o di un ideale. Il modello della philia greca, ispirato alla fratellanza, alla reciprocità, allo scambio da Stesso a Stesso, non si adattava alla loro amicizia, viceversa vocata alla scoperta dell’Altro e al “godimento (senza concupiscenza, come dice Pascal) della sua Altezza, di ciò che lo rende sempre più vicino al Bene di quanto lo sia io”.
Come si parlano due amici? Si parlano senza raggiungersi. Il linguaggio non obbedisce a una volontà espressiva, non è “intermediario utile e comodo per la mente che vuol capire e farsi capire”. La domanda profonda non parte da chi la pronuncia per raggiungere chi l’ascolta, ma muove da una solitudine verso un’altra solitudine. La parola nasce come appello, come interpellanza, come invocazione. Un’invocazione si aspetta che chi la riceve non risponda, perché è un appello rivolto all’assoluta alterità. Un appello chiede all’altro di fare, agire, parlare o tacere al di là della soglia. L’interpellanza, o domanda profonda, si slancia a partire da una condizione di solitudine, rivolgendosi a qualcuno o qualcosa che è a un’assoluta distanza da noi, che si trova sull’altra riva e mai potrebbe far numero con noi. Tra i due amici, un silenzio disperante, un enigma mortale. Così Blanchot nel suo capolavoro, La conversazione infinita:
“La parola è prima di tutto questa interpellanza, quest’invocazione in cui l’invocato è fuori portata, è rispettato anche da chi lo ingiuria, è chiamato alla presenza della parola anche se gli si intima di tacere, e non è circoscritto in ciò che io dico di lui, tema di discorso o argomento di conversazione, ma è sempre al di là e al di fuori di me, mi trascende e mi sovrasta, in quanto io chiedo a chi mi è sconosciuto di volgersi verso di me, a chi mi è estraneo di intendermi”.
Insomma, la distanza non è una dannazione. Siamo tentati di intendere il non-rapporto, la distanza, l’interruzione in senso negativo, come una perdita del contatto fremente con la vita, un congedo dalla presa dell’esperienza, tale da nutrire mancanze, nostalgie, malinconie per la perdita del mondo. In fondo, potrebbe dirsi che se è vero che “non c’è rapporto sessuale”, secondo l’enunciato lacaniano, gli esseri umani sono condannati alla solitudine, alla distanza dalla vita che solo eros potrebbe lenire, sono destinati a essere gabbati dall’erranza dei significanti, lontani, infinitamente lontani gli uni dagli altri e tutti insieme dalla vita. Così intese, in effetti, la distanza, la separatezza, l’interruzione sono una vera dannazione. Eppure Blanchot e i suoi amici, Lacan e Levinas, a dispetto delle apparenze, ci hanno traghettato in tutt’altro territorio, facendo di quel “tele” l’occasione per sentire la vita. Il continuum genererebbe sviluppo, piegature; a regnare in esso sarebbe il risucchio del medesimo. Si guadagnerebbe un senso di unità, di immanenza, di appartenenza, ma si sacrificherebbe la possibilità di sentire la vita. Giacché sentire la vita significa vederla sorgere al di là della soglia, come evento non innervato da noi, come un accadere stagliato, sagomato, capace di attrarre nel suo gorgo dal futuro, senza anticipazioni, preparazioni. Dire “senza preparazione” significa ribadire l’interruzione della presa su ciò che accade, ma allo stesso tempo riconoscere l’estensione della nostra portata nell’incontro con l’alterità.
Che questa idea di amicizia sia particolarmente calzante per descrivere la modernità, come nota acutamente Moroncini nella postfazione a Per l’amicizia, è indubbio. Abbiamo oramai preso confidenza col sentimento della distanza, con la sensazione di poter estendere la portata sul mondo senza che questo ce ne garantisca la presa. Sappiamo tollerare l’insopportabile, grande paradosso del nostro tempo. Siamo in grado di tessere legami senza pontificare, senza gettare ponti che riducano il baratro. Rinunciamo al possesso per far essere l’evento esplosivo. Stabiliamo correlazioni senza individuare nessi causali diretti, smarriamo volentieri la linearità del tempo a favore di una temporalità selvaggia e incontrollabile. Tutto questo a patto di rinunciare alla conciliante e levigata fratellanza, e di coltivare, piuttosto, la scabrosa e ruvida amicizia.