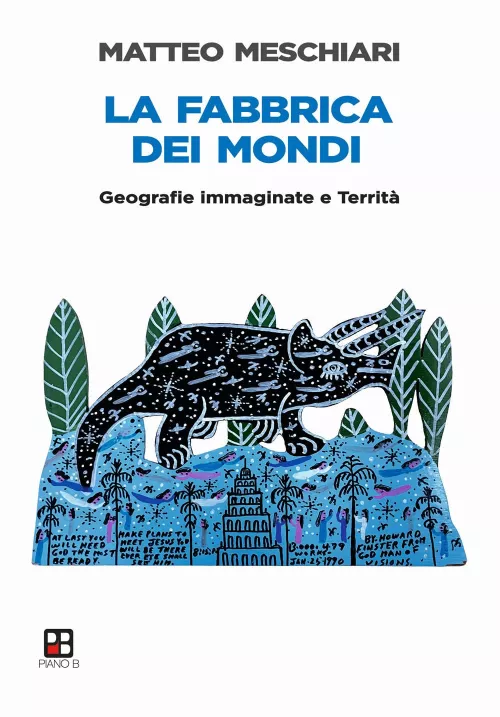Matteo Meschiari, una geografia delle macerie
Nel 1796, Hubert Robert dipinge la Vue imaginaire de la Grand Galerie du Louvre en ruines: un quadro a olio in cui l’artista raffigura la maestosa galleria a volta del Museo del Louvre in stato di rovina. Vediamo così il soffitto, in gran parte crollato, che si apre verso il cielo nuvoloso, mentre ai piedi dei grandiosi colonnati e delle pareti laterali, tra le macerie e i resti di statue antiche, vagolano le incerte figure di un’umanità in miseria. Ma non tutto è perduto. Proprio al centro della composizione, si staglia infatti la figura di un pittore, intento a copiare l’Apollo del Belvedere. La magnifica statua, infatti, emblema assoluto del Bello, si regge ancora integra e solenne in mezzo allo sfacelo; e può quindi servire di nuovo da modello a quel sopravvissuto disegnatore che non vuole dimenticare la perfezione delle arti classiche. E così pure paiono fare due giovani che, sulla sinistra, si chinano attenti sui resti di un busto di Minerva, la dea delle arti. Mentre sullo sfondo due popolane, in parte riparate dagli arbusti cresciuti sui margini sbrecciati della volta, si scaldano a un braciere improvvisato, come se fossimo in campagna.
Dunque ci troviamo dinanzi a una scena di disfacimento della bellezza e decadenza di una civiltà. Scena tanto più emblematica se si tiene presente che Hubert Robert ritrae una realtà del tutto inesistente: all’epoca infatti il Louvre era ancora in stato di costruzione e si stava appunto cominciando a realizzare quella Grande Galleria, che il pittore ritrae come se fosse già in sfacelo. Ma che vuole dirci allora Hubert Robert con questa prefigurazione di un futuro lontano, dove la possente gloria del presente che si sta erigendo giace ormai in rovina? Sicuramente il suo vuole essere innanzitutto un canto malinconico alla caducità del mondo: noi non siamo padroni del nostro destino. Perfino le magnificenze dei tempi moderni, i pomposi progetti della nostra contemporaneità, proprio quelli che noi oggi con tanto entusiasmo stiamo realizzando, cadranno un giorno in frantumi a terra.
Anche in tal caso però – aggiunge Hubert Robert – il germe del bello permarrà. Fra i ruderi e lo sfasciume, infatti, rimarranno integre, qua e là, alcune esemplari vestigia dello splendore antico. E da quelle testimonianze allora potremo ricominciare un’altra volta. Prendendole a modello, copiandole umilmente, saremo in grado di capire che significa la bellezza e ridare vita alla bellezza, così come qua e là, tra le statue a pezzi delle trascorse magnificenze, la semplice vita – l’umile vita di chi vuole riscaldarsi a un braciere, di una donna intenta solo a riposarsi sulle pietre del tempo che fu – riprende inestinguibile a trascorrere ancora, come sempre. Perché non tutto è scomparso anche quando tutto pareva scomparso: e quel minimo resto che è rimasto integro si rivela allora come il germe della gloria che verrà. Purché ci sia qualcuno che sappia chinarsi premuroso sui frantumi delle glorie antiche, per farne memoria e custodirle, così come si preserva e rinasce sempre la nuda vita dei corpi che hanno bisogno di calore, la semplice vita di due persone che non hanno dimenticato come si accende un fuoco…
Questo messaggio risuona tanto più forte, convinto e incoraggiante, se si pensa che Hubert Robert non era un artista sovversivo, “fuori dal sistema”, ma anzi pienamente organico alle istituzioni dello Stato: era infatti il responsabile delle collezioni di pittura destinate proprio al futuro museo del Louvre. Del resto, l’artista era noto per la sua passione nel ritrarre, in una mescolanza continua di vero e falso, crolli e ricostruzioni architettoniche, disfacimenti e rinascite urbane. Tanto da essere soprannominato Robert des ruines, cioè “Roberto delle rovine”. Del resto il suo apprendistato lo aveva svolto proprio a Roma, teatro smisurato dove ogni giorno, da secoli, andava in scena lo spettacolo della magnificenza che persiste a grandeggiare, a primeggiare, pur ridotta a un susseguirsi di crolli e di dissesti. Qui, nell’“Urbe eterna”, Hubert Robert aveva visto i pastori pascolare greggi, le lavandaie sciacquare i panni sotto i ruderi maestosi delle glorie antiche. E qui aveva subito il fascino misterioso delle rovine, che tanto incantava non solo lui ma tutta la sua epoca: quella convinzione che il tempo passa, tutto decade, tutto crolla, ma la bellezza non tramonta mai del tutto, la vita rifiorisce, e nel disfacimento già si scorgono le basi per un grandioso progetto nuovo.
La Bellezza! Ma, di fronte al quadro possente e “resiliente” (come diremmo oggi) di Hubert Robert, proviamo invece a immaginare che, dalla scena dipinta, fossero scomparsi il busto di Minerva, l’Apollo del Belvedere, il disegnatore intento a ricopiare questi preziosi reperti… Raffiguriamoci la medesima scena ma senza consolanti appigli di spirituali riscatti. Se ci trovassimo solo di fronte a cumuli informi di sterpi e rottami, con macilente figure di rari sopravvissuti, vagolanti in cerca di un misero riparo o degli avanzi marcescenti di un pasto? In un simile spazio dissestato, non più paesaggio abitabile, ma scomposizione definitiva di ogni possibile idea di casa futura, che cosa ci rimarrebbe? Da dove potremmo ripartire? Me lo chiedo mentre vado leggendo il mirabile (e anche un po’ perturbante) libro di Matteo Meschiari, La fabbrica dei mondi. Geografie immaginate e Territà (Piano B Edizioni, 2024). Geografo e antropologo, autore di testi dove la ricerca saggistica si trasfonde in una narrativa di spregiudicata eleganza, Meschiari ha dato vita in questo suo nuovo lavoro a quello che lui stesso definisce «un manuale portatile della notte», vale a dire un’ampia ricognizione tra opere e autori che, nel corso degli ultimi decenni, hanno traversato i tormentati campi delle distopie, dei fantasmi apocalittici, dei collassi catastrofici: autori e autrici che si sono immersi in mondi disfatti, disconnessi, ottenebrati, dove di tanto in tanto però, sembrano aprirsi varchi inattesi, faticose ma percorribili vie di fuga, dischiuse proprio dentro gli abissi, in fondo ai vicoli ciechi, tanto da permetterci di delineare, immaginare nuove possibili geografie, pur dentro il collasso dell’epoca che stiamo vivendo: l’Antropocene.
Ci sarebbe dunque un residuo irriducibile di resistenza, che permane nonostante il cumulo dei dissesti, anzi che si manifesta proprio dentro lo sconquasso. E tale scoglio inscalfibile, incoercibile malgrado ogni crollo, Meschiari lo chiama, con un neologismo efficace, la “territà”. Una Terra da percorrere, da raccontare, da mappare, un suolo sorprendentemente ancora vivibile, forse addirittura salvifico, anche se ormai percepibile solo come un sovraccumulo di macerie non ulteriormente comprimibili. Ma sentiamo come ne parla l’Autore stesso:
«Quando il crollo è avvenuto, l’unica cosa che resta a chi sopravvive, a parte migliaia di frammenti alieni del mondo di prima, è la Terra sotto i piedi. Né madre né matrigna, né massa inerte né Gaia senziente, la Terra è come un grande animale del Tempo di cui restano solo le ossa. Che cosa si può fare con un cumulo d’ossa nella tabula rasa della prateria? Alcuni popoli, lontani nello spazio e nel tempo dal nostro Occidente, ce lo raccontano da sempre con varianti infinite dello stesso mito: le ossa vengono ricomposte e l’animale rinasce. Non è questione di superstizione, di speranza o di credenza. L’animale rinasce perché è pensato, cercato, desiderato, perché è una bestia fatta di carne ma anche di idee, perché se non fosse immaginato sarebbe perfino impossibile cacciarlo. Quando il suo corpo muore, quando una civiltà muore, l’unico modo per de-estinguerla è re-immaginarla. Per alcune persone che camminano, pensano e immaginano molto – come le autrici e gli autori in questo libro – la risposta è semplice: la Terra si salva con la Terra».
Sono molti le scrittrici e gli scrittori che Meschiari convoca in questo suo percorso attraverso la territà: Calvino e Pasolini, Tolkien e McCarthy, Paul Shepard e William Vollmann, Laura Pugno e Laura Pariani, più altre e altri ancora, che attraverso le scritture più svariate ci hanno inviato i loro Dispacci dall’Antropocene. Testi ora smaglianti, ora soffocanti, ora allucinati che, malgrado la loro difformità, ci hanno insegnato a osservare il reticolo di resistenza della territà, la meraviglia di nuove mappe, di nuove geografie di senso, che ci appaiono quando impariamo a osservare le crepe del suolo, la moltitudine di «minerali, piante, animali, paesaggi selvatici, foreste, eventi atmosferici, migrazioni, dimore, battaglie, popoli, città, tutti legati tra loro in un vasto ecosistema narrativo». Una «fabbrica di mondi» (come recita il titolo stesso del libro di Meschiari) che trova appunto nella territà un fondo unificante, un residuo vivibile, oltretutto descrivibile in una nuova geografia, concepita proprio a partire dalle macerie, dal collasso dell’Antropocene.

Si badi bene: la territà di cui ci parla Meschiari non è la Madre Terra, noi coincide con l’antica, nutriente, materna Natura che noi abbiamo offeso e di cui ora dovremmo prenderci cura. Mantenendosi invece in tale prospettiva consolante e incoraggiante, il filosofo Duccio Demetrio pubblicava, nel 2013 , un libro bello e importante: La religiosità della terra. Una fede civile per la cura del mondo (Cortina). Demetrio si proponeva, in quell’opera pedagogica e propositiva, di superare le differenze fra credenti e non credenti, o i diversi approcci del mondo laico e religioso, per costituire in modo ecumenico una nuova «fede civile» basata sulla comune esigenza di custodire, proteggere una natura da noi stessi aggredita e saccheggiata. Occorreva di conseguenza immaginare non una nuova fede religiosa, ma una inedita e laica «religiosità della terra», basata sulla meraviglia, la commozione, lo sgomento di fronte allo spettacolo straordinario della natura, ma anche di fronte allo strazio di una terra declinante, madre nutrice in affanno, da curare e da amare come una figlia. Come dire che la nuova epoca in cui ci ritroviamo, quell’Antropocene dove l’essere umano modifica strutturalmente i processi geologici e biologici, ci sollecita per ciò stesso a farci carico di una Terra da salvare, se non vogliamo perire insieme alla vita stessa del Pianeta.
Ebbene, Meschiari si pone al di là di questa chiamata a una nuova custodia di un mondo malgrado tutto ancora mirabile, ancora incantevole: assume infatti come già avvenuto il tracollo dell’Antropocene, e si pone alla ricerca dei residui di territà che non possono essere ulteriormente decomposti: «in epoche di disgregazione e collasso è sempre dalla terra che la nostra specie è ripartita per pensarsi al di là della faglia. Anche in letteratura: tra bordelli, deserti, coste, geologia, invasioni vegetali e fantasmi di persone e di città», si può sempre pensare a un nuovo atlante, «un’antropologia radicale dei luoghi ultimi». Ma vi è un ulteriore, inatteso esito che emerge da questa prospettiva: spingere in avanti fino all’estremo lo scenario del cataclisma, permette al tempo stesso di tornare indietro, fino a una dimensione mitica, sacrale, cosmogonica, dove animali, piante, esseri umani rinascono insieme, dal fondo comune della terra, dal suolo e dal sottosuolo di una territà mai scomparsa.
Meschiari non lo cita, ma proprio seguendo questo suo approccio proviamo ora a leggere un passo dal primo capitolo del libro della Genesi:
«Poi Dio disse: “Produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza, sulla terra”. E così fu. La terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che portavano frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fui mattina: terzo giorno» (Gen 1, 11-13).
Ci troviamo qui agli inizi dei tempi. Luce e tenebre, come pure cielo, terra e mari sono appena stati creati, ma la vita ancora non c’è. Dio allora fa sorgere dalla terra i vegetali: erbe, alberi, frutti… Dal fondo terroso, dal suolo minerale, spunta per la prima volta la vita, in forma vegetale. Facciamo attenzione. Nel momento stesso in cui Dio dà vita alla vita, fa anche un passo indietro, discretamente si ritrae. Non vuole essere Lui a immettere dall’esterno la vita dentro alla terra, ma esorta la terra stessa a produrre vita, come se questa vita sgorgasse dalla sua stessa “terrosità” o “territà”. E perché mai sarebbe la terra così importante? Perché Dio non auspica semplicemente un’esuberanza vitale nella nascita dei vegetali. Non è che erbe, arbusti, alberi, fiori, frutti siano incoraggiati a manifestarsi nel mondo attraverso una profusione inarrestabile di forme, le più fantasmagoriche possibili. Ogni specie viene invece sollecitata a produrre semi e frutti, non in modo confuso e imprevedibile, bensì ciascuna secondo le caratteristiche della propria specie. Dunque una riproduzione della vita specie per specie, e da una generazione all’altra, nel corso del tempo, dato che ogni frutto porta già «in sé la propria semenza, sulla terra».
L’esplosione della vita vegetale non darà dunque origine a una girandola imprevedibile di sempre nuove piante, mai viste prima. Per quanto carico di energia vitale, il nuovo mondo delle piante si presenta fin da subito stabile e ordinato, in grado di mantenere ben definite le diverse identità di ciascuna specie. Tant’è che, seguendo l’invito della parola di Dio, «la terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo le loro specie e degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie». Ma non sarebbe questo un sistema un po’ rigido e violento che esclude a priori un luogo vivibile anche per chi si situa invece a metà via, fra una specie e l’altra, fra un genere e l’altro? Non è – quello descritto in Genesi – un sistema conservatore e “antidarwiniano”, che impedisce l’evoluzione delle specie, resa possibile – così ci spiega la scienza – proprio dalla continua proliferazione di variazioni genetiche, solo grazie alle quali potranno poi imporsi nuove specie? No, perché il testo non esclude a priori la nascita di nuove specie, e quindi la variazione del sistema riproduttivo. Che cosa ci spinge a ipotizzarlo? Il fatto che il racconto di Genesi 1, 9-13, insiste sulla terra quale fondamento produttivo di ogni specie di vegetazione. Erbe e alberi non si riproducono da soli, in autonomia, ma scaturiscono dal suolo, e al suolo tornano sotto forma di frutti carichi di semenza per la terra. La terra dunque si rivela come una immensa riserva di specie e di piante, come un fondamento unico, unificante, pre-specifico, che permette la varietà di tutte le specie, ma che non si limita a confermare l’identità di ogni singola specie. E infatti la terra, proprio in quanto fondamento pre-specifico, potrebbe sempre, in futuro, dare origine a nuove specie. La terra si rivela così un fondamento originario della vita, in tutte le sue nuove, possibili forme. È questa – se vogliamo usare un’ultima volta ancora le parole di Meschiari – la Territà. È questo il racconto mitico, ancestrale, che ci riporta all’origine sacra dei tempi, proprio quando l’Antropocene sembra aprirci alla prospettiva di una angosciosa fine di tutti i tempi. Ma no! – dice Meschiari – non sarà così, perché è già stato così, fin dai tempi del Pleistocene, fin dai tempi in cui gli umani convivevano fianco a fianco con le piante e con gli animali, sul suolo terrestre…