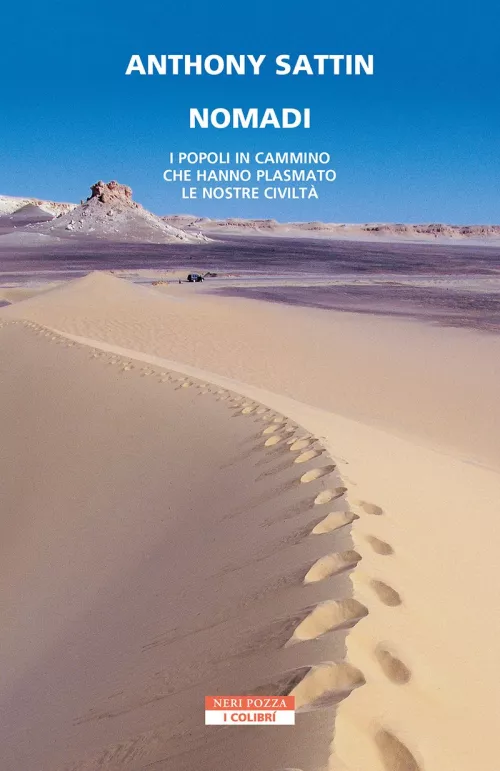Nomadi, il lato in ombra della storia
Avanzano lungo un pianoro sassoso e giallastro, sullo sfondo crepato di un’arida montagna bruna. Uomini e donne cavalcano in lenta fila, chi a cavallo, chi su un asino o un cammello. Portano cappucci neri, mantelli scuri o candidi e, appesi alle selle, sacchi rossi o bisacce paglierine, in un sublime accostamento di colori che rende misteriosamente nobile la loro dignitosa povertà. Sfilano silenti davanti a noi, senza degnarci di uno sguardo, il volto sempre fisso verso un orizzonte desolato, privo di oasi, privo di miraggi, di là dal quale però si nasconde evidentemente una meta a noi ignota, ma verso cui si dirigono pazienti e vigorosi, ritti sulle loro selle come calmi guerrieri, come sfavillanti, orgogliose matriarche… Chi sono? Sono nomadi, di più non so: un’esigua carovana di errabondi nel deserto del Marocco. È la prima volta che li incontro. Vorrei quasi rincorrerli, ma la loro taciturna dignità mi intimidisce, li perdo, sfilano via come punti evanescenti nel deserto, non li reincontrerò più.
Oltre trent’anni son passati da allora, ma ancora insistono nei miei ricordi: immagine enigmatica e fascinosa di un altro modo di vivere, un altro stile con cui abbigliarsi e guardare l’orizzonte per traversare nobilmente le distese del mondo. Una diversa postura nell’essere uomini e donne: quella che Bruce Chatwin chiamava, proprio in quegli anni, «l’alternativa nomade». Ma anche Chatwin da tempo se n’è andato, e oggi chi crede più ormai di poter seguire la sua affascinante, forse troppo fascinosa idea, secondo la quale la forma nomade costituirebbe il vero stile di vita, l’autentica vocazione a cui tutti, anche noi stanziali, saremmo chiamati, così da raggiungere una pienezza d’esistenza? Nel frattempo, i popoli nomadi si sono ancor più ridotti a esigue, ininfluenti minoranze su una terra vieppiù sovraffollata di metropoli e migranti in penosa erranza: non nomadi per scelta, bensì profughi costretti a fughe tormentate. Ma i nomadi a cavallo, che liberi percorrono le steppe guidando mandrie e greggi, chi li sogna più? Chi crede ancora all’alternativa nomade che Chatwin vagheggiava?
Ebbene, qualcuno c’è, e non si tratta semplicemente di un incerto epigono del vecchio Bruce. Si chiama Sattin, Anthony Sattin, ed è un giornalista e storico britannico che ai popoli nomadi di Asia e Africa ha dedicato anni di studio, realizzando libri e reportage televisivi. Ora, tradotto da Alessandra Manzi, Neri Pozza pubblica il suo ampio, vertiginoso testo Nomadi, uscito l’anno scorso in Inghilterra, e subito elogiato dai più noti scrittori inglesi di viaggi come «un’opera di bellezza e ritmo seducente», come «un libro importante, un libro generoso, scritto meravigliosamente» (William Dalrymple). Ma davvero? Chiariamo subito: lo stile non è quello lucente, fantasioso ed eccitato di Chatwin. Piuttosto, Sattin avanza con passo attento e misurato, lo sguardo umano e premuroso del bravo documentarista che sa esporre con ordine e compartecipazione i suoi argomenti. E quali argomenti! Qui sì che troviamo qualcosa di grandioso e di potente, come se Sattin ci volesse accompagnare «verso vette altissime della storia umana» (ancora Dalrymple). Il progetto del nostro autore è in effetti ambizioso assai, ma l’esposizione risulta solida e originale, come quella di un esploratore che ha trovato una nuova via per traversare i paesaggi della storia umana, e rivederne le tappe passo dopo passo, dal paleolitico fino ai nostri giorni.
L’idea di Sattin è questa. Partire dai primordi, dagli antichi spostamenti di cacciatori e raccoglitori; notare poi che le prime architetture monumentali, come pure l’addomesticamento dei cavalli, l’invenzione fondamentale delle briglie e dei carri, furono opera di nomadi e non di civiltà stanziali; spiegare quindi «come fosse possibile mettere insieme una sequenza di imperi – da quello persiano, xiongnu e han a quello mongolo, moghul, safavide e ottomano – che suona alternativa alla visione eurocentrica dell’universalità degli imperi lungo l’asse Egitto-Grecia-Roma». E concludere quindi che la storia dei nomadi, o meglio la storia dell’umanità osservata dal punto di vista nomade ci permette di «capire il nostro posto nel mondo naturale». Detto in altri termini, la scommessa di Sattin è che sia possibile riscrivere in modo proficuo la storia umana, rovesciandone la prospettiva: non più concentrarsi sullo sviluppo progressivo delle grandi civiltà stanziali, ma osservare queste ultime tenendo come punto prospettico d’osservazione il susseguirsi delle culture nomadi, molto più ricche, potenti e influenti per l’evolversi delle civiltà di quanto non possiamo immaginare se teniamo ferma solo sui popoli stanziali la nostra attenzione.
Questo approccio storiografico ha una sua plausibilità e permette di valutare meglio il susseguirsi delle grandi vicende umane dagli inizi nella preistoria fino almeno ai secoli XVI e XVII della nostra era. In effetti, un susseguirsi ininterrotto di grandi migrazioni, invasioni, spostamenti di popoli ha sempre caratterizzato i tempi della storia antica, e anche quando sono sorte le prime straordinarie civiltà stanziali – in Egitto, in Grecia, a Roma – il contributo dei popoli nomadi all’affermazione di queste stesse civiltà è stato molto più importante e profondo di quanto non si possa superficialmente immaginare. Solo il continuo spostamento di genti, carovane, mercanti, idee, invenzioni ha in realtà permesso e nutrito senza sosta il consolidamento delle civiltà stanziali. Ma i protagonisti di tale vitale interscambio erano appunto i popoli nomadi, usi da sempre ai grandi spostamenti lungo le vie carovaniere, pronti a valicare ogni catena montuosa, o a superare – con le buone o le cattive – ogni confine statale, ogni frontiera culturale. È un fatto che i più vasti e potenti imperi della storia, almeno fino all’avvento dell’età moderna, erano quelli del Medio Oriente e dell’Asia centrale, dove dominavano unni, arabi, mongoli, turcomanni, tutti popoli nomadi o seminomadi che basavano la loro potenza militare e culturale sulla capacità di superare velocemente enormi distanze, trasportando soldati e mercanzie, provocando non solo epici scontri militari, ma soprattutto favorendo l’incontro tra lingue, religioni, mentalità diverse: un interscambio ininterrotto e vitale, che da sempre ha permesso e favorito il fiorire delle civiltà.
Sattin è molto bravo nel farci conoscere da vicino la grande apertura mentale, la grande visione politica di personaggi che noi siamo abituati a considerare solo come collezionisti di teste tagliate, barbari sanguinari dediti ad efferate crudeltà: Attila, Gengis Khan, Tamerlano, nomi da brivido… Eppure, sotto il loro dominio, «le città dell’Asia centrale producevano tessuti, tappeti, ceramiche, opere in metallo e gioielli, tanto che, non certo a caso, il poeta britannico James Elroy Flecker parlava di una strada d’oro per giungere a Samarcanda», dove nel XIV secolo si trovava la corte di Tamerlano. In questa favolosa, mitica città, vera metropoli multietnica, non splendevano solo straordinarie architetture islamiche, perché fianco a fianco vi lavoravano artigiani europei e persiani, e convivevano in pace studiosi musulmani, maestri buddhisti, preti cristiani. Qui si era costituito un immenso centro carovaniero dove «seta, muschio, diamanti, rubini, perle e rabarbaro provenivano dalla Cina, cuoio e lino dalla Russia, cannella, noce moscata, chiodi di garofano e molte altre spezie dall’India».
Ma Sattin sa descrivere anche con chiarezza i molteplici fattori che, a partire dal Cinquecento, portarono al progressivo declino delle civiltà nomadi. Innanzitutto l’apertura di nuove vie marittime da parte delle potenze europee: la scoperta dell’America e la circumnavigazione dell’Africa – per raggiungere via mare le Indie e le ambite isole delle spezie – privarono i paesi arabi del loro monopolio marittimo e soprattutto tolsero importanza alle grandi piste carovaniere dell’Asia centrale, che fino a quel momento costituivano per l’Europa la più importante via mercantile. Poi, con il Seicento ecco lo sviluppo del pensiero scientifico e un secolo dopo il sommovimento della rivoluzione industriale e il dilagare dei grandi imperi occidentali e coloniali, cui venivano ad aggiungersi gli Stati Uniti d’America. Per le grandi civiltà nomadi non vi era più scampo, cominciava il loro inesorabile declino. E se 10.000 anni fa – nota Sattin – la popolazione globale era costituita quasi interamente da etnie nomadi, oggi queste ultime sono ridotte a circa 40 milioni, su una popolazione complessiva prossima agli 8 miliardi. Per chi avverte il fascino del mondo nomade, non vi sarebbe dunque altra prospettiva che quella della nostalgia e del rimpianto, come cantava nel 1980 Bruce Chatwin:

Quel giorno [a venire] non riporterà in vita le cose che abbiamo amato: le immense giornate limpide e le azzurre calotte di ghiaccio sui monti; i filari di pioppi bianchi che tremolavano al vento, e le lunghe e candide bandiere da preghiere; i campi di asfodeli che venivano dopo quelli dei tulipani; o le pecore dalla grassa coda che chiazzavano le colline sopra Chaghcharan (…) Non ci sdraieremo più davanti al Castello Rosso a guardare gli avvoltoi roteanti sopra la valle in cui fu ucciso il nipote di Gengis Khan. Non leggeremo le memorie di Babur nel suo giardino di Istalif, né vedremo il cieco avanzare tra i cespugli di rose facendosi guidare dall’olfatto. Non andremo a sederci nella Pace dell’Islam con i mendicanti di Gazor Gah (…) Non dormiremo nella tenda dei nomadi, né daremo la scalata al minareto di Jam. E avremo perduto i sapori: il pane rustico, caldo e amaro; il tè verde speziato col cardamomo; l’uva che facevamo raffreddare nella neve; e le noci e le more secche che masticavamo per difenderci dal mal di montagna. Né ritroveremo l’aroma dei campi di fagioli, il dolce resinoso profumo del legno di deodara, o l’afrore di un leopardo delle nevi a quattromila metri. Mai più. Mai più mai più.
(Bruce Chatwin, Lamento per l’Afghanistan, testo introduttivo a: Robert Byron, La via per l’Oxiana, Adelphi, 1993).
Ho voluto riportare quasi per intero queste righe elegiache di Chatwin perché ben ci restituiscono l’incanto per un perduto mondo nomade: una seduzione alla quale anche il più asciutto Anthony Sattin non è estraneo. Tant’è che a propria volta inizia il suo libro con una splendida descrizione dei nomadi Bakhtiari in Iran, così come lui li ha conosciuti:
Un giovane uomo mi viene incontro tenendo un bastone sulle spalle. Tutt’intorno a lui è un gregge: le pecore gli stanno davanti, accanto, dietro; si muovono disordinatamente – come l’acqua delle nevi disciolte che scorre nel vicino torrente – e lo accompagnano lungo il sentiero alla stregua di una frotta di bambini vocianti. Un uomo anziano – segnato dalle intemperie ma ancora vigoroso – lo segue con un fucile sulla spalla sinistra e schiocca di tanto in tanto la lingua per convincere il gregge a muovere in avanti. Seguono due donne in groppa a un asino, una più anziana dell’altra, che penso siano sua moglie e sua figlia. Sembrano donne forti, ma d’altronde dev’esser così, perché la vita sotto le cime scoscese dei monti Zagros è difficile. Altri asini trasportano le loro cose, raccolte all’interno di pesanti teli di un color ruggine, che sono stati tessuti dalle donne e che presto, non appena verranno montate le tende, saranno utilizzate come copriporta. A questa altitudine gli alberi sono pochi, ma la neve ormai si è sciolta e la valle – coperta di iris, tulipani nani e altri fiori primaverili – è di una struggente bellezza. La famiglia sembra allegra, mentre conduce verso me le pecore e le capre bianche e grigie, con i maschi dalle magnifiche corna volte all’indietro. E io a mia volta sorrido loro, per l’emozione che provoca in me la migrazione annuale dei Bakhtiari dalle pianure fin sulle montagne, in cerca di pascoli estivi.
(A. Sattin, Tra i monti Zagros, in Iran, testo introduttivo a: Nomadi, Neri Pozza)
Ma Sattin non scrive la sua opera solo per lasciarsi andare allo struggimento verso lo splendore di un mondo antico e ormai residuale. Anzi, la sua convinzione è che la prospettiva nomade vada compresa e conosciuta proprio in quanto rilevante per il nostro futuro. Vi sono infatti, nelle forme di vita nomade, dei valori, delle norme, dei comportamenti su cui lui insiste a più riprese, in quanto dovremmo imparare a farli nostri, ad assimilarli. Vediamoli brevemente.
Innanzitutto la spinta ininterrotta allo spostamento, la volontà di considerare sempre provvisori i confini entro cui viviamo, per aprirci verso altri orizzonti, verso nuovi scenari di vita. Poi la disponibilità inesausta all’incontro, all’interscambio, al dialogo e al commercio con altri popoli e culture. Di conseguenza la tolleranza spirituale e religiosa, la disponibilità a lasciar convivere pacificamente, fianco a fianco, diverse fedi e tradizioni. E quindi, lascito prezioso dell’incontro fra diversi, la primaria importanza attribuita alle tradizioni orali, il fascino dei racconti a viva voce, delle conversazioni meravigliate e divertite sul far della sera, in un convito. Accanto a ciò, l’attenzione inesausta verso il mondo naturale, la spinta a vivere osservando con premura le manifestazioni della natura, assecondandone i ritmi, invece di contrastarli. Un’attenzione alla natura che va di pari passo con la piena dignità offerta alle donne, la profonda rilevanza attribuita al mondo femminile, senza mai stabilire rigide gerarchie e forme di sottomissione di un genere contro l’altro. Infine, la grande capacità di costruire relazioni sociali il più possibile paritarie, fra chi comanda e chi ubbidisce, senza creare divisioni di gruppo, per alimentare invece fortissimi legami comunitari, in modo che ogni compagine sociale, grande o piccola che essa sia, venga tenuta insieme dalla forza dell’asabiyya, parola araba che vuole indicare «una condizione gioiosa, un sentimento di comunanza, uno spirito di corpo, una solidarietà tribale». E con ciò arriviamo all’ultima caratteristica della forma nomade di vita: la gioia, la capacità di godere la vita nei suoi aspetti più pieni, più festosi, più corporei, malgrado la durezza, la fatica, il dolore delle condizioni di esistenza in cui ci si ritrova gettati. Com’è possibile tanta esultanza, anche nella più aspra povertà? Ma perché i nomadi sono gente libera, ed è la loro eterna libertà il più grande valore di cui ci danno testimonianza.
Prova ne sia un film stupendo, che Sattin ci descrive e che anche noi possiamo facilmente reperire online: Grass: A Nation’s Battle for Life. Si tratta di un eccezionale documentario, realizzato nel 1926 da Ernest Schoedsack, Merian Cooper e Marguerite Harrison, per descrivere la transumanza dei pastori Bakhtiari (quelli stessi che quasi un secolo dopo, come abbiamo visto, avrebbe incontrato anche Sattin). Un film muto, in bianco e nero, di 75 minuti: ma vale assolutamente la pena di vederlo. Per la prima volta al mondo Grass ci mostra la vita nomade nella sua pienezza e nella sua purezza, così come fino ad allora si era sempre svolta, identica a se stessa, secoli dopo secoli. Vediamo la meraviglia dei costumi e la luminosità eccitata degli sguardi, vediamo le zattere create con otri in pelle di pecora per attraversare i fiumi, seguiamo file interminabili di uomini, donne e bambini che, guidando mandrie e greggi, a piedi nudi, traversano deserte montagne innevate, per raggiungere i pascoli dell’abbondanza. Si tratta di un documento cinematografico unico, di abbagliante splendore, anche perché già sappiamo che di lì a pochi anni l’integrità di quel mondo si sarebbe frantumata, con le strade asfaltate al posto delle piste polverose, i furgoni che superano i valichi di montagna sostituendo i cavalli e i piedi nudi, i ponti invece delle zattere, la religione di Stato che cerca di imporsi sulle antiche credenze persiane, le case di città che cancellano via via i vecchi accampamenti… Sattin conosce bene tali trasmutazioni e le descrive nelle ultime pagine del libro. Ma ci fa anche capire che, nonostante il declino, la vitalità nomade non si spegne, l’orgoglio nomade continua a rifulgere sui volti dei Bakhtiari. E Sattin ce lo racconta, questo fulgore, e convince pure noi a incamminarci verso i colori del mondo nomade. Cosa significa? Non necessariamente raggiungere i monti Zagros dell’Iran, per incontrare gli ultimi Bakhtiari. Ma imparare ad accogliere nel racconto della nostra storia anche l’altro versante delle vicende umane: quello dei popoli nomadi. E poi coltivare forme di vita nomade anche nelle nostre esistenze, così da offrire una prospettiva diversa, più profonda e più vitale, al futuro che ci aspetta.