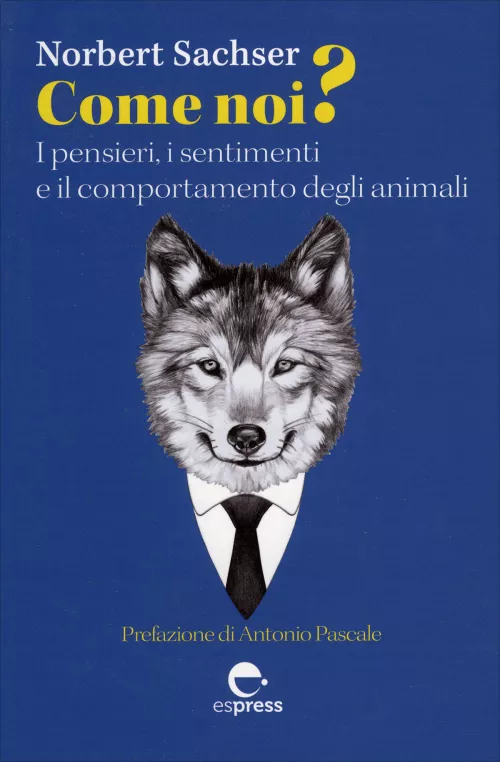La saggezza animale
La distanza tra noi e gli animali si è ridotta. Ma le somiglianze che si riscontrano nei geni, nell’organizzazione del cervello e nella funzione del sistema endocrino possono portarci a dire che esistono punti di contatto nel pensiero, nei sentimenti e nel comportamento? Per lo zoologo e biologo comportamentale tedesco Norbert Sachser, la risposta sta in quella domanda che costituisce il titolo di un suo saggio del 2018, Come noi?, pubblicato ora in Italia dalle edizioni Espress con la traduzione di Francesco Vitellini e la prefazione di Antonio Pascale. L’osservazione scientifica degli animali dimostra che la risposta a quello che per ora è ancora un interrogativo, potrebbe essere affermativa. Gli animali, in particolare i mammiferi, hanno molti punti di convergenza con gli esseri umani. Ma si potrebbero anche ribaltare i termini della questione: noi umani siamo animali e, inevitabilmente, gli assomigliamo. Quanto la scienza ci dimostra comunque è la complessità della vita animale, la sua profondità. Sembra lontanissima l’epoca in cui si sosteneva che gli animali non pensavano, erano, diceva Heidegger, “poveri di mondo”; ma il primo studio ad affermare il contrario è Animal thinking di Donald Griffin, pubblicato nel 1984. E Konrad Lorenz, negli anni Settanta, sosteneva che dal punto di vista scientifico nulla si poteva affermare sulle emozioni degli animali. Solo quarant’anni fa, insomma, sapiens era ancora saldamente separato dagli animali. Soltanto la nostra vita sembrava possedere ramificazioni profonde, chiamava in causa il vissuto, alternava periodi di crisi a fasi di benessere, si nutriva di emozioni, e, in particolare, era in grado di esercitare il pensiero, servendosi del linguaggio. Ebbene, Sachser può essere un utile strumento per mandare a gambe all’aria ognuno di questi ex-punti fermi, che, sotto i colpi della ricerca sperimentale, si riempiono di crepe, o, addirittura, vanno in pezzi.
Il primo argomento che affronta è il rapporto tra gli animali e lo stress. Sachser sottolinea l’importanza dell’ambiente. Se è instabile – come frequentemente capita nella stagione riproduttiva – gli animali sociali allo stato selvatico ne soffrono con evidenza. Negli animali affidati all’uomo lo stress invece si manifesta quando la composizione del gruppo di appartenenza viene costantemente modificata. Ad esserne esposti sono soprattutto i dominanti che devono rinegoziare la loro posizione rispetto ai nuovi membri. Quanto appare certo è che l’esperienza sociale precedente influenza profondamente lo stress, che, invece, può essere attenuato con la presenza di conspecifici, come accade con l’amicizia tra gli umani. Detto altrimenti: tra i mammiferi che vivono in un gruppo il presente ha radici nel passato. Gli animali non sono piatte figurine senza profondità, ma creature con una storia. È un aspetto che affiora con evidenza parlando del benessere e delle emozioni animali. La sperimentazione ha chiarito che per stare bene l’animale deve avere la possibilità di imparare attraverso il gioco, che, a sua volta, necessita di un ambiente rilassato e tranquillo. Ancora una volta non è indifferente la qualità di quanto circonda gli animali. Quelli che vivono in un ambiente strutturato e variegato infatti sono diversi da quelli della stessa specie che si muovono in un ambiente monotono e per nulla strutturato. L’ambiente che favorisce uno stile di vita attivo e vario, in definitiva, è benefico per gli uomini e per gli animali. Se il benessere è compromesso, l’animale non mangia, non beve, trascura l’igiene personale, vive con ritmi giornalieri alterati, presenta comportamenti conflittuali (attività a vuoto, comportamento stereotipato, comportamento di ricerca). A creare situazioni di difficoltà possono essere esperienze traumatiche precedenti, che influenzano il pensiero, determinando le cosiddette “distorsioni cognitive”. Se ha alle spalle trascorsi poco felici, anche un ratto tende ad essere pessimista. Proprio il territorio delle emozioni è quello che presenta più convergenze tra uomini e altri animali. Ma è anche quello che più potrebbe far insorgere equivoci. La sensazione che si stia dalla stessa parte è favorita dal fatto che la parte del cervello responsabile della generazione delle emozioni – il sistema limbico – è molto antica ed è già presente negli antenati non umani, in tutti i mammiferi e in quasi tutti i vertebrati. L’uomo e l’animale hanno le stesse vie nervose per evocare le emozioni di base. Le cellule nervose ricorrono alle stesse sostanze messaggere per comunicare tra loro. Gli stessi geni sono attivati e disattivati per regolare gli stati emotivi. Esiste, per esempio, una perfetta corrispondenza tra uomo e altri animali per emozioni quali la paura e l’ansia. Il punto dolente è che è poco conosciuto il modo in cui il nostro cervello produce la maggior parte delle altre emozioni. E se, osservando il comportamento degli animali sembra che alcune di queste, come la frustrazione, la gioia e la gelosia, siano simili alle nostre emozioni, bisogna valutare che la stessa emozione può essere espressa in modi del tutto diversi da creature appartenenti a specie diverse. È indubbio, comunque, che, sul piano evolutivo, le emozioni per tutti i viventi rispondano alla stessa necessità, aiutino a sopravvivere e a riprodursi, cioè ad adattarsi meglio agli habitat. Quindi esistono emozioni comuni – per esempio tra i mammiferi – ed emozioni specifiche per chi vive in un determinato ambiente.
Un comportamento complesso si forma grazie all’alternanza fra istinto e apprendimento. L’istinto ha da sempre identificato il comportamento animale, ridotto a una serie di azioni dettate da scarsa coscienza. Ma anche negli uomini ci sono reazioni innate a stimoli chiave. La cura dei neonati, per esempio, viene stimolata dai segnali infantili – il principale è la rotondità del volto – che attivano il nucleus accumbens, la regione del prosencefalo basale, conosciuto come centro di ricompensa (è la stessa area che si attiva con le dipendenze). I segnali infantili sono caratteristici di molti animali, nella relazione uomo-cane sono addirittura decisivi. Più che di istinto oggi si parla di geni, che non determinano ma influenzano il comportamento, in parallelo all’ambiente, che è addirittura in grado di modificare la struttura di alcuni geni (viene definito il cambiamento epigenetico del genoma). In tale direzione un ruolo chiave è quello dell’apprendimento, strettamente legato alla memoria, che permette di adattare il comportamento alle condizioni ambientali ed è già presente in invertebrati semplici come i nematodi e i parameci. il processo di apprendimento più semplice è l’assuefazione o abituazione, con la quale non si apprende una nuova reazione comportamentale ma se ne perde una già esistente, imparando ad evitare i comportamenti superflui, a risparmiare energia e a concentrarsi sugli aspetti essenziali della vita. Ma è rilevante anche l’apprendimento associativo (reso celebre da Pavlov), con cui si abbina una ricompensa a uno stimolo condizionato.
Un terreno particolarmente scivoloso è quello della sfera cognitiva. Qui sapiens sembra possedere capacità da cui gli animali sono esclusi. Ma è davvero così? Il celebre esperimento dello specchio, in cui l’animale vedendosi riflesso cerca di togliersi il segno che il ricercatore gli ha lasciato sul volto o sul corpo, dimostra che le grandi scimmie, gli elefanti, i delfini e le gazze si riconoscono, possiedono quindi un’autocoscienza del proprio corpo. I corvidi e le grandi scimmie fanno anche di più, hanno una teoria della mente, cioè sanno che anche altre creature possono avere pensieri. Il fatto che i corvidi, che non possiedono la corteccia cerebrale, abbiano raggiunto lo stesso livello cognitivo delle grandi scimmie, dimostra che si è verificata una evoluzione parallela dei due gruppi di animali che, sul piano evolutivo, si sono separati 300 milioni di anni fa. In pratica lo stesso risultato è stato raggiunto percorrendo due strade diverse. Si tratta di una scoperta che lascia aperte molte implicazioni sulla spinosa questione dell’intelligenza, che si è evoluta in modo indipendente nelle diverse specie. Sachser spiega che le prestazioni cognitive elevate aiutano ad adattarsi alle condizioni ambientali. Ma il grado di adattamento si riflette nella sopravvivenza e nella riproduzione degli individui e non nel livello delle loro prestazioni cognitive. In altre parole, l’intelligenza, che per noi umani è tutto, non è così rilevante a livello evolutivo.
Per molti aspetti sorprendente è anche la scoperta delle talvolta profonde differenze caratteriali e comportamentali di membri della stessa specie, qualità che davvero si pensava fosse solo umana, anzi addirittura era individuata come il principale elemento di discrimine tra noi e la generica schiera degli “animali”. Invece ciascun animale possiede la sua personalità. Si è notato che minime differenze nei contatti sociali portano a marcate differenze nel comportamento. Notevole è la centralità della prima infanzia, in cui giocano un ruolo decisivo il rapporto con la madre e con i compagni di gioco. Studiando le cavie, si è dimostrato, per esempio, che le madri che vivono in un ambiente sociale instabile durante la gravidanza hanno figlie mascolinizzate e figli maschi infantilizzati. Questi comportamenti sono adattamenti indotti dalla madre. In un ambiente instabile è preferibile avere una figlia robusta e assertiva, mentre in un ambiente stabile non c’è vantaggio ad essere dominanti. Il comportamento infantilizzato dei maschi invece segnala al membro dominante che non si è un rivale. Altri studi hanno evidenziato che ridotti rapporti tra la madre e i figli portano questi ultimi ad essere timorosi e cauti. Ma lo sviluppo del comportamento non avviene in modo unilaterale, i piccoli influenzano i loro conspecifici. Alla definizione del comportamento concorrono anche le esperienze che gli animali fanno durante l’adolescenza. Se in questa fase l’animale non si confronta con i suoi simili non impara la subordinazione. In età adulta qualche modifica comportamentale è possibile, ma non è facile metterla in atto, per cui tendenzialmente il comportamento si stabilizza, anche se non può adattarsi completamente in modo ottimale a ogni situazione.
L’obiettivo di ogni specie è massimizzare il proprio successo riproduttivo. La legge di natura è allora l’egoismo? E come valutare i comportamenti apparentemente altruistici? Lorenz sostenne la teoria della sopravvivenza della specie. A metà degli anni Sessanta il biologo inglese William Hamilton propose un’altra idea. Ci si aiuta tra parenti. E l’egoismo non è cancellato. I genitori attraverso i discendenti aumentano la percentuale dei loro geni nelle generazioni future. Ma non si può dimenticare che per trasmettere alle generazioni successive copie dei propri geni con la massima efficienza si può arrivare a minacciare e a uccidere gli appartenenti alla propria specie. L’infanticidio è un evento regolare nelle scimmie, nei roditori e nei predatori come i leoni africani. Insomma, il “dogma dell’etologia classica” secondo cui gli animali non uccidono i propri simili è un mito. Così come è un mito l’idea della passività delle femmine nella selezione sessuale. Le femmine scelgono il proprio partner.