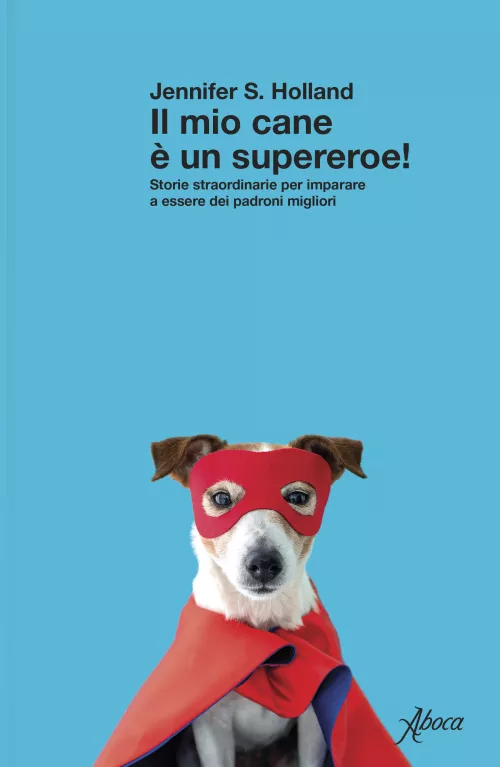Quel supereroe d'un cane
Perché si pensa che un cane sia intelligente? La maggioranza di noi risponderebbe perché ci capisce. E se ci chiedessimo qual è il limite della sua intelligenza? Probabilmente penseremmo all’assenza del linguaggio, a quel “gli manca solo la parola” che appartiene alla categoria dei più ferrei luoghi comuni sui cani. Le due risposte, come scrive la giornalista scientifica Jennifer S. Holland, in Il mio cane è un supereroe!, edito da Aboca con la traduzione di Stefano Chiapello, pur non essendo entrambe accettabili, condividono un aspetto: se del cane percepiamo l’intelligenza è perché questa entra nelle nostre vite, per eccesso o per difetto. Difficilmente, con l’esclusione del gatto, saremmo disposti senza batter ciglio a concedere quote di intelligenza ad altre specie animali. Ora è evidente che questo atteggiamento è un limite, reputiamo i cani intelligenti perché ci assomigliano. Ciononostante, non è soltanto un fraintendimento o una proiezione antropocentrica, ma è l’avvertimento, seppur impreciso, di un fatto che è avvenuto e continua ad avvenire: in effetti, il primo indizio dell’intelligenza del cane sta nell’aver costruito una relazione profonda ed ininterrotta con la nostra specie. E che si sia rivelata una soluzione vincente lo dimostra il miliardo di cani presenti sulla terra, di cui 850 milioni sono randagi.
Un successo evolutivo che si spiega solo in un modo: il cane è stato così intelligente da aver moltiplicato la sua presenza, inserendosi nella nicchia ecologica creata dall’uomo. Pet e randagi che siano, i cani stanno con Homo Sapiens, dipendono da noi. La parola spesso usata è allora “coevoluzione”: umani e cani sono cresciuti assieme, fornendosi reciproci rinforzi, come spiega in molti suoi lavori lo zooantropologo Roberto Marchesini. Ma alla radice della relazione, ribadisce Holland, c’è il cane più che l’uomo. Dalla sua parte c’è la predisposizione genetica alla socievolezza unita alla sua capacità di leggerci in profondità, assecondandoci (è la prospettiva che porta a pensare al cane che addomestica l’uomo). Lo strumento della relazione, in qualche modo il suo simbolo, è lo sguardo. I cani, a differenza dei lupi, hanno imparato a guardarci. E non smettono mai di farlo. Lo scambio di sguardi dà piacere al cane ed è probabilmente il motore della collaborazione, lo spunto d’avvio sia dell’impulso epimeletico umano, ovvero della nostra predisposizione all’accudimento, sia della cooperazione durante la caccia.
Se è stato il cane a venirci incontro – una volta separatosi dall’antenato comune con il lupo, Holland ritiene poco probabile che l’uomo abbia direttamente addomesticato gli esemplari più docili di lupo – la conseguenza è che, sin dai primordi, la relazione è sbilanciata. Quindi il cane ci capisce benissimo, forse sa di noi quello che noi ancora non sappiamo, ma non si dà il contrario: facciamo fatica a comprendere i cani, o meglio, cerchiamo di farlo applicando loro metri di valutazione esclusivamente umani, misurandone qualità e intelligenza sempre in rapporto a paradigmi ed esigenze della nostra specie. Risultato: mentre i cani hanno imparato a destreggiarsi “tra l’essere cani e l’essere i nostri cani”, noi non abbiamo ancora compreso in modo adeguato le caratteristiche di chi abbiamo in casa, tendiamo a sottovalutarlo. Con due ulteriori epifenomeni: non cogliamo tutte le opportunità che una migliore comprensione del cane potrebbe offrirci e non diamo al cane la possibilità di essere compiutamente cane. Leggendo il libro di Holland l’impressione è di essere all’inizio: a ben vedere, nella prospettiva dell’evoluzione, quindicimila anni – grossomodo il tempo della convivenza tra le due specie – sono un soffio. Dopo millenni di fraintendimenti, insomma, la nostra relazione col cane può svoltare. Il cane non è un minus habens che, se va bene, esegue quello che gli chiediamo per poi ricadere nella sua irredimibile ferinità, ma è un essere vivente complesso e per molti aspetti geniale. E forse da questo punto fermo potrebbero derivare conseguenze utili per acquisire altre prospettive sulla vita. Ma, ripetiamolo, l’impressione è di aver appena iniziato questo cammino.

La strategia per farci comprendere le potenzialità del cane adottata da Holland consiste nel mostrarci di cosa sono capaci alcuni di loro, quei cani-specialisti che si dedicano ad attività delicatissime, rivelando la loro “multiforme intelligenza”. La rassegna è vasta. Ci sono i cani che collaborano con gli scienziati, arrivando a sottoporsi a risonanza magnetica; i cani guida, “intelligenti a sufficienza da smettere di fidarsi del loro padrone se questo si mostra incoerente” e capaci di leggere il linguaggio del corpo del padrone, ma anche “i suoi segnali gestuali e il suo tono di voce”; i cani di polizia ed esercito, che, attraverso autocontrollo ed obbedienza, devono imparare a mordere a comando, esercitando l’istinto predatorio e di difesa contro l’uomo; i cani per la tutela ambientale, addestrati, tra l’altro, per la sorveglianza delle specie in via di estinzione; i cani adibiti alla ricerca di cadaveri (anche risalenti a millenni fa) che rintracciano i resti a partire da frammenti minimi di tessuto umano; i cani che, sempre servendosi dell’olfatto, sono in grado di scoprire malattie, come il cancro, il Parkinson, il diabete, l’Alzheimer; i cani adibiti alla pet-therapy.
Si tratta di “supereroi”, come li definisce Holland? Questi cioè sono esemplari unici che sfuggono alla media? Probabilmente sì, visto che ogni individuo è diverso dall’altro. Ma il ragionamento da fare è un altro. Quanto si nasconde dietro all’apparente semplicità dei cani? Cosa sono capaci di fare se fatti crescere, sviluppare e vivere in equilibrata relazione con gli esseri umani e con la loro “caninità”? Probabilmente le potenzialità ci sono ancora ignote, vincolati come siamo allo stereotipo dell’animale fedele ma in fondo inferiore, da addestrare con le maniere forti se si vuole ottenere qualcosa, da compatire per i suoi limiti, da tenere sotto chiave se si vuole evitare che faccia danni, da escludere da certi momenti della nostra vita. Il passaggio da compiere consiste nell’imparare a conoscerli meglio, a partire dalla certezza che cani hanno la capacità di apprendere “qualunque cosa in qualunque circostanza”. È però necessario agire andando loro incontro. Così, da cuccioli, devono essere subito esposti a qualunque stimolo per evitare che una volta adulti siano vittime di paure e di ansie paralizzanti; nell’addestrarli bisogna evitare le “metodologie avversive”, meno efficaci di una strategia ad incentivi e, soprattutto, è bene procedere con gradualità. È inoltre importante capire che i cani vogliono riuscire in ciò che fanno e che talvolta i limiti sono degli addestratori che devono imparare meglio il loro linguaggio. Non si deve perdere di vista, per esempio, che il cane, come l’uomo, cerca di controllare il suo ambiente, per cui ha bisogno di affrontare sfide e di prendere decisioni. Peraltro non si può dimenticare che i cani raccolgono informazioni sull’ambiente in modo diverso da noi. Il loro apparato sensoriale non è il nostro, hanno una diversa sensibilità a suono e luce, colgono i cambiamenti d’aria con le vibrisse, cuscinetti e pelle tra le dita sono eccezionalmente sensibili; le papille gustative in fondo alla gola e sulla punta della lingua consentono loro di percepire anche il sapore dell’acqua. Soprattutto dispongono di un apparato olfattivo che non ha confronti con quello umano. È il naso che dà senso alla vita del cane, permettendogli di socializzare, di avere la percezione dello spazio e del tempo, perfino la coscienza di sé. Quanto i sensi colgono viene poi elaborato dal cervello del cane secondo modalità e procedure che non coincidono con quelle degli uomini. Di fatto, quindi, dobbiamo rassegnarci: il modo in cui il cane vede la stessa fetta di realtà in cui conviviamo, non ha punti di contatti con il nostro. Ciononostante il cane non se ne sta chiuso nella sua Umwelt. Il cane “vuole che tu sappia quello che sa lui”. Vuole condividere, creare un legame. Ed è il legame con noi che “ha plasmato il (suo) modo di sentire e quello che (sente) per noi”, sviluppando l’intelligenza emotiva. Holland insiste su un aspetto: il cane vive nella relazione con gli altri, che si tratti di uomini, altri cani o altri animali: è così che si manifesta l’intelligenza sociale, affidata al linguaggio corporeo, strutturata attraverso il gioco e basata sulla capacità di “leggere gli stati mentali” (i cani hanno una “teoria della mente”). Appare quindi decisamente fuorviante ridurre le potenzialità del cane perché non dispone di linguaggio verbale. Tutto, in realtà, nel cane è linguaggio. Come scrive Holland, il cane comunica “con le orecchie, con la posizione della mascella e delle labbra, con la direzione dei baffi, e scoprendo o meno i denti”; ma comunica anche con le espressioni facciali, gli occhi, il respiro, la coda. E poi ovviamente si serve di abbai (ce ne sono di varie tipologie a differenza dell’unico abbaio, sempre uguale a se stesso, che ha a disposizione il lupo), di ululati e di guaiti.
Di fronte a questa ricchezza, a questo stratificato apparato di possibilità, che cosa è “storicamente” successo? La nostra pressione sul cane, la sua (consenziente) trasformazione in nostro aiutante, ha compromesso la sua capacità di relazione, ovvero ha intaccato quanto più lo caratterizza, riducendone il cabotaggio. Il libro di Holland, costruito attraverso un fitto intreccio di incontri con scienziati e specialisti del settore, si chiude tracciando un ventaglio di strade percorribili. In un mondo dove il cane è sempre più presente sarebbero necessarie tre nostre azioni: apprendere da lui stili di vita (dal recupero dell’espressività fisica e delle potenzialità di sensi come l’olfatto ad accettare il prossimo senza pregiudizi); metterlo nella condizione di poter esprimere al meglio la sua intelligenza, addestrandolo, facendo “cose” insieme a lui, ma lasciandolo anche libero di “fare il cane” (non gli si può togliere il piacere e la necessità di annusare), e, soprattutto, offrendogli l’occasione di incontrare i suoi simili; ed infine, ma si tratta della condizione che sta a monte di tutto, non bisognerebbe mai cessare di “avere curiosità intellettuale per la (sua) vita interiore”.