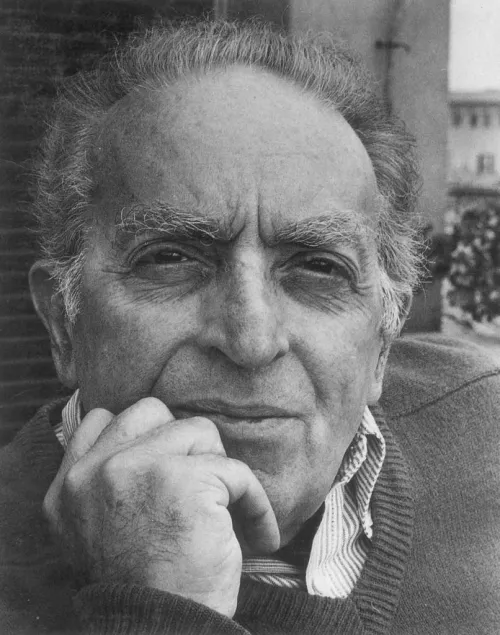L'arte della ritrattazione / Luigi Malerba. Pensare confonde le idee
Ogni tanto compare una Beretta calibro sette e sessantacinque nei racconti e nei romanzi di Malerba. A fare il gesto di impugnarla, o ad essere tentati di usarla, sono personaggi che stanno perdendo la pazienza per ragioni anche banali ma importantissime per il loro equilibrio psichico; personaggi consumati psicologicamente da una loro mania o esacerbati dall’andazzo del mondo che gravita intorno a loro, rappresentato e governato da politici corrotti e infami. All’apparenza sono professionisti seri o funzionari che occupano posizioni di rilievo. Nel Serpente è un commerciante di francobolli a munirsene per regolare i conti con la propria moglie (che non esiste) e per farle capire che anche lui ha i suoi ideali da difendere e che è perfettamente in grado di agire indipendentemente da lei. In Dopo il pescecane, nel racconto omonimo, è l’amministratore delegato di una grande società di costruzioni a tenerla a portata di mano dentro il cassetto della sua scrivania: nonostante egli sia stato proposto per la nomina a Cavaliere del Lavoro, si trova sempre sul punto di cedere alla tentazione di farne uso ogni volta che davanti a lui, dall’altra parte della scrivania, compare un architetto. Nel Pianeta azzurro il protagonista è un ingegnere idraulico che progetta pompe e dirige il Settore della Sperimentazione sul Vuoto in una multinazionale ed è fermamente deciso a scaricarne il caricatore su un eminente e potentissimo uomo politico italiano che è allo stesso tempo l’incarnazione di tutti i mali e il delinquente più pericoloso del Paese. Questi solo per citare alcuni esempi. In Salto mortale, essendo il protagonista un robivecchi, anche l’arma risente della classe sociale d’appartenenza del suo proprietario e torna ad essere quella dei vecchi tempi, ossia il coltello. Ma è sempre simbolica di un meccanismo che sta per esplodere o di un cortocircuito mentale, e funziona ogni volta come proiezione visualizzata di un desiderio omicida il quale, nell’essere frutto di un sentimento di odio, ambisce a nobilitarsi in quanto portatore di un cambiamento, dato che, come si afferma nel Pianeta azzurro, solo “chi odia vuole cambiare qualcosa”.
Certo non si può dire che quelli di Malerba siano personaggi rappacificanti, adatti alle letture amene che il pubblico di oggi sembra prediligere, e nemmeno che possano rispecchiare le ambizioni di lettori e lettrici in cerca di facili gratificazioni culturali che molto opportunamente vengono offerte loro da tutti quegli autori malati di letteratura che hanno sempre buon gioco quando si tratta di abbindolare i polli. Ma anche ammettendo che questi personaggi in buona parte siano classificabili come mitomani e paranoici e che le loro storie siano tutto fuorché resoconti oggettivi di fatti avvenuti, e spesso anzi si trasformino con improvvise accelerazioni in attacchi deliranti, per cui ci si guarderebbe bene dall’identificarsi in loro, non si può negare invece che è proprio questo che succede, forse perché evidentemente un po’ paranoici e mitomani lo siamo tutti, tanto che alla fine risulta impossibile non provare un forte sentimento di empatia per loro. Ed è anzi proprio per questa singolare attitudine che Malerba ha di frugare nella mente scardinata di mitomani e paranoici e nel riprodurne il funzionamento attraverso un linguaggio aderente allo scopo, che egli è non solo lo scrittore italiano più originale della seconda metà del Novecento, ma anche il più geniale e uno dei pochi a poter reggere il confronto con altri grandi della stessa epoca, come Samuel Beckett e Thomas Bernhard, coi quali oltretutto egli condivide la concezione – frutto di un’intuizione modernissima e tipicamente novecentesca – del testo narrativo inteso come espressione di un assillo persecutorio e l’idea che la maniacalità ossessiva con cui l’oggetto di tale assillo viene fatto proliferare, per essere poi alla fine tolto di mezzo tramite un’implosione, sia il modo più efficace di dire una verità non prevedibile, e quindi non facilmente neutralizzabile o normalizzabile, su quella che con grande cautela e magari ponendola fra mille virgolette potremmo definire realtà.
Tutto questo era già evidente nel primo romanzo di Malerba, Il serpente, e addirittura, anche se potrebbe sembrare un’esagerazione, nella frase d’apertura che dà il titolo al primo capitolo e che dice: “GLI UCCELLI VOLANO IO INVECE MI AVVIAI A PIEDI VERSO LA STAZIONE DELLE FERROVIE”. Qui è già presente la peculiarità della voce narrativa di Malerba, la quale poi si sarebbe acuita sempre più nel corso degli anni e anche quando sarebbe stata sottoposta a un processo di normalizzazione, come si avverte nella prosa delle sue ultime opere, sarebbe comunque rimasta sempre riconoscibile. In questa frase la sfasatura temporale prodotta dai due tempi verbali che stando alla presenza dell’avverbio connettivo “invece” avrebbero dovuto suggerire l’idea di due azioni simultanee e la mancanza di punteggiatura non stanno a indicare una semplice violazione grammaticale, ma un modo di caratterizzare il proprio rapporto col mondo da parte dell’io in questione e di lasciare intendere in maniera fulminea quanto questo rapporto sia conflittuale e per nulla pacifico; oltre naturalmente a definirsi in maniera originale come voce narrativa. Il protagonista del romanzo, infatti, un commerciante di francobolli che è ossessionato dall’idea di voler volare (e per questo come persona tende verso l’alto) e che odia “tutti gli uomini ad eccezione di una donna”, dice parecchie cose nel corso del racconto che poi ritratta ammettendo di aver mentito al loro riguardo: ad esempio che era sposato quando non lo era, di essere stato in guerra quando invece in guerra non c’è mai stato, di non sapere cos’è la gelosia quando tutte le sue azioni, compresa quella finale di compiere un atto di cannibalismo sulla donna da lui amata, Miriam, sono scaturite da una forma maniacale e abnorme di gelosia. Abnorme perché questa gelosia non solo non avrebbe motivo di sussistere, dato che nulla nel comportamento della donna la giustificherebbe, ma proprio perché è la donna stessa a non esistere, essendo solo il frutto della fervida immaginazione di lui. Ci si chiede dunque di cosa tratti il libro, visto che abbiamo un io narrante mentitore e diversi personaggi che sono solo invenzioni, parti mentali che non hanno una vera consistenza.
Be’, proprio qui sta la grandezza di Malerba, nella sua capacità di attirarci dentro a una storia senza nemmeno utilizzare i mezzi più canonici della finzione e di cui la finzione necessiterebbe per rendersi credibile. Per cui, la trama, diciamo così, di superficie del romanzo si risolverebbe nella vicenda del protagonista narratore che, sconvolto da un potente sentimento di gelosia verso una donna che ha conosciuto frequentando una corale e di cui si è innamorato follemente, decide di ucciderla e di divorarla, per poi autoaccusarsi del delitto – cosa per cui alla fine verrà spedito in manicomio anziché essere processato, dato che questa donna non è mai esistita. Ma poiché Malerba presenta questa situazione facendola evolvere solo negli stati alterati di coscienza del suo protagonista e nei suoi movimenti di pensiero, dato che i fatti di cui essa si compone vengono narrati, sì, ma anche negati e dunque privati di una verità realistica, fattuale, la vera trama del romanzo alla fine risulta essere, come ha acutamente osservato Angelo Guglielmi, la sua stessa struttura, la funzione del pensare, cioè il meccanismo del cervello umano, sfruttato nell’interezza della sua potenzialità operativa. “Potenzialità – scrive Guglielmi – il cui punto di maggior esaltazione coincide con il punto di nullificazione della realtà fattuale”, e da ciò vien fatto risultare che la realtà “è una potenzialità, non una effettualità. Anzi, l’effettualità nella misura in cui realizza la potenzialità la limita e la distrugge. Insomma la realtà non sono i fatti che accadono ma forse sono i fatti che non accadono. Soltanto quello che può accadere e non accade è la garanzia dell’inesauribilità del reale e quindi del suo valore” (Vero e falso, Feltrinelli 1968, p. 159).
C’è da dire che questa continua ritrattazione da parte del narratore, questo suo modo di dire e disdire o di cadere spesso in contraddizione, che sarà un tratto distintivo anche degli altri due maggiori lavori di Malerba, Salto mortale e Il pianeta azzurro, – e che è sicuramente uno dei grandi pregi della sua tecnica – non compromette per nulla il godimento della lettura dei suoi testi, ma semmai ottiene l’effetto opposto di ingenerare un maggior interesse proprio perché, appellandosi a una forma inedita di sospensione dell’incredulità, agisce sul lettore come una notevole forza propulsiva in aggiunta a quella di eccellente favolista che già di per sé Malerba possiede in abbondanza. In fondo si tratta di un espediente tecnico simile a quello che anche Buñuel avrebbe sperimentato nel suo capolavoro Il fascino discreto della borghesia, con la differenza che nel film la ritrattazione è meno evidente in quanto consiste di volta in volta nel risveglio da parte dei vari personaggi da una serie di sogni a scatola cinese in cui ognuno di loro sogna l’altro alle prese con situazioni e fatti angosciosi e di estremo pericolo; per cui a risentirne risulterà essere la trama, o la storia, che da un certo punto in poi non progredisce più, dato che quello che avviene nei sogni dei personaggi non avviene sul piano narrativo vero e proprio del film, ma appunto solo a livello onirico, anche se poi è proprio in questi fatti inesistenti e mai successi che si sviluppa con grande forza il discorso critico del regista (ossia la condanna del clero, della borghesia e delle forze armate).
Questa tecnica narrativa, come s’è detto, viene ulteriormente messa a punto da Malerba in Salto mortale. Qui il protagonista è un robivecchi, Giuseppe detto Giuseppe, che sostiene di aver trovato, in aperta campagna, il cadavere di un uomo sgozzato con un coltello, accanto a una bicicletta nera, vicino a punto chiamato Torre Medievale, nella pianura fra Roma e Latina; e poiché gli sembra di aver capito che la polizia non si dà molto da fare per risolvere il caso, comincia a svolgere un’indagine di sua iniziativa per trovare l’assassino. Sennonché nei suoi sproloqui e nei suoi dialoghi con la donna amata o con la voce della propria coscienza egli comincia a lasciarsi maldestramente sfuggire di bocca certi particolari che farebbero presumere che possa essere stato lui l’assassino, cosa che poi in effetti risulterà esser vera, dato che tutti i sospetti alla fine convergeranno su di lui, trasformandolo da investigatore a ricercato, da innocente a colpevole, come già poco prima egli stesso aveva involontariamente ammesso, dicendo che “ci sono molti tipi di innocenti, ci sono degli innocenti che meriterebbero vent’anni di galera”.
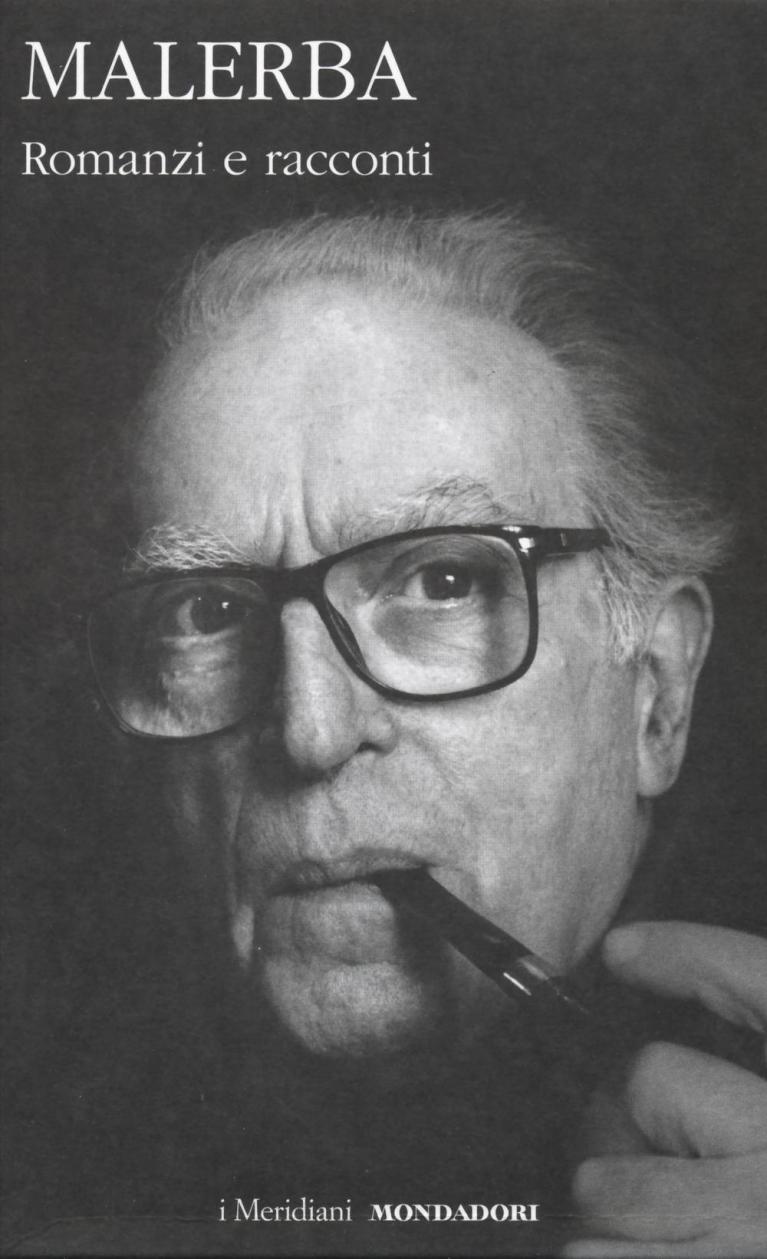
Questa trasformazione del personaggio narrante nell’opposto di ciò che egli vanamente cerca di convincerci di essere sembra trovare un riflesso anche sul piano linguistico, nel modo in cui alcune le frasi vengono costruite da un certo punto del romanzo in poi, quando ad esempio lo stesso elemento che nella frase costituisce il complemento oggetto diventa soggetto nella continuazione della frase stessa (ad esempio: “Non vedo i muratori non ci sono”). E questo solo per accennare di passaggio a una delle numerosissime invenzioni linguistiche presenti nel testo, che da questo punto di vista richiederebbe un’attenzione molto particolare, dal momento che esso si presenta come uno dei più riusciti esempi di stilizzazione del parlato e per questo andrebbe considerato come l’antesignano di quel filone della narrativa italiana che ha fatto dell’oralità, delle sue risorse strutturali e sintattiche, il punto di forza nell’elaborazione di uno stile molto diretto ed efficace, e di una lingua letteraria che, come è stato detto, non finge di non esser scritta e non teme di sembrare parlata. In Salto mortale, poi, abbiamo un’esposizione quasi in forma di campionario di tutti quei costrutti sintattici al limite della sgrammaticatura, come certe forme di anacoluto (“Gli uomini per me ci sono soltanto le mosche”), o ellittiche (“C’è poco da ridere, i cinesi”), o certe inversioni della linea sintattica (“Lo teneva nascosto nel palmo della mano, un coltello, voleva ammazzarmi con il quale”), e di altri espedienti tipici del parlato, come le legature col che polivalente, la combinazione di una preposizione e di un articolo partitivo, la sconcordanza grammaticale, periodi ipotetici semplificati e l’adozione dell’imperfetto a tempo narrativo, mischiato al passato prossimo e al presente, e usato anche nei verba dicendi. Anche le parti dialogate, infatti, risentono del modo in cui esse si dispongono a livello orale, dal momento che le battute non sono separate da segni di punteggiatura o virgolette, ma vengono risucchiate all’interno del flusso narrativo e il più delle volte in un’unica frase troviamo, in forma diretta, quello che un personaggio dice, quello che risponde un secondo personaggio e la ripresa in forma indiretta di ciò che ha detto il primo (come nel dialogo fra Giuseppe e il macellaio di Pavona: “Allora vendete anche il cavallo vendo quello che mi pare vendeva anche il cavallo”).
Si potrebbe obiettare che gran parte di questi espedienti sono presenti nella prosa italiana già a partire dai tempi di Manzoni e Verga, ma la differenza è che qui non vengono usati per dare un tocco o una coloritura linguistica locale alla parlata di certi personaggi, ma contribuiscono, come già s’è detto per Il serpente, a creare la “voce” narrativa e a caratterizzare in maniera istantanea – e molto meglio di quanto non si potrebbe fare con una descrizione – l’identità del narratore, il quale appunto è sia artefice della propria lingua che plasmato dalla stessa. È importante porre in evidenza l’aspetto linguistico di questo romanzo perché in sede critica non viene sottolineato abbastanza l’apporto dato da Malerba alla creazione di una lingua letteraria basata sul parlato, che al contrario è stato fondamentale, mentre ad altri scrittori che semmai sarebbero da considerare per l’adozione ma solo sul piano lessicale di elementi desunti dall’oralità o per l’uso di forme gergali (in particolare giovanili) viene dato uno spazio fin troppo ampio.
Ma che tipo di narratore è quello che si agita nelle pagine di Salto mortale? È sia un parente stretto del commerciante di francobolli del Serpente che una prefigurazione del Demetrio F. che vent’anni più tardi sarebbe comparso nel Pianeta azzurro, ma con in più un’accentuazione del lato paranoico del carattere che si riversa sull’eloquio, scompaginando la sintassi spesso in maniera comica (come estremamente comiche del resto sono anche tutte le digressioni e le divagazioni talvolta inutilmente puntigliose – ma è proprio da questa inutilità e da questa puntigliosità che sorge l’effetto comico – che sostengono l’affabulazione di Giuseppe detto Giuseppe come cuscinetti protettivi che ruotano intorno a un involucro vuoto). Anche in Salto mortale, infatti, la progressione della storia avviene fra continue smentite e ritrattazioni: ogni dato apparentemente acquisito si rivela falso, ogni supposizione contraddetta e lo stesso ritrovamento del cadavere, nel buffissimo terzo capitolo, che segna l’inizio vero e proprio della vicenda raccontata, viene negato assieme a tutto l’insieme di particolari che nell’episodio compaiono come punti descrittivi della campagna in cui il protagonista rinviene il cadavere. È tale poi la mancanza di credibilità da parte del narratore da far sorgere seri dubbi circa l’esistenza stessa del cadavere, dando in questo modo adito al sospetto che il delitto non sia nemmeno avvenuto se non nella sua testa, frutto di una sua elucubrazione mentale, dato che, come poi apparirà chiaro nel resto della narrazione, egli è alle prese con pensieri ossessivi che lo tormentano spingendolo a interpretare i dati della realtà in maniera paranoica, ossia facendogli sovrapporre il soggettivo all’oggettivo; oppure che, se effettivamente il delitto è stato commesso, egli ne sia paradossalmente l’autore, come a un certo punto si è autorizzati a credere, se non addirittura e ancor più paradossalmente non ne sia egli stesso la vittima. Di nuovo dunque siamo alle prese con una vanificazione dell’oggetto narrativo, con una costruzione di parole che ritraggono una realtà di per sé inesistente e che servono solo a mascherare il Nulla. Lo stesso statuto narrativo rappresentato dall’io del protagonista sembra perdere uno dopo l’altro tutti i suoi pezzi: i personaggi infatti che Giuseppe detto Giuseppe incontra e interroga nel suo vano girovagare in cerca dell’assassino – e cioè il macellaio di Pavona, il demoscatore di Albano, il bagnino del Lido di Lavinio – e che lo sorprendono in maniera inquietante perché si chiamano tutti Giuseppe come lui (cosa che glieli rende immediatamente sospetti) finiscono per fare una brutta (o ridicola) fine: il primo infatti annega in venti centimetri d’acqua, il secondo cade giù da un ponte e il terzo viene arso vivo per aver incendiato della nafta galleggiante sul mare.
Uno dei punti di raccordo fra Salto mortale e Il pianeta azzurro riguarda proprio questa elusività della figura del narratore, questo suo eclissarsi e disperdersi assieme al materiale narrativo il quale, come ha osservato Guido Almansi, nel momento in cui viene fatto diventare “oggetto di un resoconto tende a mutarsi, a spostarsi, a diventare un’altra cosa” (La ragion comica, Feltrinelli 1986, p.84), convenendo in questo senso con quanto già aveva rilevato Paolo Mauri, ossia che ad essere vanificato in questi primi romanzi di Malerba è lo spazio letterario, “recuperato in fondo per poterlo negare e nelle sue strutture generali e nelle sue realtà minori”(Malerba, La Nuova Italia 1977, p. 47). Anche nel Pianeta azzurro c’è poca chiarezza riguardo alla vera identità del narratore, benché all’inizio si abbia la certezza di seguire una storia dall’andamento diaristico redatta da un certo Demetrio F., ingegnere idraulico, che ha affittato un appartamento nella località di villeggiatura di Porto Santo Stefano con l’intenzione di compiere un attentato alla vita di un illustre uomo politico italiano corrottissimo e potentissimo e denominato il Professore, che in quella località trascorre le vacanze ospite di un suo compare di intrallazzi e ricatti (il sindaco di una città dell’Alto Lazio). Questa storia a sua volta viene chiosata capitolo per capitolo da quello che inizialmente parrebbe essere il proprietario dell’appartamento affittato da Demetrio, il quale sostiene di aver trovato i tre quaderni contenenti i diari di quest’ultimo in uno scaffale della libreria e che nella finzione si potrebbe supporre essere l’autore stesso, Luigi Malerba; cosa che però viene smentita nella prima delle due appendici al romanzo, intitolata Nota dell’Autore, nella quale appunto compare inequivocabilmente il vero Malerba che racconta di come tutto il materiale contenuto nel libro da noi appena letto gli sia stato consegnato da uno sconosciuto che aveva suonato alla sua porta. Trattandosi di uno scrittore come Malerba, per il quale raccontare è sempre un’organizzazione della menzogna, memore forse dell’adagio beckettiano “telling stories is telling lies” (raccontare storie significa raccontar balle), bisognerebbe dubitare anche del fatto che, presentandosi come se stesso, Malerba intendesse proprio se stesso, ma questo ha scarsa rilevanza per il momento.
Quello che importa è la dissolvenza verso cui sembrano dirigersi i due narratori che si alternano in questo romanzo il quale proprio nel momento in cui sembra spegnersi riesce a trovare un’impennata improvvisa nelle pagine finali dove, non solo viene a compiersi l’atto che era stato programmato provato tentato immaginato desiderato per tutto il romanzo e a cui poi infine si era rinunciato, ossia l’uccisione del Professore, ma a tingere di mistero la vicenda stessa di Demetrio F., dato che inizialmente ci era stato detto che egli era sparito lasciando appunto dietro di sé i tre diari e poi che era morto di infarto, mentre alla fine lo vediamo ricomparire dall’altra parte del mondo, in Nicaragua, dove casualmente era entrato in contatto con una persona che l’autore (Malerba) aveva conosciuto altrettanto casualmente e di cui era diventato amico.
Come si vede, il romanzo ha una struttura non semplice, tipica di un’epoca in cui era ancora vivo lo spirito dello sperimentalismo e in un certo genere di romanzi il piano metanarrativo poteva entrare in forte competizione con le parti occupate dalla narrazione diretta degli eventi di una storia, quanto a presa sul lettore. In questo romanzo in particolare, poi, in cui l’odio spesso si sostituisce all’autore stesso nel redigere le pagine, l’intrigo si complica a livello di trama ma è anche parte del modo in cui evolve la nostra conoscenza dei personaggi. Di Demetrio, ad esempio, che sappiamo alle prese con l’ideazione di un piano per assassinare il Professore, capo segreto della Supermassoneria (chiamato anche il Grande Vecchio, il Burattinaio, la Testa del Serpente, Belzebù) – e sono parecchi i punti in cui egli criminalizza questa potentissima organizzazione – veniamo poi inaspettatamente a sapere, tramite il chiosatore, non solo che pure lui, Demetrio, fa parte della Massoneria (e un ampio spazio qui sarà dedicato al minuzioso e dettagliato racconto del rituale d’iniziazione a cui egli si era sottoposto per esservi ammesso), ma anche che a un certo punto egli accantona il piano di assassinare l’odiato Professore (la realizzazione del quale sembrava fosse per lui una questione di vita o di morte) per progettare invece l’uccisione della propria moglie e del suo supposto amante (un architetto fiorentino) colpevoli di aver imbastito una tresca amorosa che ha però tutta l’aria di essere solo frutto di un suo delirio di gelosia. D’altra parte è proprio l’ambigua e contraddittoria condotta del personaggio di Demetrio a fare del Pianeta azzurro uno dei romanzi più audaci di Malerba, “un romanzo giallo, con attentato, assassinio, investigatore e tutto l’apparato di contorno che suscita la curiosità del lettore; un romanzo politico con trame nere, corruzione, massonerie, intrighi, riferimenti alla cronaca politica, che assuma una partecipazione attiva da parte di un lettore simpatizzante; tutto per trascinare questo sventurato lettore in un’avventura sulla soglia del vuoto assoluto, che è la metafora centrale del romanzo” (Guido Almansi, Op. cit., p. 74).
Concetto, questo, che viene elaborato anche da Walter Pedullà, uno dei maggiori esperti dell’opera di Malerba e autore dell’Introduzione al Meridiano di recente pubblicazione, quando scrive: “È il vuoto alla fine il qualcosa che i vari livelli delle parole hanno nascosto. Un vuoto dentro il quale sono attirati e bruciati tutti i significati di volta in volta imposti sulla superficie in cui agiscono come parole della società, della cultura, della politica, della religione, della scienza. In quel vuoto c’entra tutto, ogni parola, ogni significato, ogni pensiero, ogni linguaggio, ogni personaggio, ogni storia (…) Nessun’altra storia può essere raccontata se non quella che racconta a partire da quel vuoto: che però è anche la conclusione di ogni vicenda umana” (Storia generale della letteratura italiana, Vol. XV, Motta Editore 2004, p. 294).
Questo vuoto, o Nulla, è anche il centro delle riflessioni che i due (o presunti due) personaggi narranti del Pianeta azzurro svolgono a seguito delle letture filosofiche – Platone, Plotino, ma anche lo scrittore francese Michel Tournier (Il re degli ontani) – che essi compiono nella biblioteca del paese, il primo, Demetrio, per cercarvi una giustificazione morale all’atto che egli ha intenzione di compiere (l’assassinio del Professore), e il secondo per capire un po’ meglio i contorcimenti mentali del primo, ossia se quella contenuta nei suoi quaderni è la storia di un omicidio premeditato o di un’ossessione, nutrita com’è di allucinazioni paranoiche e prefigurazioni di morte che, oltre a esprimere il timore di venire risucchiati nel Nulla, sarebbero indicative, nell’interpretazione di uno psichiatra a cui vengono mostrati i diari, di “una profonda disperazione ontologica”. Disperazione però che risulterebbe eventualmente attenuata dalla giustezza e dalla naturalezza del proposito omicida, dal momento che il gesto di uccidere, come scrive Demetrio in una delle sue riflessioni, è naturale e la Storia non l’ha abolito, “ma l’ha soltanto circondato di molte parole, lo ha coperto con i rifiuti della saggezza e con il pulviscolo della morale”. Questo gesto però viene continuamente procrastinato e sostituito almeno in parte da una serie di episodi allucinatori composti e strutturati, di tipo sia visivo che uditivo, durante i quali in effetti egli lo realizza ma semplicemente perché ha bisogno di costruire il racconto del delitto prima di commetterlo. E questa sua necessità diventa per Malerba un espediente narrativo grazie al quale procedere con una variante della sua tipica tecnica di ritrattare quanto precedentemente affermato o raccontato, dando ogni volta a noi lettori l’illusione di seguire fatti che realmente avvengono nella realtà fittizia del romanzo mentre questi fatti si svolgono soltanto nella mente contorta del suo narratore. Alla fine però questo modo di deformare o inventare la realtà risulta il modo più efficace di raccontarla ed è talmente forte il coinvolgimento nelle elucubrazioni martellanti del narratore che non importa nemmeno più se il delitto avviene o no, perché di fatto è come se fosse già avvenuto.
Come si vede, occorrerebbe un saggio intero anche solo per passare in rassegna gli aspetti più semplici di questo grande romanzo, figuriamoci poi se ci si dovesse addentrare nell’intricato tessuto filosofico di cui è in gran parte composto, con le sue frequenti incursioni in antiche trattazioni sui problemi relativi all’esistenza dell’Anima o in quelle più moderne riguardanti i cromosomi e la chimica della vita, che in una pagina del libro vengono tirati in ballo come possibili versioni più aggiornate proprio dell’Anima. In ogni caso non si farebbe che scoprire una volta ancora la profondità del pensiero di Malerba, la sua capacità di penetrazione nelle implicazioni morali delle problematiche della vita e nella visione anche tragica della stessa che queste gli hanno ispirato e che la sua narrativa ha esplorato sfruttando tutta la gamma fra l’insensato, l’inumano, l’immondo, l’immorale, il grottesco e l’assurdo. E questo senza nemmeno prendere in considerazione l’altra sua spiccata qualità, ossia la sua straordinaria vis comica, che anche in un romanzo duro e problematico come Il pianeta azzurro riesce a farsi sentire in parecchi punti, forse anche perché, per una strana legge non scritta dell’universo, gli scrittori più tragici sono anche quelli più comici.