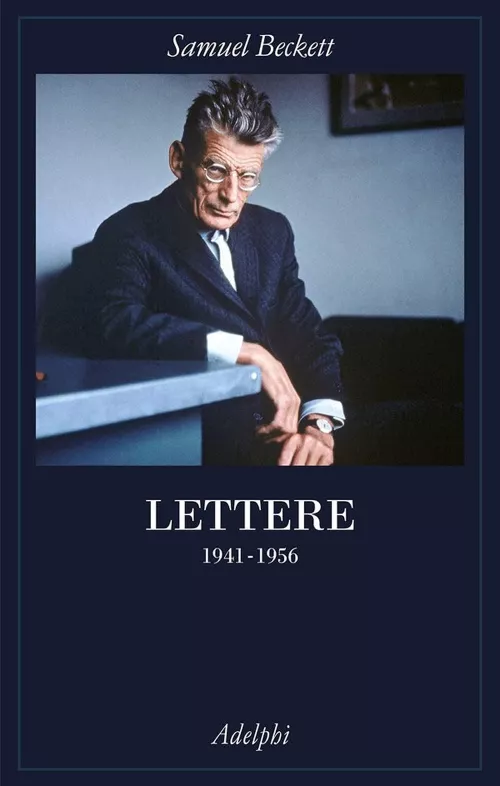Lettere 1941-1956 / Beckett dalla clandestinità a Godot
È bello anche solo come oggetto da guardare, questo secondo volume di lettere di Samuel Beckett. Con quella elegante tonalità di blu indaco utilizzata nel fondo di copertina e ripresa a variazioni più chiare nel riquadro contenente la foto dell’autore, pure lui particolarmente elegante e dallo sguardo arcigno dietro gli occhialini rotondi.
Ma naturalmente è il contenuto a suscitare interesse: la corrispondenza tenuta da Beckett nel periodo più intenso e creativamente più importante della sua vita. Quello che ha inizio con la stesura di Watt, avvenuta in gran parte durante il periodo di clandestinità trascorso da Beckett, allora ricercato dalla Gestapo, a Roussillon, nella Francia non occupata, assieme alla propria compagna Suzanne Deschevaux-Dumesnil; e termina con le prime prove di Finale di partita e con un Beckett già famosissimo a livello internazionale, rappresentato in più parti del mondo ma con qualche fastidio ancora da sanare nei confronti della madre patria, l’Irlanda, dove i suoi libri continuano ad essere messi all’indice, e della città che per un irlandese è la sola a sancire effettivamente il successo, ossia Londra, dove la sua opera teatrale, Aspettando Godot, ha potuto essere rappresentata solo dopo innumerevoli complicazioni e non prima di essere stata mondata di parecchie parole ed espressioni ritenute volgari su espressa volontà del Lord Chamberlain.
Le lettere sono precedute da un’acutissima introduzione di Dan Gunn, uno degli studiosi che hanno curato l’intera opera, il quale si avvicina con tatto e sensibilità alla figura umana di Beckett cogliendo le varie sfumature che contraddistinguono gli umori e gli atteggiamenti espressi nelle lettere raccolte in questo volume rispetto alle spigolosità di carattere che avevano caratterizzato quelle del primo. Ciò è evidente soprattutto a partire dal momento in cui ha inizio il periodo del cosiddetto “assedio nella stanza”, dal ’46 al ’51, quello cioè in cui Beckett avrebbe prodotto a raffica, verrebbe da dire, oltre alle novelle in francese, che pure basterebbero a collocarlo fra gli autori più originali del momento, anche i suoi maggiori capolavori, Molloy, Malone muore e L’innominabile.
Gunn sottolinea giustamente come questa trasformazione sia stata determinata dalle privazioni e dalle condizioni di pericolosità in cui Beckett era vissuto durante gli anni della guerra e come di fatto questo cambiamento sia attestato nelle lettere dalla “nuova assenza di ostilità e recriminazioni, di risentimento nei confronti del mondo e di chi lo abita” (p. LI). “Proprio quando ci si aspetterebbe un Beckett ombroso o furente – scrive Gunn – per gli anni in clandestinità, per le perdita di tanti amici deportati e morti, per le condizioni disastrose in mezzo alle macerie della cittadina di Saint-Lô, in Normandia, dove lavora per la Croce rossa irlandese, ci si trova davanti un Beckett rassegnato e reticente; non ci sono più, o quasi, le effervescenti filippiche dei primi anni, l’autocommiserazione, il rancore e gli occasionali sfoggi compiaciuti di bravura, come se tutta la sofferenza di cui è stato testimone avesse per sempre messo a tacere ogni espressione puramente personale di sfavore e disprezzo; come se, forse, la vista di un agire tanto brutale lo avesse per sempre consolidato nella sua inclinazione alla passività, per quanto paradossalmente rigorosa e fattiva” (p. LI).
Naturalmente, rispetto al periodo anteriore, questa nuova fase della vita di Beckett, una fase di rinascita, di stabilità e di continuità creativa sul piano del lavoro letterario, finisce inevitabilmente per produrre un mutamento anche nel giro delle amicizie e dei confidenti a cui le lettere sono indirizzate. Più diradate sono quelle destinate ai due interlocutori privilegiati dell’epoca precedente: l’amico Tom MacGreevy, divenuto nel frattempo direttore della National Gallery di Dublino, e George Reavy, suo primo agente letterario, ora passato un po’ in secondo piano, ma a cui tuttavia Beckett continua a dare ragguagli sul proprio lavoro, mettendolo pure a parte per primo della sua intenzione – poi rivelatasi decisiva per la svolta che già era latente nel suo modo di scrivere, dopo che anche il suo ultimo romanzo Watt l’aveva lasciato insoddisfatto – “di non scrivere più molto in inglese in futuro” (lettera del 15/12/1946), l’inglese “che mi impastoia (…) lingua orribile che so ancora troppo bene” (a Georges Duthuit, il 28/6/1949), ma di adottare il francese, per aderire piuttosto al bisogno di essere “mal armato” (a Hans Naumann, il 17/2/1954), e dunque in posizione di debolezza o di soggezione rispetto alla lingua, compiendo in tal modo quel passo che avrebbe letteralmente stravolto il suo destino di scrittore.
Contemporaneamente prende l’avvio una corrispondenza con persone dell’ambiente artistico letterario non solo parigino ma anche inglese e americano, ed esponenti del mondo editoriale francese che lo aiutano a sbarcare il lunario commissionandogli lavori di traduzione o interessandosi ai suoi scritti, come Alexander Trocchi che accoglie una parte di Watt sulla sua rivista “Merlin” (finendo poi per mandarlo su tutte le furie per aver stampato il pezzo a sua insaputa, senza avergli prima lasciato correggere le bozze), o l’editore Bordas che non solo gli pubblica Murphy in francese, ma fa in modo di ottenere un’opzione sulle sue opere successive, cosa questa che poi avrà fastidiose conseguenze nel momento in cui Beckett troverà in Jérôme Lindon un editore ben più sensibile, colto, intelligente e soprattutto pronto a scommettere veramente su di lui, garantendogli un’attenzione e un appoggio continui.
Fra i destinatari delle lettere scritte in questo periodo, dunque, cresce sempre di più il numero di coloro che lo avvicinano perché attratti dalla peculiarità dei suoi scritti e dal magnetismo della sua personalità e che saranno determinanti per lui nell’acquisizione di uno status nell’ambiente culturale parigino (in quegli anni collabora anche a “Les Temps Modernes”, la rivista di Sarte e Simone de Beauvoir) e in seguito nel consolidamento della sua fama.
Fra questi, in particolare, Georges Duthuit redattore capo della rivista “Transition”, alla quale Beckett contribuisce con parecchie traduzioni, riuscendo in tal modo a mantenersi nei primi anni di magra del dopoguerra; Mania Peron, che gli sarà di grande aiuto nel rivedere i suoi testi in francese; il succitato Jérôme Lindon, proprietario e direttore delle Éditions de Minuit, a cui Beckett legherà il suo nome e la sua fortuna per tutti gli anni a venire; Roger Blin, l’attore e regista teatrale che per primo intuisce la genialità di un’opera come Aspettando Godot e si adopera in tutti i modi per trovare un teatro in cui rappresentarla; Barney Rosset, l’editore americano di Grove Press che letteralmente si fa in quattro per promuovere l’opera di Beckett sul mercato d’oltreoceano; Pamela Mitchell, americana, amministratrice finanziaria della Oram Incorporated, che sbarca in Europa con il compito di assicurarsi i diritti delle opere di Beckett e avrà con lui una relazione; e Alan Schneider, un altro americano, regista teatrale che, dopo un primo fiasco a Miami con la rappresentazione di Godot (ma non ci poteva essere in tutto il mondo una città più sbagliata di quella per un dramma del genere), avrebbe in seguito diretto con successo molte altre opere di Beckett negli Stati Uniti.
Ricche di informazioni e di particolare interesse sono le lettere indirizzate al primo corrispondente di questo elenco, Georges Duthuit, il quale, anche grazie a una frequentazione regolare che avrebbe avuto con Beckett al di fuori dalla redazione della rivista da lui diretta, assolverà nel corso del tempo la funzione di confidente, consigliere, confessore, ascoltatore dei suoi malesseri e dei suoi momenti di cupa disperazione. Su tutti, in particolare, quelli espressi nelle lettere che Beckett gli scrive da Dublino o che hanno per oggetto l’Irlanda e i soggiorni che egli è obbligato a trascorrervi contro la propria volontà o per causa di forza maggiore, come in occasione della morte della madre, nel 1950, e due anni dopo, per assistere il fratello Frank che stava morendo di cancro.
Sono gli unici momenti in cui dalla pagina riaffiora il Beckett acido e corrosivo di un tempo, e forse anche quello un po’ superbo, come quando non esita a definire la rivista letteraria “Envoy”, che pure aveva pubblicato un brano di Watt, “nuova schifezza irlandese” (lettera del 9/5/1950), o a liquidare l’altra pubblicazione periodica di Dublino, “Irish Writing”, come “una roba davvero ributtante”, negando una collaborazione ai suoi redattori per evitare di finire accanto a uno scrittore come James Stephen, autore di un racconto a suo giudizio “magnifico per pulircisi il culo” (lettera del 20/7/1951). Altrove, consapevole che in quella città (Dublino) non godeva di una grande stima (a Donald Albery, il 4/7/1954), dopo aver partecipato a una non meglio precisata riunione con esponenti del mondo culturale dublinese, scrive con piglio ironico: “Ma l’altra sera, accecato dal whiskey, mi sono messo a sbraitare e a dare in escandescenze. I miei spettatori, genia di grande cultura, non hanno perso tempo a richiamarmi alla decenza, a suon di citazioni dei soliti intoccabili. Ho sentito, in lontananza, voci gravi, dolci e sensate, che si profittavano dello sbraitatore per farsi ancora più merdose del solito” (lettera del 27/7/1948). Tutto ciò in un crescendo di animosità e di dissapori che culmineranno dapprima nella consapevolezza che sarebbe ormai per lui impossibile vivere in Irlanda (a Susan Manning, il 10/9/1950), e in seguito nel rifiuto all’invito di diventare membro dell’Irish Academy of Letters che gli era stato posto da Seumas O’Sullivan, direttore di “Dublin Magazine” (lettera del 21/1/1956).
Ma accanto a queste vampate momentanee e a questi rigurgiti di rabbia del resto non del tutto immotivati, troviamo anche attimi di riflessione profonda che preludono o alludono a ciò che egli stava elaborando nei suoi scritti proprio in quell’epoca: “Stasera, tra le felci goccianti, in questa luce di sole calante che illumina il temporale dal basso, ho avuto la sensazione che ci serva un motivo adatto a far esplodere tutto questo misero miscuglio. Va sicuramente cercato dove va cercata ormai ogni cosa, nell’eterno larvale, no, è qualcos’altro anche nel coraggio dell’imperfezione del non essere, dove viene ad assalirci la tentazione di essere ancora, un po’, e la gloria di essere stati un po’, sotto un cielo indimenticabile. Sì, va cercato nell’impossibilità di non avere mai abbastanza torto, di non essere mai abbastanza ridicoli e indifesi” (lettera del 12/8/1948).
Del resto, pur con molta reticenza, senza mai dilungarsi troppo e spesso utilizzando un linguaggio scatologico per parlare della sua attività scrittoria, che egli sembra intendere quasi alla stregua di un processo fisico involontario caratterizzato da spasmi simili a quelli della defecazione e della eiaculazione (d’altra parte anche la morte viene definita “la stronzata suprema”), è proprio a Duthuit che Beckett confida o annuncia per primo l’elaborazione di nuove idee o il formarsi di nuove opere, soprattutto durante il periodo della gestazione di Godot. Mentre per i romanzi della trilogia egli si limita a qualche breve cenno di sfuggita, forse per scaramanzia, attorno a Godot si respira un’aria diversa, quasi che la facilità con cui quell’opera gli stava riuscendo, o forse perché l’aveva giudicata fin da subito come un diversivo o un momento di riposo dopo le fatiche della trilogia, ora sentisse la necessità di renderne partecipi i suoi interlocutori, in particolare appunto Duthuit, cui comunica di averla iniziata, poi di averla terminata, e a cui via via sottopone i propri dubbi, specialmente riguardo al titolo, e in seguito riguardo a tutta la problematica relativa alla messa in scena, ma sempre utilizzando espressioni colorite mai propriamente tecniche: “Adesso devo dedicarmi alla noiosa toeletta della mia pièce che forse si intitolerà Aspettando Godot. La cosa più importante è sturare bene l’ano” (lettera del marzo 1949). Esattamente come altrove definirà “minutaglia” (a A. Higgins, 30/8/1955) o “primi e ultimi rantoli” (a A.J. Leventhal, 26/1/1956) gli scritti in prosa che poi sarebbero stati raccolti col titolo di Testi per nulla.

En attendant Godot, prima messa in scena, 1952
Che Beckett d’altronde fosse restio a parlare in altri termini delle proprie opere o a dare spiegazioni riguardo al loro significato o più in generale a discutere di letteratura o di tecnica narrativa, è cosa ormai risaputa. A parte gli scritti giovanili su Proust, Joyce, o quelli redatti in età più matura di critica d’arte, in particolare sui fratelli Bram e Geer van Velde, non sono molte le occasioni in cui si dilunga su questi argomenti. In alcune lettere discute di qualche recensione o di qualche articolo uscito sui suoi primi libri in francese, ma lo fa succintamente, appunto, approvando o disapprovando senza però mai esporre un punto di vista personale riguardo all’opera in questione o proporre una sua spiegazione. Gli preme molto invece, a proposito delle possibili interpretazioni dei suoi testi, manifestare di nuovo tutto il suo “orrore” per i simboli (lettera a Mania Péron del 16/4/1951) ribadendo ancora una volta quanto aveva già espresso in chiusura di Watt, ossia che “non ci sono simboli dove non c’è intenzione”.
Molto più esplicito e puntiglioso Beckett lo sarà quando si accollerà il compito di riguardare le traduzioni dei suoi testi dal francese all’inglese (“Mi piacerebbe scoprire perché la mia prosa non passa in inglese”, scrive a Pamela Mitchell il 25/11/1953) o dall’inglese al francese, e di valutare quelle in tedesco, olandese e italiano; o quando si tratterà di mettere in scena le sue opere teatrali, per le quali con la massima intransigenza (modificando tutt’al più qualche battuta che gli è sembrata forse un po’ troppo pretenziosa durante le prove) pretenderà da parte del regista e degli attori la più scrupolosa osservanza delle sue direttive, consapevole che proprio nei dettagli si nasconde il diavolo, e a non poche complicazioni andrà incontro nel pretendere che siano rispettate le sue indicazioni, come ad esempio nella scena finale di Godot, quando Estragone, per impiccarsi, si toglie la corda che gli fa da cintura e i pantaloni gli si devono afflosciare sugli scarponi: una volta perché l’attore non accetta di farlo, una volta perché i pantaloni cadono sì, ma solo fino alle ginocchia, un’altra volta per il timore di offendere il pubblico decoro, l’esecuzione di questa gag, giustamente considerata della massima importanza, finisce sempre per trovare più difficoltà del previsto.
Quanto poi Beckett fosse poco disposto a interpretare la parte dell’autore che si crogiola nell’analisi delle proprie opere, risulta evidente in maniera fin troppo esplicita in una lettera (dopo il 23/1/1952) che egli scrive in risposta a una serie di domande che gli sono state poste, a proposito di Godot, dal giornalista radiofonico Michel Polac, stando alla quale egli dichiara di non avere idee sul teatro, di non capirne niente, di non andarci mai; che della pièce in particolare non ne sa di più di chi la legge attentamente; di non sapere con quale spirito l’ha scritta; che dei personaggi, non ne sa di più di quello che essi dicono, di quello che essi fanno o di quello che succede loro; di non sapere chi sia Godot; di non sapere nemmeno se esiste o se lo sappiano i due che lo aspettano; che gli altri due personaggi che passano verso la fine di ciascuno dei due atti dovevano esserci per rompere la monotonia; e infine che tutto quello che gli è riuscito di sapere l’ha mostrato: sa che è poco, ma è un poco che gli basta e avanza, e che si sarebbe accontentato anche di meno.
Che fossero sincere o no, queste risposte rivelano un Beckett intento sì a minimizzare la propria competenza d’autore, ma anche a rimanere fedele al proposito di non spiegare nulla della propria opera per non incorrere nell’errore di voler apparire ad essa superiore. Si tratta comunque di strategie che, per quanto piccole, sono rivelatrici di una estrema dedizione alla cura di tutti gli aspetti della propria attività, la quale evidentemente richiedeva anche una certa dose di segretezza, cosa che del resto appare chiara anche nelle lettere di questo periodo, nonostante che in esse, come nota Gunn, “la reticenza a spiegare il proprio lavoro è ancora a uno stadio iniziale e può essere vista come un aspetto o della repulsione, o della cura e del senso di protezione, o magari di entrambe le cose” (p. LXX). Solo in un caso, forse perché particolarmente soddisfatto, rivela a Duthuit di aver fatto una cosa che non aveva mai fatto prima: ossia di aver scritto l’ultima pagina del libro in corso (allora stava lavorando a L’innominabile, dunque si sta parlando di una pagina che sarebbe diventata fra le sue più famose) quando è ancora alla trentesima. “Non ne vado orgoglioso. Ma l’esito è già certo, quali che siano i contorcimenti, di cui ho soltanto un’idea vaghissima, che me ne separano” (lettera del 1/6/1949). Ma a Duthuit Beckett era ormai abituato a fare confidenze che non avrebbe rivolto a nessun altro, e a un certo punto gli rivela perfino quale sia il vero tema che occupa, e attorno a cui ruota, la sua narrativa: “Sappi però che io, che quasi non parlo di me, in realtà quasi non parlo che di questo” (lettera del 9/3/1949).
Un’ammissione, questa, inaspettata ma nemmeno tanto sorprendente se si pensa che tutta la narrativa di Beckett è costruita su un’infinità di particolari che rimandano alla sua vita, così come le parti descrittive, i paesaggi, i luoghi, certe apparizioni evocate dalle voci monologanti dei vari Molloy, Moran Malone, o che fanno da sfondo ai loro racconti, corrispondono precisamente a punti particolari dei dintorni di Dublino o delle Wicklow Mountains, dove Beckett era nato e cresciuto, come risulta anche dalla meticolosa ricognizione fotografica realizzata da Eoin O’Brien nel suo volume The Beckett Country (The Black Cat Press, 1986). Ma l’uso che Beckett fa di questi dati è tutt’altro che realistico, dal momento che egli se ne serve, astraendoli, come punti di riferimento di un paesaggio mentale in cui far apparire, muovere o star fermi i suoi personaggi, ossia i corpi che appartengono alle loro voci monologanti; per cui non verrebbe certo da dire che Molloy, Malone muore o L’innominabile siano opere ambientate nei pressi di Dublino, e men che meno che siano narrazioni autobiografiche, o romanzi nel senso in cui questo termine viene normalmente utilizzato.
Lo stesso aspetto di questi personaggi, o la loro condizione fisica (Molloy storpio; Malone, vecchio, disteso su un letto, morente; l’Innominabile, immobile, senza naso, senza sesso, senza capelli, con le lacrime agli occhi e le mani posate sulle ginocchia) è un dato che fissa naturalmente la loro identità esteriore ma serve soprattutto a imprimere nella narrazione una determinata tonalità emotiva, grazie alla quale si può prescindere dal raffigurarseli visivamente, o realisticamente. Molloy, ad esempio, è sdentato, ha i capelli lunghi, la bombetta, i pantaloni sporchi, indossa un cappotto liso, ha una gamba rigida e l’altra che lo diventa man mano che egli procede nella sua peregrinazione, tanto che alla fine non può più andare in bicicletta né camminare ed è costretto a strisciare. Ma un’immagine come questa, se posta in copertina, produrrebbe solo un effetto caricaturale, perché la trasposizione in un linguaggio visivo di una descrizione fatta attraverso un linguaggio letterario emotivamente permeato da quella stessa immagine fallisce se la corrispondenza avviene nei termini di una pedissequa realistica riproduzione (è lo stesso motivo per cui sarebbe un errore madornale ridurre all’immagine di un grosso insetto il contenuto visivo di un racconto come La metamorfosi di Kafka). Sarà solo quando Beckett passerà al teatro che questa oggettivazione si renderà, oltre che necessaria, efficace sul palcoscenico, in sostituzione del tessuto narrativo grazie al quale i suoi personaggi avevano affermato la propria esistenza, assumendosi l’obbligo etico di andare avanti, di continuare a narrare, sapendo che “non c’è niente da esprimere, niente con cui esprimere, nessun potere di esprimere, nessun desiderio di esprimere, insieme all’obbligo di esprimere”, secondo l’assioma dell’impossibilità comunicativa enunciato da Beckett nel primo dei Tre dialoghi, e poi da lui utilizzato come principio compositivo dell’intera trilogia.
Proprio riguardo a quest’ultima, prescindendo da implicazioni di carattere testuale, e per rimanere ai fatti di contorno, va segnalata la presenza in questa edizione delle lettere dello scambio di corrispondenza avvenuto con Jérôme Lindon, proprietario delle Editions de Minuit, relativo alla pubblicazione dei tre volumi di cui la trilogia si compone, ed è interessante notare come la trattativa sia stata interamente condotta in prima persona dalla moglie di Beckett, Suzanne, e di come egli sia subentrato solo in un secondo tempo, a pubblicazione avvenuta, e in seguito abbia continuato a farlo, col diffondersi della sua fama, spesso per ripararsi dietro le spalle dell’editore e sottrarsi da ogni tipo di invito o manifestazione – comprese quelli in cui era in ballo l’assegnazione di un premio – che richiedesse la sua presenza.
Il volume, poi, contiene anche parecchie altre curiosità, come la proposta ricevuta da parte del New Repertory Theatre di New York, e da Beckett riportata in una lettera a Pamela Mitchell (17/2/1955), di portare in scena la pièce (Godot) con Buster Keaton nella parte di Vladimir e Marlon Brando in quella di Estragone: proposta però a cui lui, pur rammaricandosene, aveva dovuto rinunciare per questioni contrattuali.
Ma prima ancora Godot aveva dato origine ad un altro curioso episodio dall’epilogo imprevisto, dopo che la pièce era stata realizzata, nel novembre 1953, nel carcere tedesco di Luttrinhausen, ad opera di un detenuto, Karl-Franz Lembke, che l’aveva tradotta, diretta e interpretata. Questi, poi, avendo ricevuto una lettera di ringraziamento da parte di Beckett, una volta scarcerato, era andato a Parigi per conoscerlo di persona, cercandolo attraverso Roger Blin, il quale però aveva inizialmente preso tempo e poi, una volta saputo che Beckett, spaventato per quell’improvvisata e temendo che l’altro potesse essere un tipo pericoloso, non desiderava incontrarlo, aveva detto all’ex carcerato che Beckett non era in città, e quello, forse perché stanco di aspettare, e senza dar mostra d’esserne rimasto deluso, si era diretto verso il sud della Francia.
Quanto, infine, ad autori o libri che vengono menzionati in queste lettere, essi sono in gran numero inferiori rispetto a quelli di cui si parla nel primo volume, e forse è per questo che rimangono più impressi, come nel caso di Il giovane Holden, di cui Beckett parla con entusiasmo in un paio di lettere (a Loly Rosset, il 20/11/1953 e a Pamela Mitchell, il 25/11/1953), o del grande romanzo di Theodore Fontane, Effi Briest, che in una lettera a Barney Rosset definisce “bello e commovente come pochi” (26/5/1956). Ma certo non mancano anche le stoccate, di cui sono bersaglio via via nomi anche celebri come quelli di Prevert, Queneau, Paulhan, Faulkner; o la citazione di altri (Rimbaud, Yeats, Klee, Joyce) che vengono ricordati en passant da Beckett in una sorta di lirico attraversamento fra i ricordi del passato, come nella lunga a lettera a Duthuit del 27/7/1948, da Dublino, in cui scrive: “Ho sognato Matisse diceva in dublinese che non ne poteva più (I’m bet). In coma mio padre diceva Fight, fight, fight (combatti). Sì, ho dei bei ricordi. E che potranno solo infittirsi. Vado a pranzo, poi me ne andrò a passeggiare sui lunghi verdi pendii da dove, bambino, con il tempo terso vedevo le montagne del Galles. Al calare della notte mio padre, per farmi divertire, dava fuoco alla ginestra. Berrò qualche pinta nelle locande di montagna, non sono locande, piuttosto dei pub con i bei nomi dei proprietari defunti, Fox, Lamb, Silke, e infine verrà la sera, e il mare che si illumina, il porto la città i promontori. Paesaggio romantico ma passeggiatore rinsecchito”.
Sembra la descrizione della scena finale della prima novella che egli aveva scritto in francese, quella in cui cominciava a profilarsi il suo tipico personaggio del vecchio derelitto che qui, dopo essersi allontanato da un’opera pia che lo aveva accolto, prende a girovagare per quella che un tempo doveva essere la sua città, ma di cui non riconosce più nulla e pian piano, dopo avere anche elemosinato per strada, trovato rifugio in una caverna e poi in un barchino dentro la rimessa di una villa disabitata, prende il mare a bordo del barchino stesso e descrive intorno a sé la scena notturna con le ginestre in fiamme e il promontorio, prima di perdersi nel grande nulla del buio davanti a sé. La novella s’intitolava La fine: paradossalmente segnava l’inizio del suo periodo più grande.
Samuel Beckett, Lettere 1941-1956, a cura di George Craig, Martha Dow Fehsenfeld, Dan Gunn, Lois More Overbeck. Edizione italiana a cura di Franca Cavagnoli, traduzione di Leonardo Marcello Pignataro. Adelphi, pp. 517.
Leggi anche:
Daniele Benati, Le lettere di Samuel Beckett