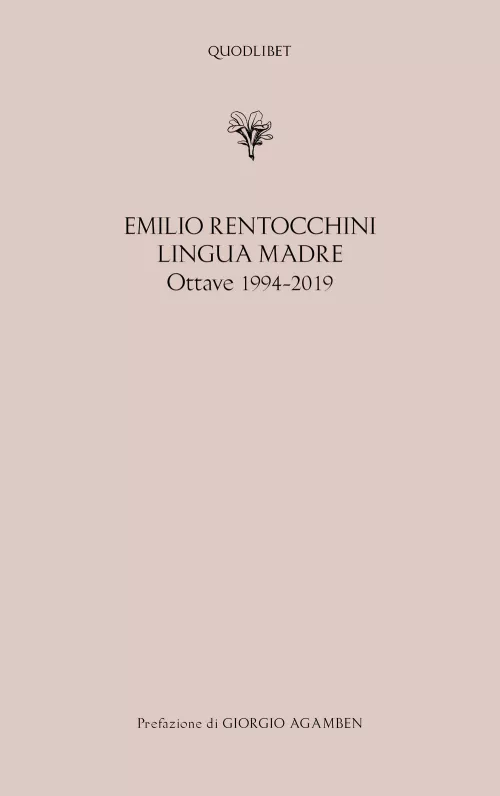Rentocchini, maestro della poesia dialettale
Sono ormai diversi gli editori che, con fiuto e lungimiranza, hanno accolto nelle loro collane di poesia le opere di Emilio Rentocchini – Donzelli, Incontri Editrice, Book Editore, per citarne alcuni; e altrettanti i critici, gli studiosi e i poeti che si sono occupati di lui, come il compianto Marco Santagata, uno dei massimi esperti di lirica italiana, petrarchista e dantista di primo piano, o Roberto Galaverni, Alberto Bertoni e, ovviamente, Giovanni Giudici, grazie al quale Rentocchini già una ventina d’anni fa era pervenuto a un primo importante riconoscimento con la pubblicazione da Garzanti (2001) di quella che all’epoca era la raccolta più completa delle sue Ottave (libro oggi ormai introvabile, se non, e se va bene, a prezzi vertiginosi su ebay).
Appare dunque come una specie di consacrazione, se non come un suggello, ma si spera non definitivo, l’apparizione ora di un’edizione ulteriormente ampliata delle sue ottave, che hanno raggiunto il numero di trecento, dal titolo Lingua Madre. Ottave 1994-2019, nella prestigiosa, raffinata ed elegante collana di poesia dialettale, diretta e curata per l’editore Quodlibet da Giorgio Agamben, che è autore anche di una bella e sentita prefazione al libro.
E non è un caso che sia proprio un filosofo a proporre al pubblico la lettura di questo autore così unico e elusivo, perché buona parte della poesia di Rentocchini è costruita su una serie di riflessioni dal sapore filosofico, per non dire metafisico, azionate da stimoli visivi e concettuali del tutto insoliti, di cui egli riesce magnificamente a catturare la poeticità. Quello che stupisce è che riesca a farlo utilizzando un mezzo espressivo non particolarmente adatto all’astrazione come il dialetto, nel suo caso specifico quello di area emiliana di Sassuolo.
Ma è proprio nella capacità di trasformare il dialetto in una lingua d’elezione che risiede uno dei maggiori pregi della sua arte. Un’arte molto cauta, fatta di tele linguistiche fini e sottili, ma di cui “ogni parola se la lasci cadere / sfonda il pavimento assorbendo il vuoto / della cantina” (ogni parola se t’la las cascher / la sfenda al pavimeint sugand al vod / ed la canteina) (Ottava 166).
E l’operazione che egli compie è quella di un esperto cultore del dialetto a cui preme innanzitutto di mettere in salvo la propria “lingua madre”, aggiornandola e ampliandone le potenzialità comunicative attraverso la naturalizzazione di forme lessicali e verbali importate dall’italiano. E questo gli dà modo, in secondo luogo, di trasformarla in un mezzo espressivo capace di divincolarsi tra le maglie del pensiero astratto, sacrificando magari quel tanto di espressività in più che normalmente il dialetto possiede rispetto all’italiano, dato che non sono le tonalità forti della lingua a interessargli quanto il suo apporto più garbatamente emotivo.
Più che un poeta dialettale, dunque, Rentocchini è un poeta che scrive in dialetto e, come tale, si mostra fedele alle forme della tradizione (principalmente l’ottava e il sonetto) e ai suoi metri (l’endecasillabo). Ma allo stesso tempo la sua poesia abbraccia orizzonti più ampi, tanto che nel suo caso definizioni come queste non hanno più molta importanza. Rentocchini infatti si allontana da qualunque classificazione riduttiva presentando in ogni edizione, sotto ai testi poetici originali, le loro versioni in italiano. E queste versioni, più che traduzioni di servizio, sono esse stesse poesie perfettamente autonome, caratterizzate da una lingua letteraria che, proprio perché passata attraverso il filtro del dialetto, pare aver fatto un bagno d’umiltà, uscendone rinforzata, credibile e dotata di una cromatura particolare che rispecchia il lavoro che l’autore ha compiuto per anni, come egli stesso scrive, “a raccattare una lingua alla deriva” (an a tor sò na léngua a la deriva) (296), una “lingua di fil di ferro / fatta per ferire la vita come un aratro” (léngua ed fil ed fer / fata per frir la véta dmand un piod)(166).
Ne esce dunque un’opera linguisticamente intensa e retta da un impianto tematico assai complesso in cui le più sofisticate speculazioni concettuali si mescolano a riflessioni sul lavoro poetico, a momenti di attività contemplativa e a sprazzi descrittivi composti da una miriade di piccoli particolari che Rentocchini utilizza per dar corpo alla sua lingua ed evocare l’ambiente e il paesaggio che di quella lingua sono la controparte visiva. I silos e i capannoni della campagna emiliana colti di sfuggita attraverso lo specchietto retrovisore dell’auto; o l’orecchino di una donna in piedi al banco di un bar, intravisto nello specchio tra il fumo di due o tre vecchi; la mano di un camionista colta fuori dal finestrino ad accarezzare la lamiera dello sportello; l’Arco della casa di Ariosto, a Reggio, contemplato da un bar sul lato opposto della Via Emilia tra un passaggio e l’altro di tir; o la luna che appare come una povera luce dietro le ciminiere degli stabilimenti industriali; e poi, ancora, le cancellate delle fabbriche, le insegne tremolanti delle Ipercoop, le colombofile, i macelli, le bocciofile, i negozi di barbieri, i bar col bersò, e gli autovelox posizionati a raffica, come quelli citati nell’Ottava 284, che a Maranello, proprio a Maranello, la capitale mondiale della velocità, paiono irridere al mito della Ferrari che lì ha la sua sede – ecco, tutte queste sono immagini che possono attirare l’attenzione grazie a un particolare stato d’animo, ma sulle quali è facile anche presumere che nessuno all’infuori di un vero poeta avrebbe la sensibilità o l’accorgimento di soffermarsi e di trasformarle in materiale poetico.
Ma, nonostante il paesaggio che compare sullo sfondo dei suoi testi sia quello industrializzato dell’Emilia, a stimolare la sensibilità di Rentocchini paiono essere soprattutto gli aspetti più ordinari della vita comune che è cresciuta ai margini dello sviluppo economico conosciuto dal suo paese, ossia quella “terra mia operaia” di cui egli parla nell’Ottava 229 e che solo attraverso il dialetto egli riesce a recuperare.
E, nel farlo, la strategia che egli utilizza è a volte quella di colpire il lettore con immagini neanche tanto appariscenti ma tali da fissarsi immediatamente nella memoria; e altre volte quella di indurlo a lasciarsi trasportare dagli elementi visivi del testo lungo un percorso alla fine del quale ci si può anche ritrovare con la sensazione di essere lontanissimi dal punto di partenza. Come nell’Ottava 164, in cui dall’immagine iniziale dei mucchi di piastrelle accatastati nei cortili delle fabbriche, si passa a disquisire sui buchi neri dell’universo, per finire con una possibile definizione di Dio come “orco che si lecca le dita” (n’ourch ch’as lecca i dî) per essersi “pappato una stella dell’infinito” (ch’al s’è papê na strella dl’infinî…).
E l’effetto prodotto è ancor più sorprendente se si considera che Rentocchini non è affatto un poeta narrativo, nonostante l’adozione di una forma come quella dell’ottava che narrativa lo è per eccellenza, e nonostante alla lettura dei suoi testi la sensazione più frequente è che il materiale tematico che essi sviluppano sia talmente vasto e compresso che se lo si liberasse dalla struttura in cui è racchiuso sprigionerebbe una quantità tale di parole che forse nemmeno un testo narrativo riuscirebbe a contenere.
Per tutti i motivi fin qui elencati, dunque, non è esagerato affermare che questo libro, Lingua madre, rappresenta un caso unico nel panorama della poesia italiana contemporanea. Scriverne è molto difficile per la varietà di temi, pensieri e idee che esso racchiude, ma lo sforzo maggiore che si compie è di trattenersi continuamente dai superlativi per descriverlo.
E proprio per avere ulteriori chiarimenti su questo suo lavoro, abbiamo posto a Rentocchini alcune domande, che compongono l’intervista che segue.
Innanzitutto, qual è il tuo rapporto col dialetto e cosa ti ha spinto ad utilizzarlo come lingua poetica?
Un ragazzo scopre in solaio il violino del bisnonno e se lo porta in camera. Pian piano, coi suoi tempi, lo sistema, ricavando dall’antico telaio sonorità e spessori unici. Ma quando comincia a usarlo veramente, è per suonare la propria musica, facendolo diventare uno strumento di conoscenza e interpretazione di sé e del mondo. Da questa semplice immagine è partito tutto. Sarà stato l’Ottanta. Siamo nel 2023 ed è ancora così.
Vorrei sapere se il tuo caso potrebbe essere simile, ad esempio, a quello di tanti poeti irlandesi che hanno assunto il gaelico come lingua letteraria, in opposizione al dominio dell’inglese.
Credo – in maniera meno perentoria e sofferta – che non sia stata una scelta di campo, quanto la soluzione più a portata di mano per la mia quotidiana sopravvivenza spirituale. Ero consapevole di possedere una miniera di parole magiche, che la convivenza da bimbo coi nonni mi aveva donato, e a cui ero affezionato anche e soprattutto per quella ragione. Cominciare a scavare con la penna la miniera del dialetto mi sembrò allora più che altro una cosa naturale.
Il dialetto presuppone un contesto di situazioni e figure di tipo paesano, che tu a volte usi, ma elevandolo con tematiche che di dialettale hanno ben poco. Così come certe riflessioni di carattere filosofico che tu fai vengono a volte trattenute il più possibile vicino a terra da un repentino mutamento di tono.
Ima summis in se reconciliavit. Queste parole, di colore non troppo oscuro, si riferiscono a Gesù e mi hanno rammentato a ogni matrimonio o funerale la retta via, come persona e come poeta. Campeggiavano, e credo ancora lo facciano, dietro l’altare della chiesetta del paesino di montagna dove, per una vita, ho passato le vacanze. Aggiungi a ciò un po’ di sano understatement ed ecco fatto.
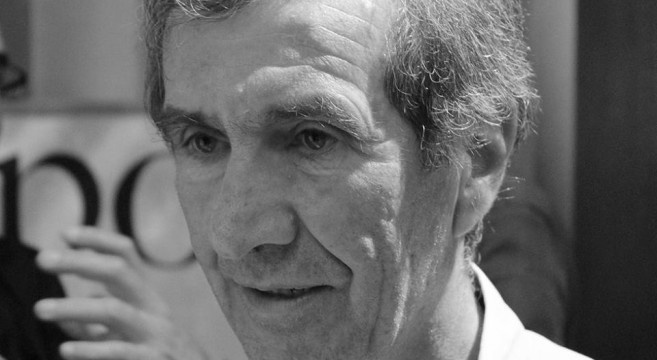
Il dialetto, la lingua, la poesia, sono temi ricorrenti nei tuoi testi E si ha l’impressione proprio per questo che tu, pur avendo adottato una forma classica come quella dell’ottava, sia bene al corrente di tutti i mutamenti avvenuti nella poesia italiana degli ultimi 50 anni e che li abbia anzi assimilati a dovere. Puoi dire a quali esperienze ti senti più vicino e se non ritieni che sarebbe un po’ riduttivo considerarti un poeta dialettale?
Parto dalla fine. Quando Pessoa scrive che la vita è un viaggio sperimentale fatto involontariamente, dice tutto. C’è solo da chiudere i libri e muti come pesci ubbidire al silenzio siderale che ci circonda. Se non fosse per sorella speranza... Quella frase ci fa tutti uguali, ma ognuno per conto suo, sulle tracce del senso delle cose. Ci fa sperimentali e finisce per combaciare col perimetro sacrale della voce dell’Ulisse dantesco. Cosa vuoi, io so solo che sono un poeta sperimentale, come tutti gli artisti, e, stando a Pessoa, ogni uomo. Rispondendo alla prima parte della domanda, il mio poeta preferito è Montale.
Capisco che è difficile farlo in poche parole perché trecento ottave sono il lavoro di una vita, ma tanto per dare qualche indicazione ai possibili lettori di questo tuo Lingua madre, potresti individuare alcune delle tematiche principali trattate nei testi. Il libro è composto da una tela fittissima di rimandi e collegamenti, tanto che, forse, più che un poema, è paragonabile a un ipertesto.
Mi piace molto la definizione di ipertesto, anche perché, visto che si scrive tutti di una stessa cosa, la vita, quaggiù è tutto un sondare con ogni mezzo quel corpaccione vischioso cui apparteniamo, per vedere di cavarne qualcosa di originale o meno stantio. Ecco dunque che per quante soluzioni organizzate, affidate alla scienza, o semplicemente, come nel mio caso, alla numerazione si provino, qualunque opera umana ‘è composta da una tela fittissima di rimandi e collegamenti’. Negli ultimi anni, prima che per merito di Quodlibet avvenisse il miracolo, rimuginavo tristemente sull’inutilità dell’opera e nel contempo, per trastullo, mi dedicavo a suddividere: ottave sulla nascita, la morte, l’amore, la lingua, l’anima, il lavoro, il tempo, e via così, giungendo sempre alla stessa conclusione: ve’ mo’, proprio una vecchia cassettiera da farmacia gonfia di roba.
A proposito del titolo, la prima cosa che viene in mente è un possibile collegamento col bellissimo volume autobiografico di Canetti, La lingua salvata. Lui, nato e cresciuto in ambiente multilingue, alla fine sceglie la lingua della madre – il tedesco – per scrivere e diventare scrittore.
Quella dell’Autobiografia senile di Canetti è stata una lettura intensa e fertile, che mi ha certamente condizionato. Ma non solo per la sua scelta del tedesco materno. Mi colpì molto, in un volume successivo, la figura del dottor Sonne, che in gioventù aveva scritto un pugno di poesie in ebraico e basta, testi perfetti, divenuti presto classici. Per non parlare di Karl Kraus: 'La lingua tedesca non riesce più a proteggere da quelli che la parlano. Se voglio salvarmi, sono costretto a farmi venire subito qualcosa in latino. E così va bene; perché come si pensa bene in una lingua che si è dimenticata. Quel pensiero sorge là dove ancora non avevo commercio con la lingua tedesca. E così ci si congeda in latino'. Dunque, lingue salvifiche più che salvate, in quanto non slavate dall’abuso. In fondo, nel mio piccolo, posso considerarmi uno resuscitato dal dialetto.
Uno degli aspetti che maggiormente ammiro della tua poesia è il tuo uso delle immagini. Spesso rappresentate in maniera indiretta, o colte di sfuggita. Cose da niente, il più delle volte. Ma che funzione hanno queste immagini nei tuoi testi? Sono il polo magnetico attorno a cui ruotano gli elementi concettuali delle tue riflessioni?
Spero proprio che sia come dici in chiusura di domanda. Roberto Galaverni ha scritto sul Corriere che guardo per pensare e penso per guardare, siamo lì. Due indizi non fanno una prova ma ci vanno vicino. Magari. Nella mia lingua un po’ antiquata mi viene comunque da chiamarle epifanie, sono parte di una situazione o di un paesaggio da cui si staccano all’improvviso ponendosi in rilievo per superiorità etico-estetica. Miraggi di umanità mai doma, di ruvida e precaria bellezza. Sempre sulla coda della lepre, perché la vita va.
Naturalmente anche aspetti caratteristici del paesaggio emiliano compaiono spesso nelle tue ottave. Diciamo, in generale, il polo industrializzato a sud di Modena, tra Sassuolo e Maranello. Ma non v’è mai traccia nei tuoi versi di una seppur minima intenzione celebrativa, né alcuna espressione di compiacimento per lo sviluppo economico che ha caratterizzato quella regione e per la ricchezza che ne è conseguita.
Non sono un tipo celebrativo in generale, non ricordo di avere festeggiato un compleanno, neanche da bambino, e ho un’idea piuttosto feriale della vita. Si dice che ognuno sappia appena di casa sua, e la mia esistenza si è sviluppata o avviluppata qui. Quindi di che scrivere se non di questi posti incalliti di lavoro e subiti guadagni. Gianni Mura, in un’intervista, disse che Sassuolo per me era come la gobba per Leopardi. Ma non saprei. Sono nato nella piazza principale di un paesino per ritrovarmi poi in pochi anni al centro di un convulso distretto industriale. Però Sassuolo, oltre che della piastrella, è la capitale della nostra montagna, che per fortuna inizia alle sue spalle, e questo aggiusta. Decine di chilometri nel nulla buono di un verde silenzioso e senza pretese. Be’, scrivendo, cerco di tenere insieme il mondo di lamiera e quello di natura, e se ci riesco mi sento a posto.
Per tornare al dialetto, spesso viene etichettato come lingua rivolta al passato. Tu hai scritto un’ottava, al riguardo. Hai qualcos’altro da aggiungere sulla questione?
Giusto e ingiusto affermare che chi usa il dialetto è volto al passato, sostiene l’incipit dell’ottava in questione, e per una volta posso dire di essere d’accordo con me stesso. In me, il dialetto è l’Angelus Novus di Klee che procede rivolto all’indietro, ma anche quello che gira sul Campanone di Sassuolo indicando il tempo a venire.
E in relazione al fatto che scrivere in dialetto sia come andare in bicicletta in discesa, o nuotare con le pinne, come sostengono alcuni?
Come mi è già capitato di dire, per me l’ottava è un orologio: deve essere bella ma anche funzionare, cioè, segnare il tempo per me e gli altri, quindi non può che essere il risultato di un lavoro di precisione, concentrazione, adesione, riflessione. Altro che discesa. La discesa comincia dopo, quando la si rilegge e, se riuscita, scivola via.
Due ottave di Emilio Rentocchini
176
A Fra
Un em ch’al péssa o al prèiga l’è listess
la lus l’è la sô cuna traspareinta,
s’a slenga un bras o al peinsa, anch s’agh incress,
al nóda in al schniusû e acsè a le dveinta,
la prua d’ogni sô idea come la cress
l’alega l’etra spenda e a la reinveinta
liberameint, l’è nê a tratgnir al fiê
per ferla countra al mur dl’eternitê.
Un uomo che piscia o che prega è la stessa cosa
la luce è la sua culla trasparente,
se allunga un braccio o pensa, pur con rincrescimento,
nuota nell’ignoto e lo diventa,
la prua d’ogni sua idea appena sboccia
allaga l’altra sponda e la reinventa
in libertà, è nato per trattenere il fiato
e farla contro il muro dell’eternità.
233
Gióst e ingióst dir che chi dróva al dialett
l’è arvultê indrê vers al pasê, vést che
scréver l’è ander in seirca e chi ’s ghe mett,
qualunque diresioun intima che
po’ a ciaparà, seimper al catrà ’d nett
l’avgnìr. Bel dir in dialett ai can se
apeina un bris randag, ai gat ch’i nàsen
a l’improvis s’un mur, ch’i mort i arnàsen.
Giusto e ingiusto affermare che chi usa il dialetto
è volto al passato, visto che
scrivere è ricercare e chi cerca,
qualunque direzione interiore
poi prenda, troverà sempre e comunque
il futuro. Che bello dire in dialetto a cani
appena un poco randagi, ai gatti che sbocciano
all’improvviso su un muro, che i morti rinascono.
da Emilio Rentocchini
Lingua madre. Ottave 1994-2019
Prefazione di Giorgio Agamben
Quodlibet 2022, E. 22.