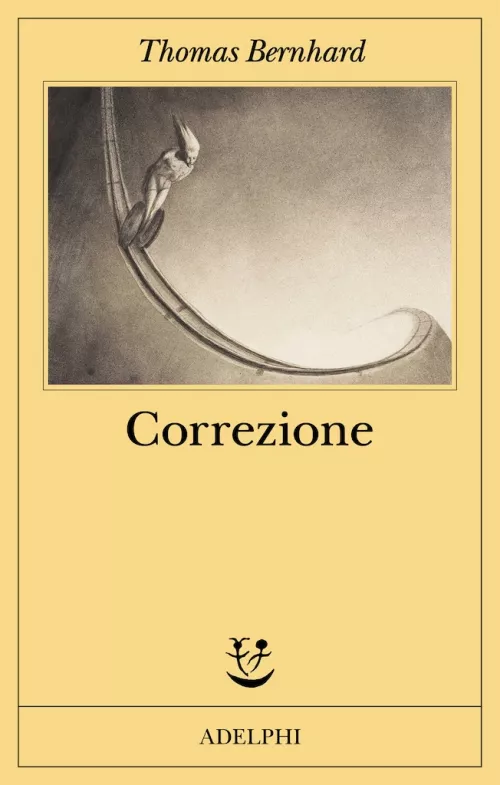Thomas Bernhard e la correzione infinita
Come in altri romanzi di Thomas Bernhard al centro di Correzione c’è una famiglia oppressiva, senza affetto, rinchiusa in una labirintica, interminabile proprietà, Altensam, simile a una fortezza (o al castello di Kafka), dove i tarli rosicchiano in continuazione il legno di assi del pavimento, mobili, travi del soffitto facendo precipitare la segatura nel cervello di chi vi abita. Un luogo inospitale, di silenzi invincibili, di strazianti conflitti, dal quale il protagonista, Roithamer, fugge appena possibile, fin da bambino, scendendo a piedi attraverso il bosco per andare a prendere i compagni di scuola, quello che diventerà l’imbalsamatore Höller e quello che sarà la voce narrante iniziale del romanzo, una figura senza nome, reduce da alcuni mesi in ospedale per malattia ai polmoni, come lo stesso Bernhard, che disegnava spesso figure di finzione sovrapponibili per certe caratteristiche a persone reali.
Correzione torna in libreria in questi giorni in una nuova edizione Adelphi, nella vecchia traduzione di Giovanna Agabio, senza la prefazione di Vincenzo Quagliotti alla seconda edizione Einaudi del 2013, dove si narrava la genesi del romanzo uscito per la prima volta nel 1975 (le prefazioni non usano nei romanzi Adelphi). Salutato all’uscita come un capolavoro, veniva così situato da Quagliotti: “Correzione chiude una stagione creativa per aprirne una nuova, affina e sistematizza soluzioni stilistiche e individua spunti tematici che saranno utilizzati nei libri successivi; non sempre con il rigore, l’intransigenza e la sicurezza qui dimostrati”.
Il tema dell’oppressione familiare è, naturalmente, solo uno dei colori di una tavolozza ricchissima, che si distende e si aggroviglia subito in uno stile incalzante per piccoli slittamenti continui, con sviluppi, variazioni, riprese che richiamano la struttura della sinfonia classica, ma anche con distillazioni che rimandano agli amati Schönberg e Webern. Caratteristico dell’autore austriaco è il gioco delle voci narranti, che si incastrano l’una nell’altra, fino a creare un sapiente vortice che avvolge il lettore e ne sposta continuamente il punto di vista e la prospettiva di verità sui fatti narrati. Un altro motivo, fondamentale, è quello della sfida impossibile, dell’opera destinata già nella concezione ardita, geniale, folle, al fallimento, come il saggio sull’udito che prova a scrivere il protagonista della Fornace (1970, in Italia Adelphi 2022) o quello su Mendelssohn che non va oltre le prime parole in Cemento (1982, in Italia SE 2015). Sono macchine celibi, in Correzione con un particolare risvolto drammatico.
Roithamer, fuggito giovanissimo dalla famiglia per studiare a Cambridge (e continuamente in fuga, tra il paese natale e l’Inghilterra, tra la casa di famiglia e la soffitta dell’imbalsamatore Höller) immagina di costruire una casa perfetta per la sorella, l’unica familiare con cui condivida affetto e sintonia. Si impegna per anni, lavorando lontano dalla magione di famiglia di Altsam, nella soffitta dell’impagliatore, a un cono da situare al centro del bosco di Kobernausserwald, non più alto dei maestosi alberi della foresta, perfettamente mimetizzato e situato in un punto strategico, centrale. Lo edifica per la sorella, cercando di realizzare una costruzione (aborre e bandisce il termine architettura) che dia felicità alla donna, riducendo via via il numero delle stanze, situando nella parte più alta un ambiente dove si possa far spaziare la vista sul paesaggio naturale, mettendo al centro dell’incredibile realizzazione una stanza della meditazione e dotandola di altri ambienti. Anche se è fuggito in Inghilterra, per studiare e poi insegnare scienze naturali (“Non è Wittgenstein, ma è Wittgenstein” affermò l’autore, affascinato dal filosofo che aveva analizzato i rapporti, i tradimenti, tra linguaggio e realtà), Roithamer è tornato spesso a casa, nella maggior parte dei casi rifuggendo la tenuta familiare e rifugiandosi a studiare, a progettare, nella soffitta di Höller. E ha ricevuto in eredità dal padre, a danno dei fratelli, odiati perché legati alla madre, volgare, brutale, impresentabile, tutta la proprietà, forse perché il genitore voleva, affidandola al più reprobo dei figli, distruggerla. (Ritorna in Bernhard continuamente, seccamente e dolorosamente, l’idea di far esplodere quei nuclei familiari in cui gli individui sono costretti a convivere loro malgrado, con la cocente nostalgia per la mancanza di calore umano di quei luoghi di puro tormento).
Il modello ideale del cono è la casa di Höller, costruita in una valle oscura su un fiume impetuoso che ha travolto altre abitazioni con le sue piene. E quelle risparmiate dalle acque sono state rovinate, spesso, dalle frane. Ma Höller ha concepito un edificio capace di resistere a acque e frane, e quello è il modello dell’impensabile dimora ideata e realizzata da Roithamer. Non ha mai fatto vedere il pazzesco cono alla sorella, finché non è stato terminato. Ma lei, proprio allora, invece che essere invasa dalla felicità, muore. Allora Roithamer abbandona la sua sfida di pietra e mattoni, bianco di calce all’interno e all’esterno, al potere distruttivo della natura.
Tornando a casa dall’Inghilterra per la sepoltura della sorella riscrive, corregge, varie volte l’opera che aveva dedicato alla ripugnante famiglia, luogo di torture, A proposito di Altensam e di tutto ciò che è connesso ad Altensam con particolare riferimento al cono, fino a ridurla da parecchie centinaia di pagine a un’ottantina di fogli. Ma l’ultima correzione, quella definitiva, quella che impedisce ogni errore, sarà il suicidio, in una radura, nel bosco.
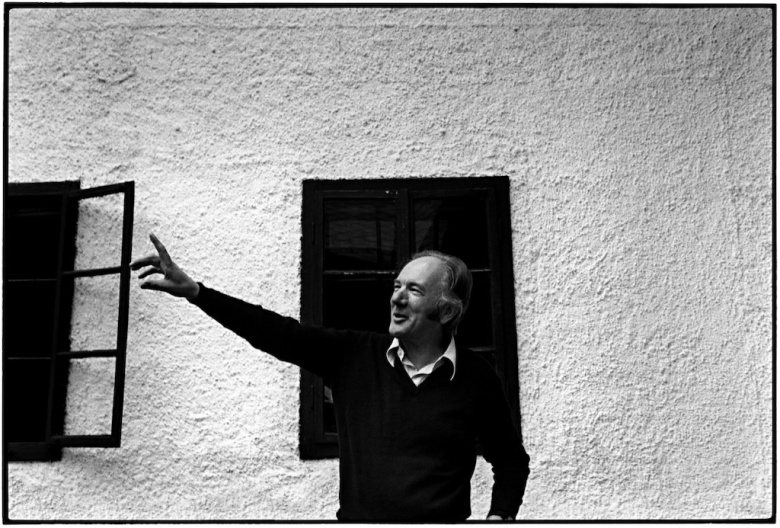
“La tendenza oggi è contro il pensiero ed è per la finzione, come in genere tutta quest’epoca in cui viviamo è finta, tutto è finto, nulla è reale, tutto è finto” leggiamo a un certo punto. La realtà è inavvicinabile. Quella delle cose e quella dei rapporti umani, delle relazioni parentali, ingarbugliate, tormentate, lacerate, guidate dall’egoismo, dal narcisismo, dall’astio verso chi sembra attentare all’identità dell’altro, dall’odio per il diverso. Di contro alle relazioni algide e guerriere nella sua famiglia, narrate con pagine ossessive che provano a trattenere una forte sofferenza, Roithamer vede nelle persone che abitano la casa dell’impagliatore, nell’umile moglie, nei figli educati e silenziosi, un forte senso affettivo, diverso dal suo glaciale nucleo d’origine.
Ma tutto questo, come sempre in Bernhard, è narrato per sovrapposizioni e spostamenti di voci, con un forte sguardo alle forme della musica, che amava e praticava. All’inizio a raccontare è l’amico che, designato curatore testamentario dal suicida, arriva da Höller e si istalla nella sua casa e nella soffitta, per mettere ordine negli scritti prodotti da Roithamer in molti anni di lavoro, divisi tra la teoria, gli studi di statica e di costruzione, e la pratica di cantiere. Sono tanti gli appunti sulla sfida rappresentata dal cono, appesi alle pareti e conservati in incartamenti che l’amico ha stipato in uno zaino. Il primo atto che fa è rovesciarne il contenuto nella soffitta, sì da confondere tutti i fogli, e rendere l’opera di riordino impossibile. Lavorerà solo sullo scritto su Altensam, districandosi tra parti sottolineate, correzioni, correzioni di correzioni, cercando un senso all’opera e alla vicenda esistenziale di Roithamer, ripercorrendone la formazione, l’infanzia, l’amicizia con sé e con Höller.
La casa sarà luogo di ospitalità e di riflessione, con l’osservazione di quella famiglia ideale. La soffitta nutrirà insonnia e fantasmi, nella sfida di dover ricostruire la verità dell’amico, lo scritto come appare dopo i vari ripensamenti, i vari interventi. Non solo la verità è difficilmente raggiungibile, ma anche la sua rappresentazione verbale è insicura, fallace, insidiata da uccelli neri della mente, quelli che nutrono la follia, che trovano un correlativo oggettivo in un animale esotico che l’impagliatore, anche egli insonne, sta imbalsamando nel suo laboratorio, spiato dall’alto dal narratore.
La soffitta, nella prima parte del romanzo, intitolata appunto La soffitta di Höller, è luogo di osservazione, di meditazione, di distanza dal mondo e di interrogazione sulle trappole dell’esistenza. Luogo di uccelli neri, come quelli delle ombre incombenti sull’opera di Roithamer.
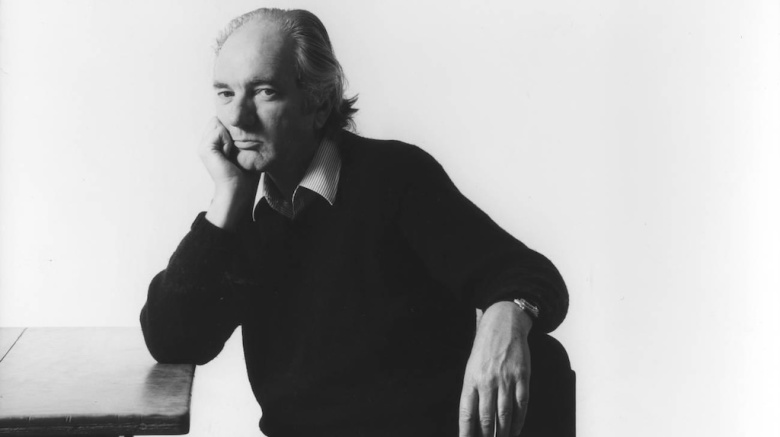
Questa prenderà il centro della narrazione nella seconda parte del romanzo, intitolata Esaminare e riordinare. Qui è il testo su Altensam di Roithamer a parlare, con slittamenti di commento dell’amico, che per esempio rimarca le parti sottolineate, evidenziate, dall’autore del cono, che quelle pagine, quel saggio, “aveva corretto all’infinito e quindi l’aveva distrutto, come credeva, ma come io so e come ho constatato adesso […] la correzione più spietata e quindi totale non l’ha distrutto, ma ne ha fatto un saggio completamente nuovo, perché la demolizione del saggio per mano sua, con la sua intelligenza acuta che elaborava il saggio senza alcuna pietà, aveva prodotto soltanto un saggio completamente nuovo”. In questo continuo variare solo la morte può concludere l’opera, annientarla, o lasciarla andare, come il cono abbandonato agli agenti naturali.
Vendere Altensam e destinare il ricavato ai detenuti tornati in libertà, come atto di autoliberazione dal carcere familiare. Lasciare alle piante, alla natura, il cono, che all’interno doveva essere un’immagine dell’interiorità della sorella, del suo essere esteriore all’esterno, poiché la sorella non è sopravvissuta al cono. Abbandonare le infinite riscritture dell’opera, cancellarla con un atto inscritto nella storia dei parenti della sua famiglia, il suicidio. Fuggire dalla tortura familiare, dalla volgarità della madre, in coppia mal assortita col padre (“la natura è quell’elemento incomprensibile che mette insieme le persone, le porta a scontrarsi con violenza, con ogni mezzo, affinché queste persone si distruggano, si annientino, si uccidano, si mandino in rovina, si eliminino, così Roithamer”).
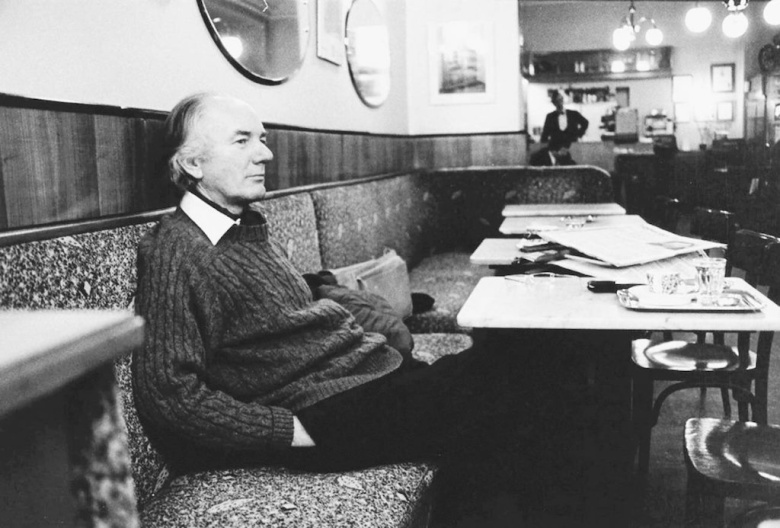
L’andamento a spirale continuo configura un’ossessione che prova a scorticare la normalità, sprofondando nel raffreddamento dei sentimenti, nel gelo della mancanza, della solitudine, della nostalgia mal riposta per una patria, terra natale e stato natale, traditori, infami (l’Austria vituperata da Bernhard, terra ipocrita, in cui il socialismo, perfino, nasconde il bigottismo cattolico e rigurgiti di nazismo). Luoghi dove le personalità e i sentimenti sono stritolati da una distruttiva macchina della tortura familiare.
La natura è una via di fuga, lo studio della natura dello scienziato naturalista, quella stessa natura che poi avvolgerà la sfida babelica del cono, offesa alle leggi dell’edilizia, forma simbolica di lenta ascesa verso un cielo che può dominare la terra, costretta al fallimento esistenziale dalla sua stessa arditezza. Un’altra via di fuga è l’amicizia, che rispetta le paure, le pause, i silenzi, le personalità più profonde. E un’altra si trova in un cassetto della soffitta: una rosa di carta vinta a un tirassegno, con altre ventitré, quando Roithamer, ventitreenne, inaspettatamente tirò con una carabina a un baraccone e colpì ventiquattro rose, di carta, lui che, figlio e fratello di cacciatori, non aveva mai sparato e ventitré le regalò, sorridendo, a una ragazza incontrata nella fiera, conservandone per sé solo una. Una “Rosebud” (il ricordo dell’infanzia di Quarto potere di Orson Welles) trovata dall’amico, immagine di un momento, un solo momento, di giovanile felicità, perduta per sempre.
Non facciamo domande alla persona che amiamo come non facciamo domande alla persona che odiamo, così Roithamer. In realtà sono spaventato da tutto quello che ho appena scritto, è stato tutto completamente diverso, penso, ma io correggerò quello che ho scritto, non adesso, lo correggerò in seguito, quando sarà arrivato il momento per una simile correzione, lo correggerò e poi correggerò quello che ho corretto e poi ricorreggerò quello che ho corretto e così via, così Roithamer. Correggiamo in continuazione e correggiamo noi stessi con la massima durezza, perché a ogni istante riconosciamo che abbiamo fatto (scritto, pensato, eseguito) tutto in modo falso, che tutto fino a questo momento è una falsificazione, per cui correggiamo questa falsificazione e ricorreggiamo la correzione di questa falsificazione e correggiamo il risultato di questa correzione della correzione e così via, così Roithamer. Ma rimandiamo la vera correzione, quella che altri hanno fatto senza esitare da un momento all’altro, penso, così Roithamer, hanno potuto fare quando anche loro non ci hanno pensato più perché hanno avuto paura anche solo di pensarci […] la vera correzione fondamentale, il loro suicidio.
Eppure, entrati in un mondo non preparato per noi, straziati dall’origine, fra tanto rancore e odio, incapaci di venire a capo delle cose, tra mille fallimenti, precipitati, al punto finale, con un cappio al collo in una radura, rimane in un cassetto di una soffitta di una casa in una valle su un torrente turbinoso un fiore di carta vinto al tirassegno.
Thomas Bernhard, Correzione, trad. italiana di Giovanna Agabio, Adelphi, pp. 304, euro 20.
Leggi anche:
Massimo Marino | Thomas Bernhard: il dolore e la neve
Massimo Marino | Thomas Bernhard: assenze e smascheramenti
Massimo Marino | Il Sessantotto di Thomas Bernhard
Thomas Bernhard | Thomas Bernhard, Una conversazione notturna
Massimo Marino | Thomas Bernhard, Piazza degli eroi