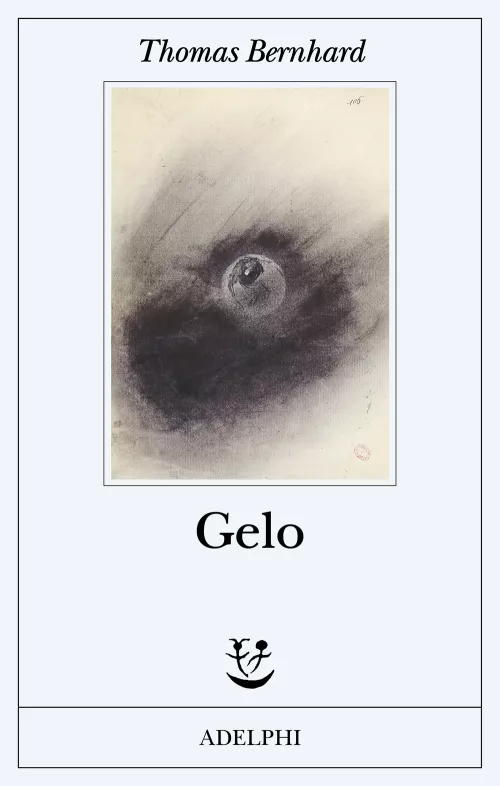Thomas Bernhard: il dolore e la neve
Gelo (Frost) è il primo romanzo di Thomas Bernhard. Scritto a trentuno anni nel 1963, in Italia fu pubblicato da Einaudi nella traduzione di Magda Olivetti nel 1986 e nel 2008. Ora torna presso Adelphi, che sta rieditando tutte le opere del grande scrittore austriaco, nella stessa versione, “riletta” e lievemente variata da Marina Pugliano. Gli interventi sono minimi: la sostituzione dell’epico passato remoto con un più veloce e ‘moderno’ passato prossimo; un’attenta revisione di spazi tra un paragrafo e l’altro e delle virgolette, un lavoro non banale in un testo che, come vedremo, scivola continuamente dalla voce del personaggio principale a quella di chi ne narra lo sprofondare nel disordine mentale.
Del testo, letto la prima volta anni fa, mi rimanevano sensazioni: il freddo estremo di un paesaggio montano invaso dalla neve e quello di un raggelamento dell’anima, tra colori cupi, senza luce, con interni sordidi, come quelli della locanda dalle tonalità ‘kafkiane’ dove alloggiano i protagonisti, un posto sporco, illuminato male, pieno di uomini vocianti. In contrasto con questi sedimenti, la memoria si apriva in passeggiate tra alberi e campi, camminate instancabili, piene di parole, di discorsi, di osservazioni, di deliri, nelle quali si dava fiato alle ossessioni attraverso il movimento continuo delle gambe, della bocca e del pensiero, guardando molto probabilmente alla Montagna magica di Thomas Mann e a Robert Walser.
La rilettura a distanza di una ventina di anni riserva, come spesso avviene, molte sorprese, aprendo nuovi scenari. Con un’osservazione preliminare: siamo lontanissimi dai romanzi di plastica della letteratura odierna, almeno quella nostra nazionale, tutti trama e caratteri da neo-commedia all’italiana, già pronti per la fiction televisiva. Al lettore qui si chiede di abbandonarsi al flusso, e (paradossalmente) di impegnarsi in questo abbandono. Siamo in una storia, in una lingua, una costruzione martellante e ansiogena, che guarda in modo originale a Beckett e all’avanguardia, con una sapienza già straordinariamente matura per uno scrittore alla prima prova. Ci troviamo di fronte a un’opera immersa nei propri tempi, anche letterari, ma assolutamente non invecchiata.
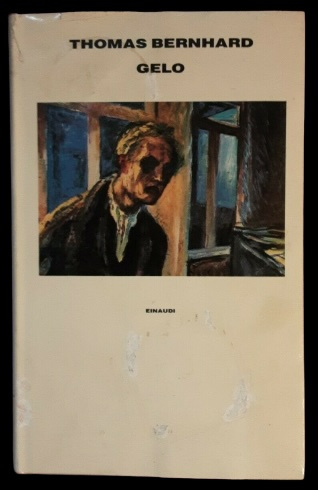
La voce narrante è quella di uno studente di medicina inviato da un suo professore, l’assistente Strauch, a osservare il precipitare verso la follia del fratello, il pittore Strauch. Costui si è ritirato a Weng, un paese in cima a una valle (ma lo sente come se fosse infossato tra pareti rocciose). La premessa del tirocinante mette subito in allerta: “La pratica d’ospedale non serve soltanto a imparare a incidere e a ricucire, a far fasciature e a tenere duro. La pratica d’ospedale deve anche fare i conti con realtà e possibilità extracorporee”. Il compito assegnatogli lo porta tra i frammenti di una personalità, “a esplorare qualcosa d’inesplorabile”, con l’immediato spettro di uno scacco. Il compito sarà svolto dall’osservatore in ventisette giornate, fermate in appunti. Egli si sistema nella stessa locanda dove si è isolato il pittore e subito, presentandosi non come un allievo del fratello ma come studente di legge, intesse con lui un rapporto di confidenza che gli permette di riportarne le parole, in un flusso verbigerante inarrestabile. Spesso la voce di Strauch e quella del narratore scivolano l’una in quella dell’altro, dal discorso diretto a quello indiretto, sovrapponendosi, confondendosi, creando un vero e proprio mondo autonomo dominato dall’ossessione, dal senso del fallimento, del vuoto, dal sogno che si rigetta sulla realtà, dalla realtà che diventa fantasia o che si presenta senza abbellimenti in una sua durezza e bruttezza infame. Il narratore, alla fine, in alcune lettere al dottor Strauch confesserà di non essere capace di articolare una vera relazione sullo stato di salute mentale del fratello; di non riuscire a dare un ordine alla rivelazione di un cervello in preda al caos, all’anarchia, orientato prima verso l’annullamento del sé sociale, avviato a “spedizioni nelle giungle della solitudine”, poi decisamente affascinato dal suicidio.
Strauch, il pittore, ha bruciato i propri quadri, dipinti spesso al buio, con colori opachi, oscuri. Strauch al narratore: “Capisce? La vita è disperazione pura, è la disperazione più chiara, la più oscura e la più cristallina delle disperazioni. Lì dentro ci conduce soltanto un sentiero che attraversa la neve e il ghiaccio, lì dentro nella umana disperazione in cui si è costretti a entrare: al di là dell’adulterio commesso dalla ragione”. Al di là dell’adulterio commesso dalla ragione: una zampata, in quel linguaggio del miocardio in cui si esprime Strauch, simile ai latrati dei cani che lo terrorizzano. “Il mondo attorno a noi è un mondo di cani” e, altrove, “non ci sono che dolori, che tenebre”. In quel paesaggio gelido “il dolore cade sotto forma di neve”: tutto quel bianco non è che una rivelazione dell’inferno.

La prosa di questo primo romanzo, subito salutato dalla critica come una rivelazione geniale, non è ancora quella circolare, labirintica dei grandi testi narrativi di Bernhard: vi agisce piuttosto una frammentarietà spesso stupita, il più delle volte rabbiosa, che descrive bene un mondo che si sta sgretolando. “Come i vecchi la saliva, così il pittore Strauch sputava le sue frasi”. Frost arriva dopo una lunga produzione poetica e dopo alcuni tentativi di romanzi fortemente sperimentali, rifiutati dagli editori. Scritto in sei-sette settimane, su consiglio di un amico redattore della casa editrice Insel, che stava per spostarsi in altro incarico e gli dice di fare presto perché possa intercedere per la pubblicazione, usa una prosa abbastanza ‘regolare’, a differenza di prove precedenti dove l’unico segno di interpunzione era il punto fermo finale (per esempio nel frammento Schwarzach St.Veit). Ma la scrittura esplode nel farsi registrazione senza tentare interpretazioni, anzi rinunciando esplicitamente, con le lettere finali a Strauch medico, all’idea di un’anamnesi coerente.
L’inizio e poi vari punti, in questo sprofondare nel buio, nel gelo, nell’osservare “ciò che di bestiale nell’uomo si annida nel profondo di noi stessi, una bestia con gli artigli tirati che al minimo segno sussulta e lacera”, descrivono anche un ambiente. Il giovane praticante medico arriva in treno in quella valle: in un vagone carico di un’umanità operaia esausta, infreddolita, esalante odori di sudore, povertà e officina, con la traccia di sangue di un uccello schiacciato sotto un finestrino. Siamo all’inizio degli anni Sessanta. Nella valle, dove si trova una vecchia fabbrica di cellulosa, si sta costruendo una diga, una grande impresa, come in quegli stessi anni nel Vajont, ed è forte la sensazione di una natura violentata dallo sviluppo economico postbellico, di una trasformazione dell’habitat non solo naturale ma soprattutto umano. Il denaro guida le vite di piccoli personaggi di contorno, l’ingegnere, l’oste che ha commesso omicidio e giace in prigione, sua moglie, il suo amante ossia il becchino del paese nonché scuoiatore, che sinistramente porta alla donna animali morti, forse da cuocere e ammannire agli avventori. Intorno ululano i cani e i latrati penetrano fino in profondità della psiche del pittore; lacerano, come uno specchio della sua condizione, di reietto, abbandonato dal fratello e dalla vita, autoesiliatosi, in cerca di una sponda, che trova nel nostro narratore, riconoscendosi come commediante, come uno che si mette continuamente in scena, che mette senza sosta in scena il proprio lato più oscuro.
Siamo nel gioco degli specchi continui che portano sempre più lontano da una possibile verità come in tutte le opere di Bernhard, con un tono particolarmente espressionista, condito di cerimonie funebri di paesi, interamente mobilitati intorno ad alcuni morti, tra superficie e profondità, in un gioco di scatole cinesi che come in testi successivi mette a confronto dei fratelli, con rimpianto per un’infanzia felice, soprattutto nel rapporto con un nonno saggio, e un successivo provare ad agire e invece precipitare nella vita, con lavori sentiti come inadeguati, come quello di maestro supplente, figura cui i maestri di ruolo non danno nessun credito e così gli alunni, esponendoli a ingiurie, in un mondo dove le istituzioni poco possono insegnare. E qui nel pittore da giovane viene trasposta in finzione la propria stessa biografia dell’autore, il suo legame con il nonno scrittore raccontato nel volume autobiografico Un bambino.
Nel gran bolo verbale di Strauch entrano la religione, con un Pater noster al contrario: “Padre nostro che sei all’inferno, che non venga santificato nessun nome. Che non venga a noi nessun regno […]”, con il ricordo lontano ma bruciante del nazismo, della guerra e dei suoi orrori, con resti umani, animali, di oggetti che spuntano ogni tanto nei campi a testimoniare un’apocalisse appena passata, con la crudeltà dei mattatoi e di poveri affamati che rubano capi di bestiame e li macellano nei campi, facendoli a pezzi per meglio trasportarli, inondando la neve di sangue. Entra un nichilismo nei confronti della consolazione della letteratura: Strauch si accompagna con i Pensieri di Pascal, che cita come opera di profonda saggezza, imprescindibile, riportando al massimo una mezza frasetta stiracchiata. Il giovane osservatore ha dimenticato a casa un volume sulle malattie del cervello di Koltz e invece ha con sé un volume di Henry James “con cui mi ero già distratto a Schwarzach”, un libro di evasione, che leggerà nei momenti di pausa, spesso senza comprenderne le storie, le parole, un libro ‘da diporto’ di cui non dichiara il titolo (ma James è scrittore di fantasmi e ossessioni).
L’esterno riflette duramente gli squilibri interni dell’anima del pittore, rappresentando mondi che si sgretolano non senza momenti in cui la tragedia si colora di ridicolo. Con un tono avvolgente, come i passi dei due personaggi che affondano in sentieri, che si perdono nella neve, che salgono verso la chiesa, si spingono nel cimitero o si fermano in cerca di ristoro presso un pagliaio. Bernhard qui lo cogliamo un po’ prima del Bernhard più noto, ma è già grandissimo, dubbioso narratore delle esplosioni della psiche tardo novecentesca, maestro nel rappresentare uno sgretolamento e nel far risuonare i propri personaggi uno nell’altro, fino a far risplendere le sue parole, spesso torve, nere, nel lettore, a scavarlo dentro fino al suo fondo più nascosto, estremo e insieme esterno. Potenza e seduzioni già tutte in questo primo ‘fallimento’, come saranno quelli di suoi successivi personaggi impegnati in imprese folli, destinate allo smacco totale.
Strauch, il pittore Strauch, mentre il fratello gode di riscontri e successi presso il consesso scientifico e la buona società, si perderà nella neve: “Ritornato a Schwarzach ho letto sul ‘Demokratisches Volksblatt’: ‘Da giovedì della scorsa settimana tale G. Strauch di W., senza professione, risulta disperso nella regione di Weng. Le operazioni di ricerca, alle quali partecipavano alcuni agenti della gendarmeria, sono state interrotte a causa delle intense nevicate’”. Perso nel gelo della disperazione pura, del grande vuoto esistenziale.
Thomas Bernhard, Gelo, Adelphi, pagine 356, euro 20.