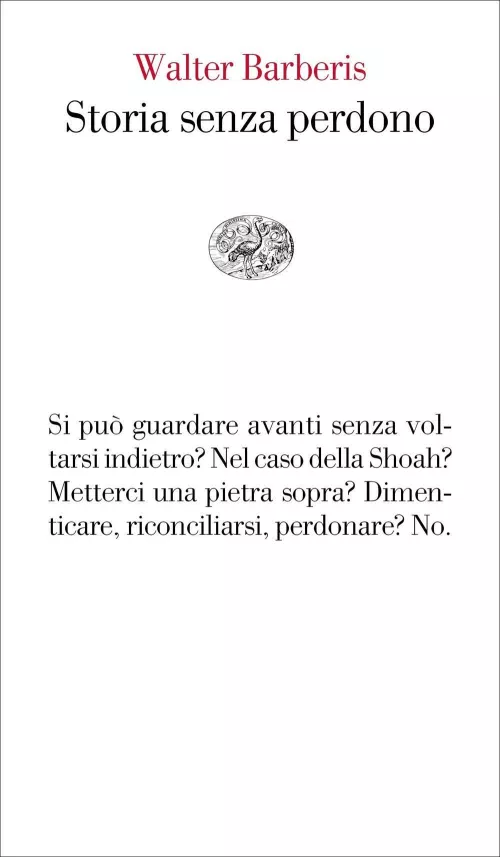Storici e testimoni / Walter Barberis, Storia senza perdono
Storia senza perdono può essere visto come un libro che si occupa di ciò che oggi ci basta di sapere della Shoah. Non solo di quanto, ma soprattutto di come. Più in generale del rapporto tra storia e testimonianza. Qui sta sicuramente il nucleo generativo di questo libro, ma non è qui che sta il nerbo della riflessione che Barberis ci consegna in queste pagine. Se concentrassimo l’attenzione su questo tema, in gran parte fermeremmo la nostra attenzione intorno a un tema importante, indubbiamente, ma laterale.
Storia senza perdono è molto di più. Riguarda la riflessione sul ruolo della storia nel processo del sapere. Ovvero, se noi oggi riconosciamo alla disciplina storica, alle procedure proprie della disciplina (che non è – né esclusivamente, né prevalentemente – narrazione del passato) una funzione formativa. Dunque la storia, il sapere storico, e forse più che la competenza, ovvero la dotazione di strumenti per proporre risposte, la sensibilità storica, ovvero la capacità di farsi delle domande. Ovvero se pensiamo che la storia abbia un ruolo da giocare nella coscienza pubblica o meno. Walter Barberis ritiene che non solo lo abbia, ma che questa sia la vera sfida di questo nostro tempo. Concordo.
Dirlo tuttavia non basta. Occorre capire perché e dove oggi si colloca quella sfida. Storia senza perdono ci aiuta a capire questo percorso. Cerco di illustrare come.
La riflessione sull’utilità della storia, meglio sulla sua indispensabilità, sempre conseguente alla consapevolezza che siamo di fronte a tempi duri, se non a una sconfitta. Talvolta a una sconfitta politica, più spesso a una sconfitta culturale. Comunque, quella riflessione è conseguente alla convinzione se non di sapere certo di vivere, una condizione di marginalità o di irrilevanza.
Non era così per Marc Bloch quando inizia a comporre Apologia della storia? Ma era così anche per Huizinga, quando nonostante il messaggio di fiducia che esprime nel suo Nelle ombre del domani (in Italia più noto con il titolo di La crisi della civiltà e ora riproposto con il suo titolo originale da Aragno editore), affronta il problema di come ritrovare un fondamento alla indagine storica. Scrivo indagine, e non racconto, perché noi oggi abbondiamo di racconto di storia. Ciò che invece non abbiamo a sufficienza, o comunque che sembra avere sempre meno spazio, è l’analisi di fatti, che riguarda anche la complessità dei linguaggi, la capacità di far coabitare sensibilità disciplinari diverse.
Credo che per certi aspetti sia così anche per Walter Barberis, quando imposta e propone tre punti su cui a mio avviso s’incardina questo libro. Da questi tre elementi ne discendono molti altri e si aprono percorsi di indagine e di riflessione di estrema rilevanza e urgenza nella definizione di un sapere storico in grado di candidarsi oggi ad essere un percorso di formazione civile per il cittadino.
Dunque, tre punti.
Il primo: la condizione per produrre conoscenza storica.
Scrive Barberis:
Senza la memoria di chi aveva visto e patito non si sarebbe arrivati da nessuna parte; ma forse anche, con quella sola memoria, non si sarebbe riusciti a far combaciare le tessere del mosaico. Il male ha sempre cause molteplici, persino remote in questo caso, anche se si manifesta con la rapidità e la micidialità di un colpo di fucile. L’occhio non riesce neppure a vedere la traiettoria della pallottola; lo sguardo può fermarsi soltanto sulle conseguenze, sui cadaveri, sulle carni ferite, sulle menti sconvolte di coloro che sono stati colpiti. È la storia, dovrebbe essere la storia, una inchiesta con l’onere della prova, una spiegazione inconfutabile e comunemente accettata da una comunità scientifica e da ogni persona raziocinante, che deve sapersi avvalere delle testimonianze, renderle necessarie, fra loro complementari e dunque significative. [p. 29]
Il tema, dice, Barberis non è più il rapporto tra testimoni e storici, o tra memoria e ricerca storiografica. L’essenzialità e l’imprescindibilità di quel rapporto sono due dati di fatto, e comunque senza testimonianza noi non solo sapremo poco, ma non saremmo neppure in grado di comprendere quali sensibilità la ricerca storica deve mettere nel conto per potere produrre indagine storica, e quale ricostruzione di ambiente, di caratteri, di culture, di mentalità, di senso comune. Tutti questi aspetti agiscono nel corso degli eventi fino a contribuire significativamente alla loro fisionomia, non solo nel momento in cui avvengono, ma anche in quale luogo della memoria singolare, di gruppo, collettiva essi si depositino dopo, nel tempo. Perché è nel modo in cui sono archiviati, e dunque nella gerarchia definita dal punto in cui si fissano nella memoria, che prende forma, nel tempo, ciò che chiamiamo identità.
Ma anche detto questo resta una sfera che è propria della storiografia che non può arrestarsi sulla soglia dell’ascolto e dell’accoglienza del racconto di memoria, e che poi ritorna nel modo in cui si definisce un’opinione pubblica e un nuovo senso comune. Anche perché, e su questo aspetto Barberis ha indubbiamente ragione [p. 38 e p. 50] nell’ambito della memoria noi dobbiamo includere, proprio per capire come sono andate le cose, anche il racconto di chi non è stato vittima: delle istituzioni (per esempio i molti percorsi di azione delle Chiese); della zona grigia; dello spettatore. Ma anche cercare di ascoltare con molta attenzione le memorie dei carnefici.
Nelle versioni dei fatti proposte dai molti soggetti anche internamente a ciascuna categoria, non stanno solo le reticenze, gli accomodamenti o la descrizione di una scena con un occhio di comprensione o di depotenziamento del racconto, ma stanno anche i molti pregiudizi, i molti luoghi comuni che segnano la nostra cultura collettiva. Il tema è come si costruisce un patrimonio culturale, che implica chiedersi che cosa significa ricordare a seconda che si parli di libro a stampa, fotografia, scrittura digitale. Insieme stanno anche le procedure di oblio, che sarebbe errato valutare come cancellazione di passato, come opportunamente ha ricordato recentemente Aleida Assmann nel suo Sette modi di dimenticare.
Tutto questo senza dimenticare anche una diversa questione a cui Barberis accenna sinteticamente nelle ultime pagine del volume, ma che ha acquistato con lo scorrere del tempo una rilevanza sempre più significativa.
Il tema è quello della responsabilità partigiana nelle rappresaglie fasciste seguite agli attentati dei resistenti, un tema che è diventato molto sensibile a partire dalla discussione intorno a Via Rasella aperto nel 1979 da Marco Pannella e poi proseguito sulle pagine di “Questioni radicali” fino al 1980 (con interventi, tra gli altri, di Bobbio, Gianni Baget-Bozzo, Roberto Guiducci, Ernesto Galli Della Loggia, Giorgio Bocca. Il complesso degli interventi è stato raccolto a cura di Angiolo Bandinelli e Valter Vecellio nel volume dal titolo Una «inutile strage»?, Pironti, Roma 1982).
Un tema che non ha esaurito la sua dimensione problematica con il libro di Alessandro Portelli L’ordine è già stato eseguito, ma che anzi è parte dei quella discussione sulla memoria divisa aperta a metà anni ’90 da Giovanni Contini con il suo La memoria divisa (Rizzoli).
Discussione che si presenta su due lati.
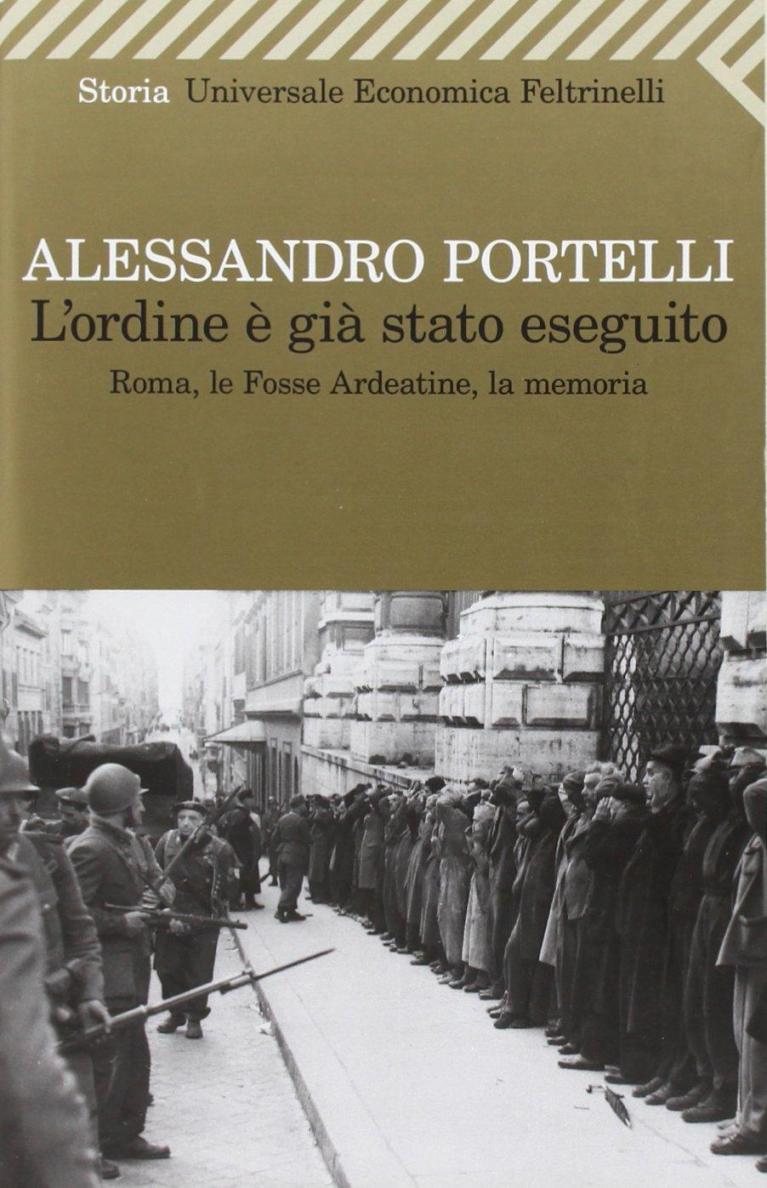
Il primo riguarda la riflessione dei protagonisti attivi di quella vicenda su cui, per quanto riguarda specificamente Via Rasella, è intervenuto uno dei protagonisti Rosario Bentivegna. Questione, tuttavia, che non può essere solo risolta sul piano della memoria, e che riguarda tutta la partita aperta dall’intervento sui processi rivoluzionari in età moderna, il cui paradigma strutturale è dato dalla vicenda dei giacobini sopravvissuti al “Terrore robespierriano” che nel lungo arco della loro esistenza scrivono su e ripensano a quel passato, spesso in maniera tormentato.
Qui si apre il secondo lato del problema, territorio di indagine che riguarda non più solo la memoria, ma i sentimenti che la definiscono e la descrivono e, alla fine, le danno un volto. Tema su cui a mio avviso ha scritto magistralmente Sergio Luzzatto nel suo Il terrore ricordato.
Il problema è quello della violenza come “levatrice di progresso”, ovvero di ciò che rimane della Rivoluzione francese e più in specifico del “Terrore” una volta che lo si riduca alla ghigliottina. E in ogni caso il meccanismo è l’idea che la libertà non si raggiunge senza un prezzo. Il punto è che quella che chiamiamo e identifichiamo come conquista è costata sangue, violenza (esercitata, e molto spesso subita); rischio della propria vita e facendola rischiare, uccidendo i nemici che avrebbero perpetuato l’oppressione e il cui obiettivo, comunque, non era la libertà, e rimanendone uccisi.
Questa condizione evoca una scena già percorsa nella storia moderna: quella propria dei vecchi giacobini che ripensano la loro condizione una volta che sono stati mesi al margine e che nella Francia dell’Ottocento vivono la loro frustrazione di sconfitti, ma anche di «espulsi», circondati da un mondo che rimprovera loro la violenza, e che, contemporaneamente, non è disposto a riconoscere quel legame tra la libertà di cui gode e la violenza che è stata necessaria o non eludibile per tentare di raggiungerla.
Non diversamente, a mio avviso, riprendendo un’eco di quelle pagine di Luzzatto, scrive Barberis:
C’è ancora la sensazione che «un buon uso del tradimento» potesse essere il minore dei mali; e che resistere sia stato un pericolo non solo per chi resisteva, ma anche per chi gli stava attorno. Tradotto in termini meno evasivi: si sarebbe potuto lasciare che gli ebrei venissero deportati verso lo sterminio senza mettere a rischio la pelle e i beni di tanti bravi francesi, o italiani o di altri di qualche altro Paese. Ma questa è proprio una lezione che non possiamo accettare né affidare passivamente ai luoghi. A nessun luogo; neppure ad Auschwitz, che da un lato è diventato negli anni meta di un pellegrinaggio significativo di una «religione civile» universale; dall’altro, con i suoi milioni di visitatori, ormai a rischio di diventare uno dei tanti luoghi «obbligati» del turismo di massa: quello che oggi include, nel pacchetto del viaggio a Cracovia, gli esili resti del campo di sterminio, la miniera di sale di Wieliczka e la Dama con l’ermellino al Castello di Wawel. [p. 65].
Secondo punto: Qual è il ruolo dell’emozione e quale quello della ragione ogni volta che si affronta un percorso di riflessione pubblica intorno ai genocidi e intorno alla Shoah?
Il tema riguarda il rapporto, il patto narrativo, ma anche il contratto civico che si stabilisce tra testimoni e pubblico. Scrive Barberis:
Nel momento in cui una generazione consegnava alle successive il racconto della Shoah e si predisponeva a un cambio della guardia contro gli assassini della memoria e i cospiratori del silenzio, la modalità del racconto assumeva non di rado una forma problematica. In effetti, l’elemento dominante di quei richiami e di quelle lezioni era l’orrore. (…). Con gli anni, ma rapidamente adesso, si andava stabilendo un patto narrativo fra il testimone e il suo pubblico. L’uno e gli altri non potevano deludersi vicendevolmente. [pp. 33-34]
E conclude:
Ora, se da un lato è del tutto normale che un tocco retorico, l’incorporazione nel proprio di ricordi altrui, un particolare aggiunto o tolto, siano ingredienti di un racconto che possa e debba suscitare l’interesse dell’ascoltatore, è purtroppo altrettanto vero che quelle modifiche rendono spesso piú ardua la comprensione del fatto in questione. Le contraddizioni tra queste forme di trasmissione di una morale sono forse inevitabili; ma la diagnosi di una malattia mortale non può che essere quanto piú vicina possibile all’esattezza, sfrondata da ogni orpello decorativo. Ne va della giusta efficacia della cura. Per combattere la battaglia dei giusti e per proteggere le giovani generazioni da germi letali, oltre una palpitante emozione, c’è bisogno di tanta ragione. [pp.34-35; il corsivo è mio].
Ci sono molte questioni che si affollano in questo passaggio tanto sintetico, quanto profondo e problematico.
Provo a indicarne almeno due.
La prima riguarda la dimensione dell’emozione.
Intorno al ruolo fondamentale dell’emozione nel ripercorrere le vicende delle persecuzioni e dei genocidi che quelle persecuzioni precedono e accompagnano, Gunter Anders molti anni fa aveva insistito a proposito dell’efficacia e della pertinenza dell’operazione culturale del serial Holocaust.
All’uscita di Holocaust sugli schermi televisivi in Europa (in Germania nel gennaio 1979, in Francia e in Italia nella primavera dello stesso anno) la reazione fu molto contrastata. Claude Lanzmann, per esempio, giudicò che in quella fiction ci fossero molte ambiguità: il fatto che essa collocasse un evento in un passato che non aveva relazione col presente; il fatto che lo relativizzasse; il fatto, infine, che non ci fosse percezione della violenza, del degrado fisico dei protagonisti, i cui corpi non compaiono segnati dalla “discesa” verso la morte. Insomma, un prodotto hollywoodiano che falsificava la storia. Anders invece valutò che la struttura della narrazione dove al centro stanno le persone e non figure emblematiche, dove in breve stanno le vite concrete, fosse una scelta efficace per riaprire un ragionamento a lungo rimasto asettico.
È una indicazione corretta, anche se a mio avviso lascia scoperti e tace di altri dati che credo Barberis richiami implicitamente quando scrive che “c’è bisogno di tanta ragione”.
Qui sta la seconda questione di merito sul rapporto emozione/ragione. Dentro a questa esortazione a ben vedere sta anche un profilo del ruolo degli storici. Perché se è vero che in Germania il richiamo proposto da Holocaust ebbe effetto, occorreva poi che la discussione entrasse nella “carne viva” e questo avvenne anni dopo nel confronto tra Jürgen Habermas ed Ernst Nolte. È in quella discussione che lo sterminio diviene un elemento essenziale della riflessione pubblica in Germania, pur non essendo mai stato negato prima.
Lo stesso accade in Italia.
Quel percorso si aprirà solo in forza dell’azione culturale di un gruppo di ventenni che si combina con l’intelligenza operativa di un grande operatore culturale come Nazzareno Pisauri, a lungo direttore dell'Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna. Quando a Bologna nell’autunno 1994 è inaugurata la mostra La menzogna della razza, la questione dell’antisemitismo torna nell’agenda culturale pubblica del nostro Paese. La forza di quell’iniziativa consisteva nel proporre una lettura di “lunga durata”, ovvero la necessità di eliminare la questione delle leggi razziali come “parentesi nella storia italiana”, mettendo come tema al centro della questione i percorsi emotivi, culturali, sociali, politici che hanno dato un volto, tra Ottocento e Novecento, a noi italiani contemporanei.
Quell’iniziativa poneva anche il duplice problema dell’uso pubblico della storia e dell’uso politico del passato. È questa una storia che attende ancora il suo storico (o meglio un gruppo di competenti composto da molte e diverse sensibilità disciplinari) in grado di leggere le molte forme del documento contemporaneo, ossia delle fonti che concorrono a vario titolo e su molti supporti a costruire un’opinione e a dare immaginario ai segni (parole, immagini, …) che costituiscono il nostro vocabolario culturale analizzandone la genesi, le molte vie che percorrono per giungere a noi, la loro metamorfosi per spiegare come rimangono dentro di noi. Un’operazione che rovescia lo sguardo passato/presente, per proporre un percorso di indagine storica che parte dal presente, cerca di comprendere il percorso genealogico nel passato e poi torna a vedere e a tentare di mettere a fuoco i molti percorsi nel presente che quel lascito del passato propone o indica come operativi.
Una procedura che chiama in causa un processo di Public History che non è solo, né prevalentemente divulgazione, bensì, e soprattutto, consapevolezza che la narrazione della storia e lo scavo nel passato oggi chiedono contemporaneamente un’attenzione alle forme della narrazione e una competenza da parte degli storici che in Italia sono ancora altamente deficitarie.
Il primo passo da fare quando si parla di riflessione civile della storia è sapere come si classificano i fatti, con quali parole si indicano gli eventi e come si risponde, ovvero a quali risorse culturali e anche operative si ricorre per trovare soluzioni alle emergenze cui dover far fronte.
Tutti temi e snodi che il nostro tempo propone. La risposta continua ad essere latitante, incerta, al più celebrativa. La memoria al futuro chiede risposte diverse, capaci di assumersi la responsabilità al presente e del presente.
Qui si apre il terzo e ultimo punto che sta a cuore a Walter Barberis: che cosa sia la partita aperta oggi su questi temi.
Quando parliamo della Shoah, dice Barberis, stiamo parlando di un tempo finito e di una dinamica singolare irripetibile o stiamo riflettendo su un fenomeno che può, in varie forme, ripresentarsi? Insomma, scrive Barberis:
Se quello è stato un episodio terribile, ma in sé concluso, allora possiamo tenere le testimonianze in un contenitore delle memorie, in una modalità «conservativa», senza chiedere loro di darci più di quanto ci abbiano già dato in passato.
Se, viceversa, riteniamo – o una buona indagine storiografica ci induce a credere – che quella storia, per quanto eccezionale, sia ancora pericolosamente aperta, allora dobbiamo fare in modo che le testimonianze di quel tempo rimangano in una modalità «attiva»; concorrano, cioè, a rifornirci di una conoscenza e di una razionalità che ci consentano di mantenere vive le ragioni della democrazia contro ogni tentazione autoritaria, intollerante e razzista. [p. 37]
Come si intraprende quel percorso?
Per tanti anni abbiamo pensato che fosse sufficiente leggere una frase di Levi, un testo di Brecht, una poesia. Oggi, per capire il percorso di disperazione e un vissuto conflittuale dobbiamo seguire un diverso percorso. Dobbiamo capire cosa accade nella testa di un ragazzo quando vede Bastardi senza gloria, o farlo riflettere su un film come L’onda. Non raccontare il totalitarismo, ma farlo confrontare con una storia come quella del film, che lo mette davanti al fenomeno concreto. Quelle scene parleranno a un adolescente meglio di un qualsiasi testo teorico. E dopo, forse, gli faranno venire voglia di scavare, di leggere, di saperne di più.
La «Generazione Doppio Zero», va a cercare le immagini sul web. Dalle parole che lì incontra, dalle immagini che salva e porta con sé fissandole in un qualsiasi supporto con cui comunica, giungerà alla carta, alle parole su carta.
Gran parte delle forme di costruzione della coscienza pubblica oggi passano per il viaggio di memoria o, più distesamente, il viaggio nei luoghi dove si è fatta la storia del nostro tempo, che si configura come un modo per riprendere il senso del rapporto col passato.
È sufficiente andare in un luogo? Probabilmente no. Comunque, dipende dagli esercizi di memoria e di attivazione di processi di memoria che avvengono o sono attivati all’interno di quella cornice.
Il nucleo mi sembra consista soprattutto nel metodo:
- intelligenza emotiva – riprendendo suggestioni di Daniel Goleman su emozioni e percezioni;
- elaborazione di storie dove contano le storie individuali;
- criteri in cui si produce riflessione di storia, lavorando alla costruzione di un processo di coinvolgimento emozionale, informato, e conseguente necessità di osservare la grande storia attraverso molte microstorie.
I luoghi non sono solo i luoghi del più tradizionale viaggio di memoria (ovvero verso Auschwitz) ma anche i luoghi caldi dello scontro tra memorie e storia nel corso del ‘900, dove il problema della guerra, per esempio, è quello del confronto aspro tra memorie, tra guerre di e per la memoria e di memorie di guerra in conflitto. Per esempio: Balcani, Sarajevo, Berlino, il fronte italiano sul Carso, l’Adriatico. Senza dimenticare Trieste: non è forse in nome della guerra di memoria che si è inaugurata una statua a Gabriele D’Annunzio a Trieste lo scorso 12 settembre? E io mi chiedo: se a quella memoria si è così affezionati, che cosa si farà il prossimo 13 luglio 2020, ancora a Trieste, a cento anni esatti dall’incendio del Narodni Dom? E soprattutto cosa si collocherà al centro di quell’atto di memoria: il rogo della cultura o chi la incendiò?.
In prospettiva se il tema è dato dagli elementi dove si è decisa con snodi la storia d’Europa, in questo filone è facile intravedere che saranno non solo i luoghi di sterminio, ma anche quelli di confine a costituire i punti sensibili da cui provare a raccontare la storia d’Europa. Forse non sarebbe sbagliato provare a riprendere le suggestioni che Lucien Febvre nel lontano 1928 provava a proporre con il suo Frontière: étude de vocabulaire historique. Comunque non sarebbe sbagliato introdurre nella nostra cultura generale la geografia intendendola come geografia economica, culturale, sociale, e non solo fisica o politica.
A cominciare dai muri, che non sono finiti e tramontati a Berlino, 30 anni fa, ma sono risorti, come ha suggerito Claude Quétel nel suo Muri. Un’altra storia fatta dagli uomini
I muri di oggi sono destinati ad avere un futuro, più che essere un residuo del passato: non più segno della vergogna o dell’offesa, ma della tutela. Per questo, all’ordine del giorno non c’è l’abbattimento di muri, ma il loro consolidamento. Perfino la costruzione di nuovi. In ogni caso la loro abolizione non è più una priorità. Magari teorizzando che ognuno ha diritto al suo muro.
Non è questa la conseguenza dell’ossessione verso la società multiculturale e non interculturale? Ovvero: una condizione che propone spazi per tutti, ma senza contaminarsi. Coabitando, ma senza mescolarsi. Ciascuno “a casa sua”.
È un tema rilevante che modifica radicalmente l’approccio consuetudinario al tema delle discriminazioni e che forse ci obbliga a riconsiderare da un diverso punto di vista quella scena fatta di ghetti, discriminazioni, marcatura delle differenze, fino alla tutela protettiva garantita da una numerazione e registrazione dei paria. Da qui la necessità sia di un diverso punto di vista, sia di una diversa modalità d’indagine volta a uno scavo sugli eventi che non sia solo finalizzata a raccontare ciò che avvenne, ma di nuovo colga il processo. In breve, la macchina delle molte figure che agiscono per la realizzazione di quell’obiettivo.
E allora non è forse vero che occorre trovare un nuovo spazio per l’esperienza dell’analisi e non più solo della narrazione, delle modalità di trattenere memoria, di costruire percorsi di ricerca di storia? In breve: riconoscere il limite, e non solo le potenzialità, dello storytelling?
Walter Barberis, Storia senza perdono, Einaudi 2019, pp. 96 € 12,00