Vienna mon amour
Vienna, discorso infinito, discorso incompiuto, aperto. Ora Franco Cardini, con la sua autorità di storico emerito, prosegue sulle le ali della cultura e della passione narrativa a raccontare – dopo Praga – dell’altra grande città, della capitale dell’Impero: Vienna. Forse l’unica capitale di un impero inteso come una compagine plurisecolare, di tante comunità etniche, linguistiche e religiose. Non lo fu mai Berlino, rocciosa capitale della Prussia. La Vienna di Cardini come suggerisce il sottotitolo: A passo leggero nella storia (Il Mulino) è una meravigliosa, colta ed erudita passeggiata per i luoghi di Vienna, per i tempi di Vienna, dall’antichità fino a Hundertwasser con le sue case sghembe. Nella storia, così ben raccontata da Cardini, non sempre il passo fu leggero, anzi talvolta assai pesante, come confessò, nella sua biografia degli anni giovanili, Mein Leben (La mia vita) circa un secolo fa un giovane provinciale trasferitosi nella capitale imperiale in cerca di fortuna. In realtà voleva essere ammesso all’Accademia delle Belle Arti, ma purtroppo per lui e per l’umanità fu bocciato due volte. Senza mezzi, frustrato, amareggiato, la città gli si trasformò in un incubo e rapidamente trovò il colpevole: «Fu così che venni a Vienna.
Gonfio delle impressioni ricevute dai miei studi architettonici, schiacciato dal peso del mio destino personale, non ebbi nei primi tempi la possibilità di guardare più da vicino le varie stratificazioni che compongono la popolazione della gigantesca città… La mia pratica esperienza delle strade di Vienna mi rese servizi indicibili. Era venuto il momento in cui io non mi aggiravo più come un cieco nella grande città, ma guardavo con occhi aperti non soltanto i palazzi, ma anche gli uomini. E una volta che mi aggiravo nelle vie del centro, capitai improvvisamente su un personaggio dal lungo kaftan e dai riccioli neri. Anche costui un ebreo? Fu il mio primo pensiero. Certo, gli ebrei di Linz non gli rassomigliavano affatto. Io osservai quell’uomo in modo furtivo e attento, ma quanto più lungamento fissavo quel viso straniero esaminandolo, tratto per tratto, tanto più si trasformava nel mio cervello la prima domanda in una tedesca: è costui un tedesco?...
Dovunque io andassi, non vedevo che ebrei, e quanto più ne vedevo, tanto più essi si distinguevano dagli altri mortali. Specialmente il centro della città e i quartieri a nord del canale rigurgitavano di un popolo che già nell’aspetto non aveva alcuno contatto con quello tedesco». Era prima della Grande Guerra, il giovane era Adolf Hitler che venne traumatizzato da quei poveri ebrei orientali che riparavano dai pogrom in atto nella Russia zarista a Vienna, in maggioranza con l’aspettativa di proseguire per l’America. Per lui furono anni di fame e ristrettezze economiche, umiliazioni, pernottamenti in dormitori pubblici: «Vienna, la città che a molti sembra l’ideale della gioia innocente, la residenza della gente felice, rappresenta per me il ricordo vivente del tempo più triste della mia vita. Ancor oggi questa città risveglia in me soltanto grigi pensieri. Il suo nome solo evoca, per me, cinque anni di miseria e di desolazione». Quelli furono i suoi anni di formazione – o deformazione-politica e sociale, di iniziazione all’antisemitismo militante.
Vienna era anche questa immensa miseria, comune a tante altre metropoli, come ricorda Rilke di Parigi nei Quaderni di Malte Laurids Brigge o Hauptmann, il drammaturgo del naturalismo nei suoi primi drammi berlinesi. Ma Vienna era anche, proprio in quegli stessi anni, la capitale della più intensa stagione pittorica e architettonica mitteleuropea da Klimt a Egon Schiele, da Robert Gerstl a Kokoschka, da Otto Wagner al suo allievo Joseph Maria Olbricht che progettò il palazzo della Sezession che fa esclamare a Cardini il sorprendente paradosso: «Dici Vienna e ti sorprendi a riflettere che (Dio ti perdoni!) daresti entrambe le cupole del Brunelleschi e di Michelangelo messe insieme in cambio di quella di foglie d’alloro in bronzo dorato – il Goldenes Krauthappel, ‘cavolo d’oro’ come lo chiamano i viennesi zotici». Molta ironia toscana. E se traversi qualche strada già ti trovi nella Vienna dei caffè: dal 2011 l’Unesco ha riconosciuto il Wiener Kaffeehaus – il caffè viennese – “patrimonio culturale immateriale”. Sono quasi tutti vicini, nel primo distretto, dal Café Central nel Palazzo Ferstel, ai due caffè ‘intellettuali’: Café Hawelka e il Bräunerhof, raffigurati con magistrale sarcasmo e improvviso affetto da Thomas Bernhard in Il nipote di Wittgenstein e in A colpi d’ascia (entrambi per Adelphi). E quando non ne poteva più dei suoi colleghi scrittori si rifugiava dove meno ce lo saremmo aspettato: al Café Sacher. Oppure al Café Eiles, quello così provvisto di spazi, scacchi e giornali fissati sulle celebri aste di legno, mentre Ingeborg Bachmann, appena sbarcata a Vienna dal deep south austriaco, dalla Carinzia, preferiva il signorile Café Landtmann di fronte all’Università, accanto al Burgtheater oppure, alla fine della guerra, il Café Raimund, che frequentava insieme a quel profugo della Bucovina, Paul Celan, l’amore folle e disperato della vita. I dolci più buoni del mondo sono al Café Demel. Il caffè è ancora centro di socializzazione, d’intrattenimenti e di civiltà letteraria.
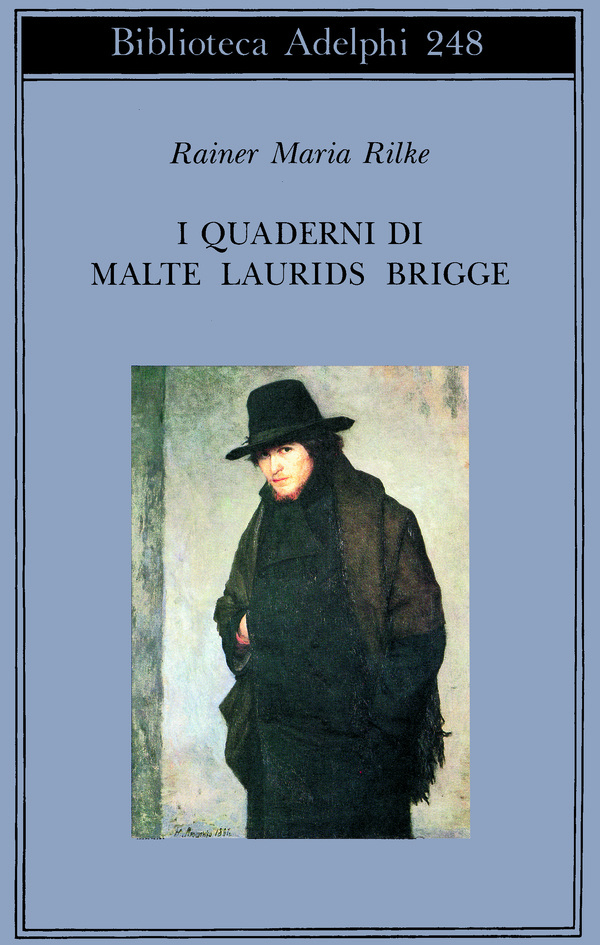
Sulla Letteratura al Café ha curato un numero monografico di «Cultura Tedesca» Micaela Latini. Insomma, nulla di più viennese del caffè. Ma fin da un certo momento. All’origine c’è infatti l’autentica stranezza che i preziosi chicchi li lasciarono i nemici storici: i turchi, a dimostrazione che non sempre il nemico è così nemico: nel 1683 i turchi, che assediavano la città, furono messi in fuga dall’audace cavalleria polacca del Re Jan Sobieski. Nella ritirata abbandonarono migliaia di sacchi con quei favolosi chicchi di caffè e qualche ‘cafferiere’ lavorandoci sopra inventò la Melange (una specie di cappuccino): il “rio caffè” turco addolcito da panna liquida, ecco la specialità viennese. Ma l’innesto nella cultura avvenne verso la fine del secolo d’oro della cultura austriaca. L’esempio più maturo è raggiunto nel 1790 con Così fan tutte di Mozart con libretto di Lorenzo Da Ponte. Nella didascalia della prima scena si avverte che l’azione prende le mosse da una “bottega di caffè”, ma non a Vienna, bensì (giustamente) a Napoli. Con Da Ponte e con Mozart la cultura austriaca raggiunge il suo apice culturale e internazionale. In questi mesi sta uscendo un’opera gigantesca in cinque corposi volumi di Lorenzo della Cha, Lorenzo da Ponte e il suo tempo – per le coraggiose Edizioni di Scienza e Letteratura – sulla vita avventurosissima di Lorenzo da Ponte (1749-1838), che si chiamava Emanuele Conegliano almeno fino ai tredici anni quando suo padre per amore di una diciassettenne cristiana si convertì insieme ai suoi tre figli; il maggiore assunse, come era d’uso, il nome del battezzatore, il vescovo Lorenzo Da Ponte vescovo di Ceneda, che oggi si chiama (guarda un po’) Vittorio Veneto. L’opera attentissima di della Cha è un affresco immenso della cultura italiana, viennese, francese, inglese e americana attraversate dall’abate libertino. E sì perché Lorenzo era alquanto vivace: divenne prete senza vocazione, ma con grande inclinazione al gioco e alle donne.
Per un certo periodo, trasferitosi a Venezia, compagno di Casanova, visse in un bordello luogo non certo raccomandabile per un abate, che, capita l’antifona, si trasferì a Vienna, che per certi aspetti era la capitale ‘italiana’ della musica lirica. E della Cha nel secondo volume del suo monumento dapontiano, che resterà nella saggistica più qualificata di questi anni, descrive con una copiosa ricchezza di dettagli che cosa era mai la Vienna italiana almeno fino alla Rivoluzione Francese, che coincise con la morte di Giuseppe II, seguita nel dicembre 1791 da quella di Mozart. Con il successore al trono Da Ponte proprio non s’intese, se ne andò a Praga, dove riabbracciò Casanova, poi a Dresda, che già si profilava come attivo centro musicale, ma quegli anni di guerre e rivoluzioni poco si adattavano al suo estro, si trasferì per una decina d’anni a Londra al King’s Theatre per finire gloriosamente la sua carriera a New York, primo insegnante di letteratura italiana alla Columbia e fondatore del Teatro Italiano, dove assunse persino Piero Maroncelli, carbonaro e patriota. Del resto per tutta la vita la massoneria stese la sua mano protettrice sull’abate libertino nonché ingegnoso come dimostrarono i suoi intramontabili libretti: Le nozze di Figaro del 1786, il Don Giovanni del 1787 e Così fan tutte del 1790.
Da Ponte era arrivato a Vienna con una lettera di raccomandazioni per Antonio Salieri – di cui della Cha fornisce un equilibratissimo ritratto, in quella Vienna dove il poeta cesareo era Metastasio. A Vienna si recò persino il papa con l’intenzione di placare le irruenti riforme illuministiche di Giuseppe II. Insomma nel 1782 a Vienna Pio VI s’intrattenne ancora con Metastasio (che morì in quell’anno) e con i musicisti e librettisti italiani. Il progetto dell’Imperatore di incrementare il Singspiel tedesco – una specie di antecedente del musical – naufragò e il sovrano era troppo intelligente e aperto alle arti per non approvare la svolta italiana durante il suo regno; sicché Vienna divenne la capitale della cultura musicale, anche se poi Da Ponte era di Ceneda, Salieri lombardo, Metastasio romano, Gluck bavarese, Mozart di Salisburgo. Con la Rivoluzione, anzi con la reazione, l’egemonia svanì e per almeno un secolo Vienna visse di eredità finché a cavallo tra l’Otto e il Novecento sorse una nuova generazione di artisti: pittori, architetti, urbanisti e poeti, tra cui Hofmannsthal, ma anche Schnitzler, Musil: era lo Jungwien, la cultura della Vienna di fine secolo, che si sviluppa sulla simbiosi ebraico-tedesca fino all’annessione dell’Austria al Terzo Reich, quando, nel 1938, quella cultura venne distrutta dalla follia nazionalsocialista.
Vienna dopo la guerra seppe ancora esprimere una straordinaria stagione letteraria con Ingeborg Bachmann (che però lasciò presto Vienna e l’Austria) e Bernhard che amò-odiò, come nessun altro prima, Vienna: «E intanto correvo lungo le strade di Vienna come fuggendo da un incubo, correvo, correvo sempre più velocemente verso il centro della città… e pensavo, durante la corsa, che questa città che stavo traversando, per tremenda che mi sembrasse adesso come in passato, era la città migliore per me, che questa Vienna che odiavo e ho sempre odiato era adesso tutt’a un tratto la città migliore, … che Vienna la odio ma Vienna è commovente … e mentre correvo, correvo, giunto ormai nel centro della città, pensavo che questa città è comunque la mia città». Una struggente dichiarazione d’amore, l’unica che Bernhard poteva strappare a sé stesso correndo verso quella che è (così si chiude A colpi d’ascia) la sua intenzione: scrivere: «pensavo, immediatamente scriverò qualcosa … immediatamente, continuavo a pensare, e intanto attraversavo di corsa il centro della città, subito e immediatamente e subito e subito, prima che sia troppo tardi». Così Vienna rivela se stessa come la città della scrittura, dell’arte (sperando che non sia troppo tardi).









