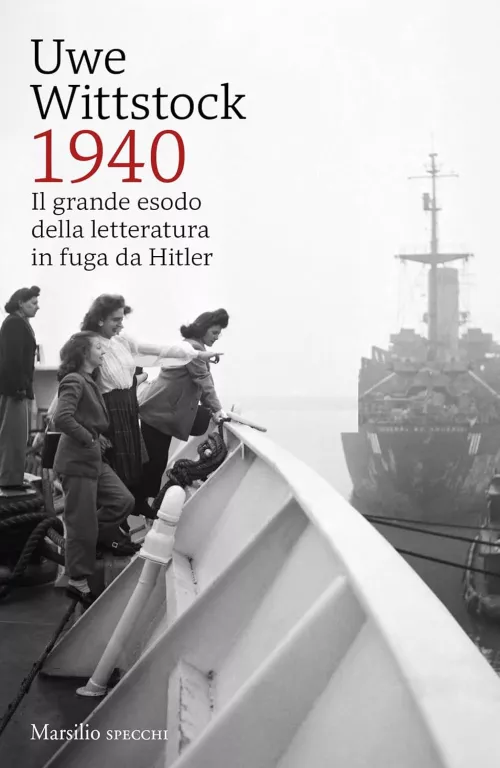La cultura in fuga da Hitler
Heldenplatz, Piazza degli Eroi, l’ultimo dramma di Thomas Bernhard, non ha perso nulla della sua attualità: Hitler era entrato a Vienna e il 15 marzo del 1938 tenne, proprio a Heldenplatz, a Piazza degli Eroi, di fronte a una adunata oceanica un discorso memorabile: «Posso annunciare oggi dinanzi alla storia l’evento più importante della mia vita: l’Austria è tornata a casa nel Reich…».
Cinquant’anni dopo l’Anschluß, l’annessione, il 4 novembre 1988, al Burgtheater, il dramma di Bernhard prima dello spettacolo venne volgarmente contestato. Il pubblico in teatro lo acclamò, ma, nonostante il successo, lo scrittore ne fu così amareggiato da vietare che le sue opere teatrali venissero in futuro rappresentate in Austria. Con quel dramma metteva in scena la maledizione della memoria: un esule, il professor Josef Schuster, eminente scienziato emigrato a Oxford (figura ispirata a Wittgenstein, così caro a Bernhard), si lascia convincere di tornare a Vienna, a casa sua, a Piazza degli Eroi. Ma viene improvvisamente perseguitato da quelle indimenticabili voci inneggianti il Führer, che comincia a udire di nuovo dentro di sé: quelle voci erano risuonate in quella piazza, in quel lontano marzo: voci brutali, fanatiche, scalmanate di acclamazione per il Führer. Schuster, non reggendo la tensione, si suicida, sua moglie decide di vendere tutto e fuggire da quell’incubo senza fine. Ma le voci non tacciono, continuano a torturare gli innocenti, le vittime. Quello che viene messo in scena al Burgtheater nel 1988 era una tragedia epocale, che lacera ancora la storia dell’Austria. Quelle voci non tacevano più, non si poteva dimenticare quella folla osannante il Führer, quella benedizione delle croci uncinate da parte del cardinale di Vienna Theodor Innitzer, quella persecuzione violenta, spietata degli ebrei, che erano la linfa vitale della cultura mitteleuropea, da Freud a Wittgenstein, da Schnitzler a Svevo, Kafka, Mahler, Schönberg.

Hitler, il provinciale di Braunau, ripetutamente bocciato all’esame di ammissione all’Accademia viennese delle Arti, non amò mai Vienna, dove in gioventù era stato umiliato e mortificato, si vendicò subito: l’Austria perse persino il nome: non più ÖSTERREICH, il “regno d’oriente”, ma Ostmark, la marca orientale E non fu certo solo una questiona nominalistica, come ricorda nelle sue splendide, ironiche, dolcissime e terribili memorie Hertha Pauli, Lo strappo del tempo nel mio cuore, ora pubblicate dalla lombardoveneta Palingenia in un’edizione particolarmente elegante, tradotte da Enrico Arosio, corredate da fotografie d’epoca. E da autentica viennese Hertha (1906-1973) fa cominciare le sue memorie davanti un Melange (caffè con panna liquida) in un caffè – lo Herrenhof nella Herrengasse (purtroppo non c’è più) – in una data crudele: l’11 marzo 1938 quando Hitler comunicò l’intenzione di ‘liberare’ l’Austria dal legittimo governo austriaco alla vigilia del referendum che avrebbe rafforzato l’adesione degli austriaci alla loro indipendenza. Nell’incontro a Berchtesgaden di qualche giorno prima il Führer aveva convocato il cancelliere austriaco Schuschnigg costringendolo ad accettare le sue condizioni: un governo con nazisti ai posti chiave, nonché l’amnistia per gli assassini del precedente cancelliere Dollfuss. Schuschnigg – in un abito assai elegante (ma abbiamo appreso di recente che con certi tipi il vestito conta poco), fu costretto ad accettare il diktat, ma si trattava solo di un preliminare. A Berlino avevano capito quale sarebbe stato l’esito della votazione, convocata per domenica 13 marzo. Si stava a sorpresa delineando un plebiscito a favore della piccola repubblica alpina con la parola d’ordine ripetuta ovunque: “Rot-weiss-rot bis in den Tod!”, “rosso-bianco-rosso [i colori della bandiera austriaca] fino alla morte”. E così lo vietarono inviando, per essere più convincenti, l’esercito del Reich per sedare supposti tumulti cruenti che per altro non si verificarono. Ingeborg Bachmann ricorda la marcia delle truppe germaniche a Klagenfurt come la fine dell’età d’oro dell’adolescenza, il vulnus di una vita e la discesa di un popolo nelle tenebre della storia. Hertha Pauli d’origine ebraica comprende subito la tragica gravità della situazione e fugge, via Zurigo, a Parigi.
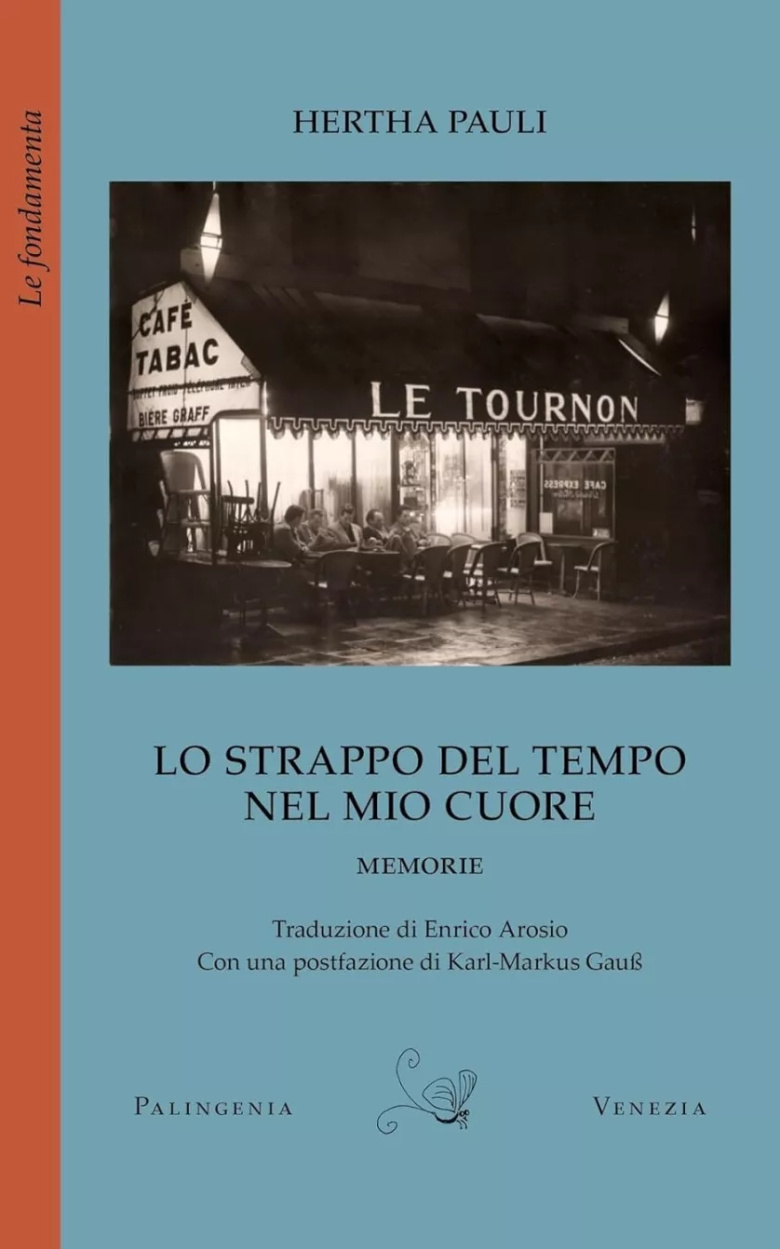
A Zurigo Hertha non incontra il fratello Wolfgang, anche lui esule, premio Nobel per la fisica, (famoso per il suo dialogo con Carl Gustav Jung sulla sincronicità) che era in quei giorni a Cambridge. Siamo nel marzo del 1938. Non le resta che proseguire il viaggio per Parigi prima dell’annunciata chiusura delle frontiere. La capitale francese era ormai il luogo prescelto dalla maggioranza dei profughi dal Reich e dall’Austria. Il Café Tournon era il punto d’incontro preferito intorno a Joseph Roth. Ma la situazione – come era prevedibile – precipitò nel 1940, anzi più esattamente nel giugno di quell’anno con l’inatteso sfondamento tedesco del fronte e l’invasione rapida, incontenibile delle armate del Reich, con la disfatta dell’esercito anglo-francese a Dunkerque (e la vergognosa dichiarazione di guerra del 10 giugno di Mussolini alla Francia). Di nuovo un esodo rievocato nelle sue memorie da Hertha come pure dai resoconti di Varian Fry, l’americano che, sostenuto da Eleanor Roosevelt, la moglie del presidente, tentò di salvare il più possibile di esuli, come ricorda Uwe Wittstock in 1940 Il grande esodo della letteratura in fuga da Hitler (Marsilio). Wittstock si era già confrontato, con fortuna editoriale, con Febbraio 1933 con questo genere di racconto legato alla cronaca di un anno fatale per la storia d’Europa.
I due racconti – quello di Fry e di Pauli – si integrano a vicenda, ricostruendo una stagione drammatica della storia della letteratura tedesca quando i principali scrittori – ma anche musicisti e pittori – abbandonarono il continente per trasferirsi negli USA: «L’America –scrive Hertha – era diventata ormai da un pezzo la terra dei miei sogni e desideri». E l’America li accolse con generosità, che fu ricompensata con l’impegno di intellettuali e artisti mitteleuropei decisivo per il decollo della cultura e delle università americane. Conviene ricordarci sempre di questa pagina della nostra storia occidentale, radicata nella nostra comunità transatlantica. E quel 1940 resta una data decisiva con immense tragedie di popoli e di uomini: in quei mesi di fuga e di morte si suicidarono Ernst Weiss, il romanziere amico di Kafka, Walter Hasenclever, il protagonista della drammaturgia espressionista, Walter Benjamin, l’intellettuale geniale della Scuola di Francoforte, e uomini e donne senza nome che segnarono la condanna spirituale della Germania. Wittstock rievoca le gesta veramente straordinarie di quel giovane giornalista americano: laureato a Harvard, Varian Fry (1907-1967), con ostinazione, quasi con ingenuità si era proposto di salvare duecento scrittori e scrittrici celebri dalla Francia di Vichy, quel torso di stato frettolosamente messo su dal maresciallo Pétain, che intendeva salvare il salvabile con esiti disastrosi. Sia le memorie di Hertha sia le relazioni di Fry, raccolte da Wittstock, danno un’idea di una Francia incerta, disorientata, spesso favorevole agli esuli, anche se sempre più impaurita dall’invadenza criminale della Gestapo che aveva le sue liste e i suoi implacabili metodi di eliminazione. In una visita a Berlino nell’anteguerra Fry era stato testimone delle crudeltà naziste: a differenza della maggioranza dei suoi concittadini, aveva compreso tutta la gravità della situazione.

Per questo prolungò il suo soggiorno a Marsiglia previsto di un mese a più di un anno. Lavorando in semi-clandestinità, sfruttò tutte le scarse risorse finanziarie e diplomatiche di cui disponeva, scoprendo vie di salvezza, utilizzando spesso con i suoi collaboratori, con i suoi passeurs, i percorsi dei contrabbandieri per attraversare i Pirenei e per giungere in Spagna e poi a Lisbona e finalmente negli USA. Certo, talvolta si incappava in una burocrazia ostile e ottusa, ma il più delle volte i francesi capivano e aiutavano anche a rischio della repressione tedesca e in quella disponibilità già s’intravede la nascita della Résistance. De Gaulle era già a Londra a organizzare il suo movimento per una “France libre”. Intanto Fry era riuscito a salvare numerosi esuli – tra i più famosi della cultura del Novecento, come Hannah Arendt, André Breton, Marc Chagall, Marcel Duchamp, Max Ernst, Lion Feuchtwanger, Leonhard Frank, Fritz Kahn, Siegfred Kracauer, Konrad Heiden, Wanda Landowska, Heinrich e Golo Mann, Walter Mehring, Soma Morgenstern, Hans Natonek, Hertha Pauli, Alfred Polgar, Hans Sahl, Anna Seghers, Alma e Franz Werfel.
Tornato in America, Fry venne di fatto emarginato, perfino allontanato dall’organizzazione che aveva collaborato a creare: la Emergency Rescue Committee. Dopo la guerra naufragarono i suoi tentativi di riallacciarsi a quell’esperienza avventurosa del 1940, coinvolgendo invano alcuni degli esuli che a lui dovevano la salvezza. Per Fry furono anni oscuri, alla fine lavorò come pubblicitario (perfino per la Coca-Cola). Nell’anno della sua morte gli fu conferita postuma la Légion d’honneur, più tardi la cittadinanza onorifica dello Stato d’Israele: la sua straordinaria opera umanitaria venne riconosciuta solo recentemente. Oggi gli è dedicata una strada al centro di Berlino e una piazza di fronte al consolato americano di Marsiglia, mentre una dignitosa serie Netflix, Transatlantic del 2023, rievoca quella stagione di salvataggi, di drammi, e di sconsideratezza giovanile, che talvolta sconfinava nell’eroismo. E talvolta, sempre più spesso, quelle voci del 1938 della Piazza degli Eroi tornano a farsi udire. Nella pièce di Thomas Bernhard il protagonista constata con amarezza: «Ci sono più nazisti oggi che nel 1938». E allora, nel 1988, l’estrema destra non era ancora il partito più votato dagli austriaci che oggi sfiora il 29% dei votanti. Così quelle voci diventano sempre più insistenti, minacciose, da Vienna a Berlino, talvolta, di recente, raggiungono persino l’altra sponda dell’Atlantico.